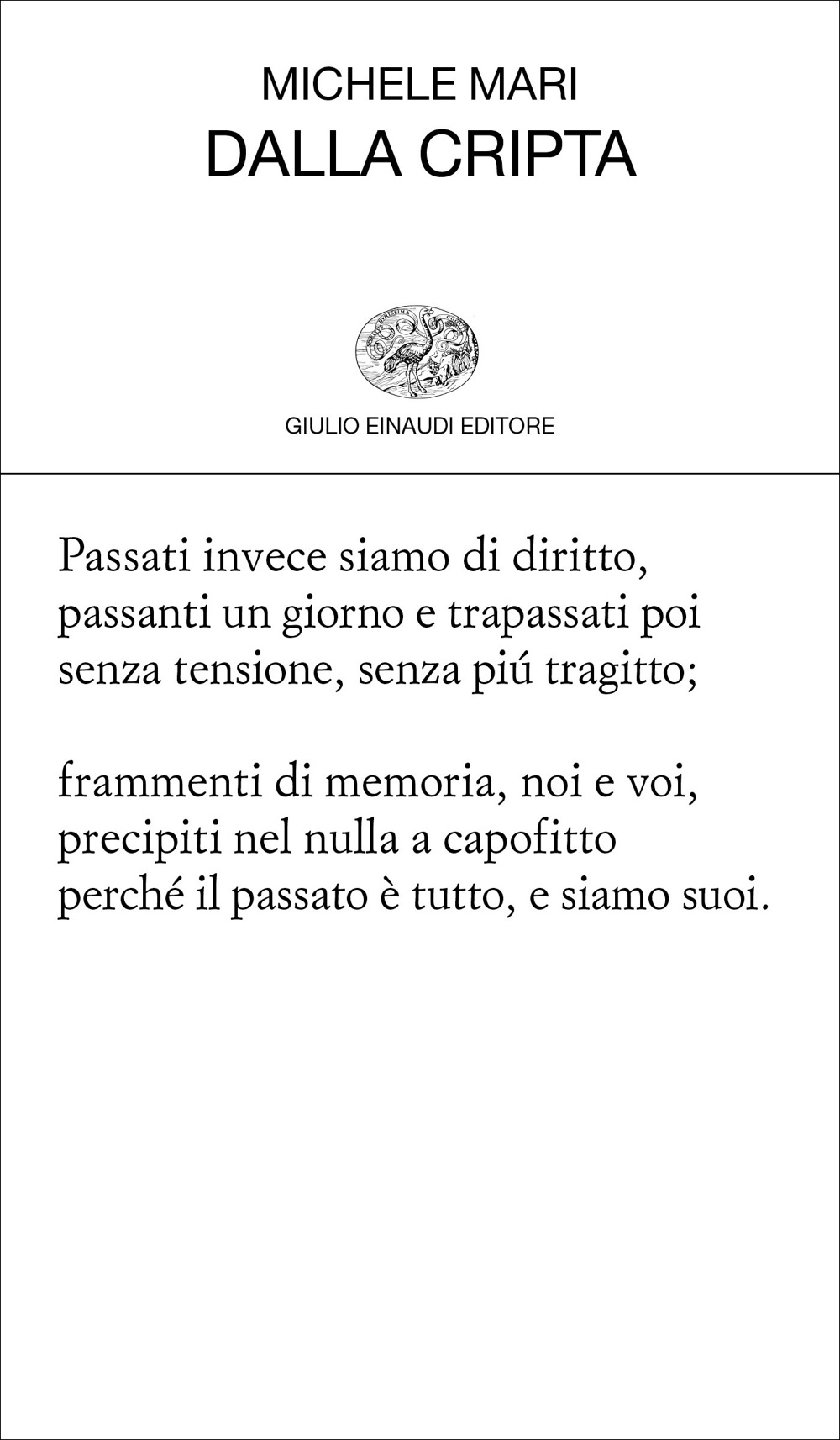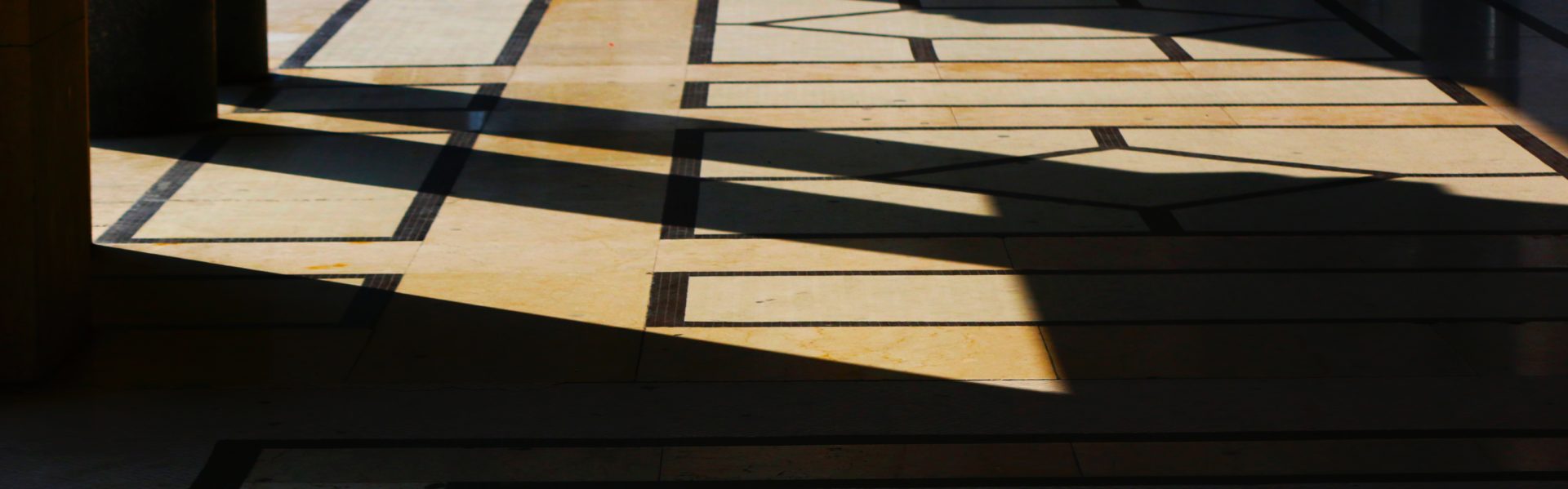Michele Mari è nato romanziere, è cresciuto romanziere e morirà romanziere – complesso e barocco, per giunta. Per questo, ha sempre considerato le sue Cento poesie d’amore a Ladyhawke (Einaudi, 2007), quell’unicum in versi così estraneo rispetto alla sua produzione “classica” e così insta-friendly nella brevità dei suoi componimenti; il suo libro peggiore, una sorta di errore di percorso che non si sarebbe mai dovuto ripetere una seconda volta. E invece.
Invece l’errore, dodici anni dopo, si è ripetuto: e per fortuna, aggiungiamo io e il folto gruppo di lettori che consideravano la pubblicazione di quell’atipico canzoniere amoroso postmoderno, racconto in versi di una storia sentimentale a lungo sospirata, lambita e infine mai concretizzata, tutto tranne che un errore.
A febbraio è uscito infatti, sempre nella Bianca Einaudi, Dalla cripta (2019), nuova e più che mai inaspettata raccolta di poesie di Mari. È difficile dire cosa abbia fatto cambiare idea allo scrittore milanese: l’impressione è che il libro sia nato da una richiesta/imposizione dell’editore, visto che le Cento poesie sono ancora oggi – ironia della sorte – il libro di Mari che vende di più e grazie a cui il suo autore è maggiormente conosciuto al grande pubblico. A novembre 2018 si sono festeggiate in casa editrice le 30.000 copie vendute, numero altissimo per un libro di poesie e pressoché impensabile per un poeta contemporaneo.

Ma forse di motivo ce n’è anche un altro: molto probabilmente a Mari andava stretto il ruolo di poeta amoroso neo-epigrammatico, amato da stuoli di ragazzine sospiranti, condiviso ossessivamente sui social e regalato per San Valentino insieme ai Baci Perugina. Forse desiderava costruirsi anche in versi l’immagine dell’autore orgogliosamente inattuale, stilizzato, anti-moderno che emerge dalla sua produzione in prosa. Dalla cripta, nella sua strutturazione, conferma entrambi i possibili motivi. Intanto il libro non è né “nuovo” né omogeneo: raccoglie infatti testi di forme ed epoche diverse, scritti in un arco che va dal 1973 al 2017 (con un picco negli anni ‘80) e alcuni già pubblicati precedentemente in altre occasioni, ad esempio incastonati dentro un racconto -i fedelissimi di Mari ricorderanno bene il Lamento di Gianciotto Malatesta e i due sonetti “redazionali” dello pseudo-Angiolieri in Fantasmagonia). Ma quel che salta subito all’occhio è la forma di questi componimenti: più che leggere un autore contemporaneo, sembra di compiere un’escursione a tappe lungo l’intero arco della storia letteraria italiana, da Cavalcanti a Tasso, da Foscolo a Leopardi, passando per Monti.
Eccola, l’inattualità di Mari, ed ecco la diga che l’autore erge tra sé e Ladyhawke. Se nelle Cento poesie la poesia era quotidiana (molti di quei testi erano in origine e-mail), rapida, fruibile e marchiata a fuoco dall’esperienza reale, in Dalla cripta la versificazione si fa ostica, secolare, refrattaria alla vita e germinante direttamente dalla letteratura. Tutte le poesie in Dalla cripta nascono dentro la gabbia costrittiva di una forma metrica codificata dalla tradizione (ci sono sonetti, sestine, quartine di settenari…), appartengono a un genere specifico (il libro è diviso in sezioni quali Rime amorose, Esercitazioni comiche, Scherzi, Versi d’occasione) e sono immancabilmente scritte “alla maniera di”: forse mai come in questo libro Mari ha portato a conseguenze così estreme il vampirismo stilistico che è da sempre la cifra peculiare della sua carriera. Ci sarebbero insomma tutti gli ingredienti, direbbe qualcuno, per concludere che questa raccolta è un puro e semplice esercizio di stile, un’operazione editoriale passatista ed inutile.
Chi è giunta a questa conclusione è ad esempio Laideanfossi, nickname di una ragazza che, mantenendo l’anonimato, gestisce la pagina Instagram dedicata alla poesia più seguita in Italia, con ben 60.000 followers. Laideanfossi, che fa uno splendido e meritevole lavoro di divulgazione poetica, ha criticato Dalla cripta sostenendo che -cerco qui di riassumere- una poesia di questo tipo, desueta e manierista, è dannosa perché non parla al cuore dei lettori; allontana il pubblico dalla poesia invece di attirarlo; è troppo “facile” nel suo imitare gli stili, tanto che anche lei -arriva a dire la misteriosa cultrice- sarebbe stata capace di scriverne di simili.
Ora, analizzando oppositivamente il pensiero di Laideanfossi credo si possa cogliere il valore delle “esercitazioni poetiche” di Michele Mari. Innanzitutto, penso che lei, come chiunque altro, non sarebbe stata in grado di scrivere poesie ad un tale livello di mimetismo stilistico: semplicemente perché non c’è autore in Italia che sia imbevuto di letteratura fin nelle fibre più intime quanto lo è Mari, e che come lui abbia letteralmente sacrificato la vita sull’altare della letteratura – il suo dono e la sua condanna. Queste poesie, questi falsi d’autore a prima vista quasi indistinguibili dagli originali trecenteschi o settecenteschi, nate per scherzo o per diletto e fuoriuscite quasi spontaneamente dalla penna del loro creatore, sono in realtà la testimonianza più naturale di una vita divorata dalla letteratura, di un singolare ultracorpo in cui all’esistenza si sono sostituite le pagine, gli stilemi, i topoi. E sono, in questo, un contrappunto poetico ad un discorso in prosa che va avanti fin dal primo romanzo di Mari, Di bestia in bestia (1989), da quando Osmoc denunciò la scissione definitiva vita/letteratura pronunciando in punto di morte, come parole estreme, degli assurdi ringraziamenti filologici quali si possono trovare in fondo alla bibliografia di un trattato erudito, in una scena di tragicamente straziante.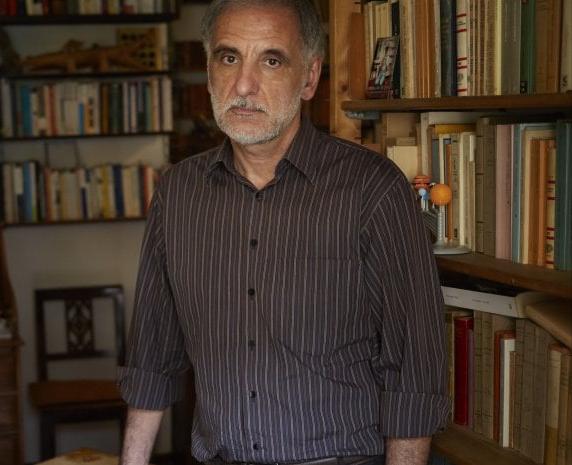
Il manierismo di Dalla cripta, dunque, come espressione naturale di una vita rubata dalla letteratura; ma il manierismo anche come orgoglio, ribellione, originalità. “Manierismo”, si sa, è un termine che nasce nelle arti figurative con una connotazione negativa, perché emerge da un’epoca in cui, ovviamente, manieristi lo erano tutti. Ma in un’epoca come la nostra, in cui la tradizione non è più un sentiero da percorrere per forza, in cui la poesia è esplosa e si è aperta a tutte le forme e sperimentazioni possibili (e meno male, lungi da me dire che sia una deriva negativa), pubblicare un libro manierista come Dalla cripta è un atto di originalità. Chi oggi osa più cimentarsi con le forme metriche tradizionali? Mi viene in mente solo la grande Patrizia Valduga, poi il deserto. Ma mentre la Valduga reinventa le forme e le piega ai suoi scopi e al suo dettato doloroso-erotico, Mari aderisce ai suoi modelli in tutto e per tutto, non solo nella forma ma anche nel lessico e negli argomenti: è un replicante che ci ricorda, orgogliosamente, che gli auctores esistono ancora, che possono essere frequentati, e che chi come lui li ha frequentati in modo così viscerale non può fare altro che ri-dirli. Dalla cripta sembra ammonirci sul fatto che la poesia non debba subito “arrivare”, e non sia obbligata ad aprire la porta e srotolare il tappeto rosso al lettore, ma che l’arrivo giunga alla fine di un lungo tragitto, una lunga stratificazione di secoli e parole sul palinsesto della tradizione, che richiede consapevolezza e dedizione.
Sarebbe ingiusto e riduttivo, però, concludere che dentro i versi di Dalla cripta scorra solo il sangue della tradizione e non ci sia nulla della poetica e dello stile di Michele Mari: al contrario, il lettore affezionato ne troverà ovunque testimonianze. Ad esempio, il gusto per la descrizione esagerata, grottesca e barocca al tempo stesso e divertentissima nel contrasto tra materia triviale e stilizzazione aulica (che troviamo negli eccessi di Rondini sul filo o di alcuni racconti), si ritrova in tutte le Esercitazioni comiche – tra le meglio riuscite del libro, scritte sul modello della poesia oscena comico-realistica, tra sesso orale (A sturalavandino è la sua bocca / esperta in succiolare i peggior cazzi […] Guatala ben quando il pompino accocca: / marcia di sughi agli angoli in gran guazzi / e circondata intorno da pelazzi / in cosa differisce da una gnocca?) e fluidi mestruali (Il salvaslip che serve a la tua sorca / se tuttodì secerne oscena bava / ch’in guisa d’una gromma afrobatava / s’incolla a la mutanda, o brutta porca?).
Oppure si ritrova il topos della misantropia letteraria, tanto caro allo scrittore milanese (Altra ed altera la mia Emma cresca, / poiché la massa è solo noia e ambascia); o il gusto dell’apocrifo (una poesia è significativamente intitolata “Giacomo Leopardi, Al Balturino”) o ancora il dissidio tra istinto (violento) e ragione, gli Osac e Osmoc di Di bestia in bestia (e maledir sol posso la coscienza / che ogni piacer mi nega di violenza).
Ma soprattutto è presente, in alcune poesie che raggiungono l’apice della raccolta (in particolare i sei sonetti che compongono Ghirlanda), il tema principe della poetica di Mari: il passato e la memoria, soprattutto di quell’infanzia “sanguinosa” che ci ha determinati e a cui apparterremo per sempre. Passati invece siamo di diritto, / passanti un giorno e trapassati poi / senza tensione, senza più tragitto; // frammenti di memoria, noi e voi, / precipiti nel nulla a capofitto / perché il passato è tutto, e siamo suoi: in due terzine, un distillato puro della letteratura di Michele Mari.
In Dalla cripta, dunque, Mari c’è eccome. E insieme c’è una tradizione che rivive riplasmata, c’è il divertimento dell’oscenità e la profondità della riflessione, c’è una maestria e una facilità di scrittura ventriloquiale introvabile altrove, c’è il debito di un uomo verso il demone che gli ha salvato e distrutto la vita: la letteratura. Forse è un’operazione editoriale, forse sono solo esercizi di stile. Ma ce ne fossero.