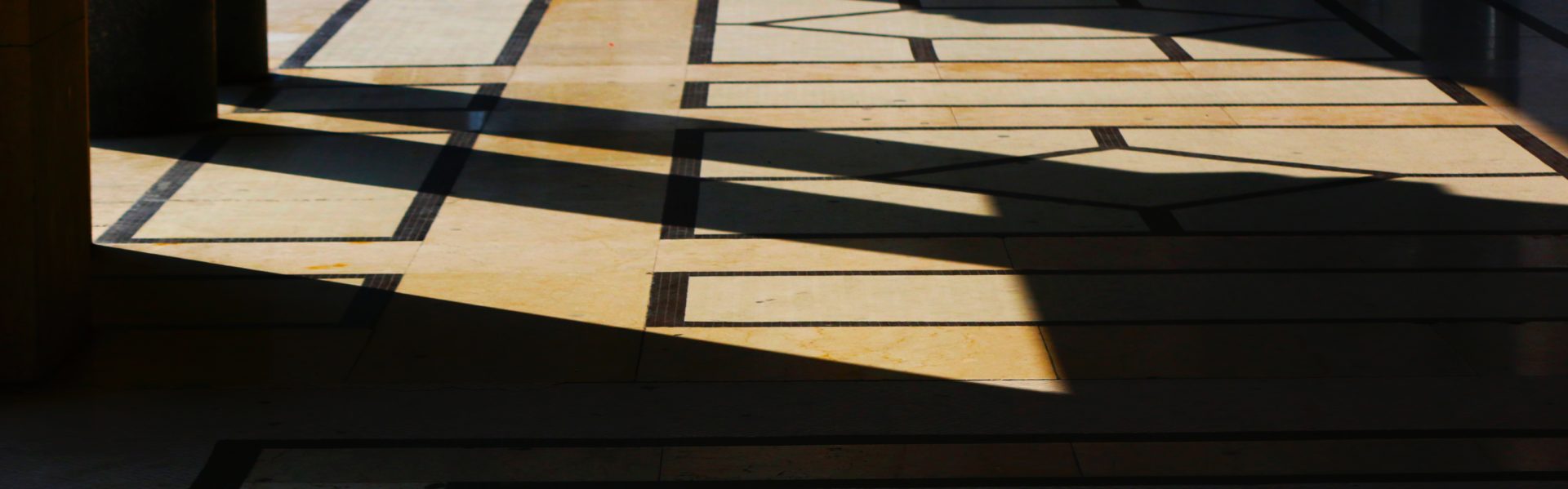Kutaisi, 8 luglio
Il volo diretto Milano-Kutaisi arriva all’una del mattino, quando la città dorme. Dei venti chilometri che separano l’aeroporto dalle prime case non si riesce a vedere quasi nulla a causa della poca luce che gettano gli sporadici lampioni sulla via.
Terry ed io arriviamo in ostello verso le due meno un quarto. I proprietari stanno dormendo, ma ci hanno detto per mail che ci avrebbero fatto trovare le chiavi in una casetta per cani nel giardino- «but don’t worry, there is no dog». Cercando con le torce dei telefonini troviamo la cuccia e vediamo che l’entrata è bloccata da un pannello di legno, tenuto fermo con dei mattoni. Leggermente scombussolati- sarà una precauzione contro i ladri?- spostiamo mattoni e pannello per cercare le chiavi, quando ecco spuntare dall’apertura due cuccioli di gatto (avranno meno di un mese) che con gli occhi ancora chiusi dal sonno annusano e si sporgono verso l’esterno per uscire. Completamente interdetto passo a Terry i gattini, perché li tenga in bracco mentre cerco comunque a tastoni le chiavi nella casetta. Queste, come immaginiamo, però non ci sono e allora rimettiamo dentro i gatti e li richiudiamo con pannello e mattoni nella cuccia.
Non sappiamo ancora come entrare e restiamo qualche minuto seduti in mezzo al giardino, cercando ovunque le chiavi e parlottando fra di noi in cerca di una soluzione. Improvvisamente la porta si apre e una voce minacciosa ci chiede «Ehi! Who are you? What are you doing?». Mi avvicino e spiego alla bene e meglio (sono sempre le due del mattino) in inglese che siamo due ospiti, che avevamo avvisato che saremmo arrivati tardi e ci era stato detto che avremmo trovato le chiavi nella cuccia del cane, ma…
«Ah, siete i due italiani!» risponde l’altro, in perfetto italiano «vi ho scritto un messaggio in cui vi dicevo che vi avremmo aspettati svegli. Facciamo compagnia a un gruppo di tedeschi che aspetta il taxi ora per l’aeroporto… Non vi è arrivato?»
«Non abbiamo più acceso il 4G da Milano» risponde Terry
«Certo, certo. Entrate pure allora, solo toglietevi le scarpe prima di entrare. Comunque io sono Riccardo.»
Appena entrati in casa, Riccardo si gira di scatto preoccupato verso di noi.
«Ah, avete detto che avete cercato nella cuccia…?»
«Non ti preoccupare, abbiamo richiuso i gatti dentro.»
«Ohh, perfetto.» risponde sollevato.
Kutaisi, 9 luglio
Siamo pronti a iniziare a scoprire la Georgia, a farcene una prima impressione. In realtà non so se si possa parlare di prima impressione; su questo paese ho già letto molto e so cosa aspettarmi, a grandi linee. Prima di partire, infatti, ho vivisezionato la guida Lonely Planet –“Georgia, Armenia e Azerbaigian”- e quella Polaris – una casa editrice italiana (che consiglio caldamente) con sede a Faenza, in provincia di Ravenna, specializzata in viaggi e geografia, le cui guide, meno dettagliate di quelle LP riguardo a sistemazioni per vitto e alloggi, hanno però il merito di gettare appieno il lettore nell’anima del posto descritto, raccontandone usi costumi e luoghi di interesse come in un romanzo. Oltre a queste ho letto “Storia della Georgia. Dalle origini ad oggi” e “Georgia. Il paese che Dio voleva per sé” di Francesco Trecci, due libri piuttosto corti che illustrano in modo sintetico ma approfondito la storia e le regioni di questa nazione. A questi ho aggiunto poi la lettura di “Imperium” di Ryszard Kapuscinski, “La terra del vello d’oro” di Wojciech Gorecki e la rilettura dei capitoli sulla Georgia di “Buonanotte, signor Lenin” di Tiziano Terzani: reportages (il secondo dedicato esclusivamente alla Georgia, gli altri due all’Unione Sovietica in generale) di tre grandi giornalisti capaci come nessun altro di cogliere le sottili correnti sotterranee che animano un popolo e una terra.
Usciamo la mattina presto diretti verso il centro città, inizialmente senza una meta precisa ma con la semplice voglia di scoprirla. Kutaisi è uno dei centri urbani più antichi del mondo, tanto che forse proprio di lei scrive Apollonio Rodio quando parla della capitale del regno della Colchide, una magnifica città fondata già nel secondo millennio a.C. Proprio qui dunque si dice Giasone abbia ottenuto il vello d’oro dal re Eeta (Aiety) grazie ai sortilegi di Medea, la bella figlia del re innamoratasi di lui. Il nucleo della Kutaisi attuale ha però origini relativamente più recenti; fu fondata nel VI secolo a.C. e assunse grande prestigio solo un millennio e mezzo più tardi, quando nel 978 d.C. il re Bagrat III la scelse come capitale della Georgia unificata.
Di un tale nobile passato non si scorge molto passeggiando per le vie asfaltate di Kutaisi, dove macchine di oltre vent’anni sfrecciano confusamente, i fili elettrici scoperti si ammassano e disegnano ragnatele sulle teste dei passanti, circondati dai muri scrostati delle case e dai cani randagi alla ricerca di cibo, mentre le bottegaie con scope di saggina spazzano pazienti la piccola porzione di strada davanti al loro negozio.
A ricordare il glorioso passato della città c’è la fontana della Colchide, il primo monumento in cui Terry ed io ci imbattiamo, quasi per caso. Le vie strette e strette, infatti, ad un certo punto si aprono in uno spiazzo gigantesco, piazza Agmashenebeli, tonda, con la parte più esterna dedicata alla circolazione delle macchine, come una rotonda a quadrupla. Al centro si staglia la fontana, imponente. Rotonda come la piazza, quest’opera, costruita negli ultimi anni, è composta da tante piattaforme circolari di mosaico blu poste su vari livelli e fra cui passa l’acqua. Su ogni piattaforma sono posizionate figure dorate di diversi animali; in quella più alta, ad esempio, posta al centro in modo da donare alla composizione un effetto piramidale, si trova la rappresentazione di due cavalli completamente bardati, che per la loro magnificenza attraggono tutta l’attenzione del passante. «Queste 30 figure», spiega un passante con cui stiamo conversando in un mix di inglese stentato (il suo) e russo altrettanto stentato (quello di Terry, dal momento che il mio è inesistente) «sono la riproduzione in scala monumentale di gioielli d’oro ritrovati nell’antica Colchide e ora custoditi in un museo di Tbilisi».
Rimaniamo un attimo a guardare le figure, cercando per alcuni minuti di capire di che animali si trattino. Terry cerca di fotografare tutta la fontana ma per farlo deve posizionarsi nella parte più esterna dalla piazza, dove circolano le macchine, anche se poche a quest’ora del mattino. Si mette nel punto prescelto, prepara lo scatto, scappa in fretta per non farsi investire e ripete il tutto un paio di volte, ma alla fine ottiene la foto. Ora possiamo andare, in direzione di Gelati, un complesso monastico a 7 km dalla città.
La breve strada che ci separa dal complesso ci mostra in nuce quanto troveremo nell’intero nostro viaggio. In Georgia, non appena terminano le ultime case delle città, la natura selvaggia del Caucaso riprende arrogantemente il dominio del territorio. Se si esclude la striscia di asfalto che fa da strada, e i pochi edifici ai lati – fattorie soprattutto, qualche negozio di alimentari e un hotel-ristorante -, molto distanziati l’uno dall’altro, non si trova altro che boschi verdi, attraverso cui il taxi sfreccia veloce. Solo vicino al monastero si incontra un nucleo abitato, ma si ha sempre l’impressione di essere in campagna più che nell’hinterland della terza città per grandezza del paese. Le case sono grandi e iniziano a sentire il peso dell’età, soprattutto grazie ai lavori di ristrutturazione casalinghi, come l’uso di nastro isolante per impedire che le tegole del tetto cadano, fil di ferro per tenere fermo un canaletto di scolo, per citarne solo alcuni, che regalano a questi villini, nati come prefabbricati uguali, un aspetto diverso l’uno dall’altro. Attorno alle case, poi, grandi giardini, orti e aree di pascolo per le mucche, che, nonostante gli ampi spazi a loro dedicati, preferiscono inspiegabilmente passare la loro giornata sull’asfalto della strada, obbligando l’autista a grandi inchiodate. Insieme alle mucche, presenza costante della Georgia rurale, i cani, non solo randagi, come nelle città, ma anche cani-pastore che custodiscono gelosamente la mandria e abbaiano rabbiosi alle auto che vi passano accanto.
Il complesso di Gelati si trova a metà di una montagnola a Nord di Kutaisi. È composto da sette edifici, fra chiese e torri campanarie, dai tetti in tegola color verde brillante. Li attraversa una piccola stradina in pietra che dall’ingresso Est, attraverso cui tutti entrano, conduce alla porta Sud, dove si è fatto seppellire il re Davit IV di Georgia, detto “il costruttore”, che volle la fondazione di questo luogo nel 1106. Il sovrano ordinò che la sua tomba fosse posta proprio all’ingresso del complesso in un atto di estrema umiltà: tutti coloro che fossero entrati nel monastero l’avrebbero così calpestato, come se fosse stato l’ultimo dei sudditi. Ovviamente, ciò non accadde mai. Per secoli i Georgiani fecero attenzione a non calpestare il luogo del riposo eterno del loro sovrano, tanto che l’ingresso cadde in disuso e l’entrata secondaria, quella orientale, divenne il principale. Ora un cartello in diverse lingue e un nastro segnalano l’area; per i turisti più distratti o irrispettosi c’è poi una beghina che silenziosa passa per il monastero, tutta vestita di nero, scruta i passanti e li rimprovera al minimo fallo, scaccia gli onnipresenti cani randagi e getta fiori sulla tomba del sovrano.
Appena sopra la porta Sud vi è un immobile basso e lungo, dove presumibilmente alloggiano i tanti monaci che ancora vivono qui. Siccome gli altri edifici sono chiese o torri, immagino che quel caseggiato sia il luogo in cui hanno risieduto nei secoli gli accademici, non solo filosofi e teologi, ma anche scienziati, che nel medioevo resero Gelati un importante centro culturale, tanto da essere considerato dai contemporanei una nuova Atene o una seconda Gerusalemme. Oggi i monaci sembrano lontani anni luce da quello spirito. Tutti con barbe poco curate e vestiti con lunghe tuniche nere, passano il giorno bivaccando per il sito, intrattenendo ogni tanto i turisti con due parole in inglese, ma più spesso chiacchierando con gli operai che si occupano del restauro dell’area. È in ristrutturazione, infatti, la chiesa principale del complesso, ovvero la Cattedrale della Vergine. Posta al centro, è larga e alta più del doppio degli altri edifici e si può vedere già dalla strada, qualche chilometro prima di arrivare al sito.
A Gelati entriamo in una georgiana, la prima di tante, tantissime. Sono tutte molto simili fra loro, con lo stesso schema e minime varianti l’una dall’altra. A una sola navata, si aprono con un piccolo spazio quadrato dove solitamente si trova un monaco, una beghina o un custode che vende candele o altri oggetti religiosi, come immagini dei santi, icone o rosari, e controlla che tutti i turisti che entrano siano vestiti in modo appropriato, indicando a chi non lo fosse un sacco contente grembiuli da indossare durante la permanenza nel luogo sacro. In questo piccolo ingresso si trovano poi, appesi ai muri o alle colonne, tantissimi quadri di santi in chiaro stile bizantino, elemento peculiare e curioso della chiesa georgiana dal momento che questa non è ortodossa. I religiosi sono ritratti frontalmente, senza ornamenti, e i colori dominanti sono l’oro dell’aureola, della cornice e di molti dettagli, e le tinte pastello, soprattutto l’azzurro e un rosso tenue. I quadri sono solitamente piuttosto moderni e di poco valore; quelli antichi, di epoca medievale, se non precedente, sono infatti stati trafugati durante l’epoca sovietica dai membri del partito che, in nome della laicità dello stato, hanno rubato tutto quanto potevano dalle chiese, lasciandole come gusci vuoti. Ai muri, affreschi della vita di Cristo o dei Santi, ritratti della Madonna e altre scene religiose, in cui dominano gli stessi colori dei quadri. Qui, infine, in molte chiese georgiane (non in quelle di Gelati però) si trova uno scranno sempre vuoto, di cui non mi sono tuttora chiari la funzione o il significato.
Dopo questa sezione iniziale, bassa e poco luminosa, facendo pochi passi si arriva nella zona centrale, posta prima dell’area finale, riservata al sacerdote dove, come nelle nostre chiese d’altronde, non è possibile entrare. In tale area il soffitto, in corrispondenza del campanile della chiesa, si alza e dalle finestre filtra la luce solare. Anche qui abbondano quadri e affreschi e questi ultimi arrivano a coprire la cupola. Si passa perciò da una zona buia e colma di oggetti a uno spazio più ampio, illuminato e meno claustrofobico, il che lascia nel visitatore e nel fedele un senso di liberazione. Sembra quasi rappresentare simbolicamente il viaggio di un’anima che abbandona il peso della vita terrena e si rivolge al cielo, o quello di un uomo che dopo una vita di errori scopre la grandezza di Dio. Non so se sia questa l’idea alla base dell’architettura di tali chiese, ma è quanto ho provato ogni volta che sono entrato dentro una di esse.
Così si struttura un buon 90% delle chiese georgiane. La cattedrale della Vergine, però, ai lati della parte centrale, ha ancora quattro stanze – due per lato – in cui è possibile entrare attraverso due piccole porticine. A sinistra i locali sono uguali a quelli che si sono appena lasciati, con gli stessi colori, le stesse colonne e gli stessi affreschi sui muri, di fronte a cui si apre una piccola cappella semicircolare dove paramenti sacri e ulteriori affreschi sono illuminati solo da una minuscola finestrella. Qui una suggestiva oscurità regna su tutto, obbligando l’occhio a sforzarsi per cogliere le forme. Quando si entra nelle due stanze a destra sembra invece di fare un salto nel tempo. Le pareti affrescate sono bianche e scrostate e dei disegni originali si colgono solo poche macchie azzurre e gialle. È facile immaginare che anche queste due sale a breve verranno baroccamente riempite di scuri affreschi come le altre, non appena vi giungeranno i lavori di restauro. Un vero peccato, perché solo qui abbiamo colto appieno tutta la suggestiva vecchiaia e la sacralità dell’edificio.
Posta appena sopra la cattedrale, di dimensione decisamente inferiore, è la più piccola chiesa di San Giorgio, che conserva i più begli affreschi che abbiamo visto in questo viaggio. Non completamente ristrutturati né del tutto consumati dal tempo, le forme e i colori si intravedono ancora sul bianco dell’intonaco, portando il visitatore a ricostruire, come in un mosaico, le immagini rappresentate.
A un’ora a piedi da Gelati c’è un altro complesso monastico molto suggestivo, anche se totalmente diverso dal primo: Motsameta, letteralmente “luogo dei martiri”. Terry ed io ci andiamo a piedi: un’impresa titanica, dato che abbiamo avuto l’infelice idea di camminare nelle ore più calde della giornata, fra mezzogiorno e le due. Per un’ora non facciamo altro che ripercorrere la strada che abbiamo percorso in macchina all’andata, scendendo da Gelati nella valle del fiume Tskaltsitela e cercando disperatamente l’ombra degli alberi ai lati della via. La passeggiata è piuttosto piacevole se si esclude il caldo: la prima parte è in discesa, poi il resto in leggera salita sino agli ultimi cinquecento metri, dove invece la salita si fa sensibile. Durante la camminata possiamo finalmente avvicinarci alle mucche che abbiamo visto all’andata: ancora non si sono mosse dalla carreggiata, che dev’essere ora caldissima. Ci facciamo inseguire anche da un cane pastore o due, ma con diplomazia e molta attenzione riusciamo ad arrivare sino alla nostra meta.
Il monastero in sé non presenta particolari attrattive: al suo interno c’è una chiesetta con campanile, come a Gelati, e una piccola dépendance per i monaci, che qui sono molti di meno, due, forse tre. Ciò che rende però questo luogo davvero meritevole di essere visitato è il paesaggio. Il piccolo complesso si erge come una cittadella, con tanto di mura e ponticello per essere raggiunta, su uno sperone di roccia costruito su un’ansa del fiume che scorre un paio di centinaia di metri sotto, ovvero lo Tskaltsitela, “acqua rossa” in georgiano. Il nome del fiume è legato a quello del monastero e deriva da una leggenda. Due fratelli dell’Imereti, la regione georgiana con capitale Kutaisi, nell’VIII secolo avevano guidato una rivolta contro gli invasori arabi, che all’epoca occupavano la Georgia. Ai due, catturati, fu proposto di convertirsi all’Islam in cambio della vita. Ovviamente rifiutarono, così furono torturati e barbaramente uccisi. I loro cadaveri furono poi gettati nel fiume che si tinse del rosso del loro sangue. Si racconta che i corpi dei fratelli, diventati successivamente santi, furono recuperati da alcuni leoni e seppelliti in cima al promontorio. E fu proprio sulle loro tombe che tre secoli dopo il re Bagrat IV fece costruire la chiesa, nucleo originario del monastero.

Il luogo in sé non raggiunge i livelli di suggestione e bellezza di Gelati. Anche la patina di antichità è stata cancellata dai lavori in corso, onnipresenti in Georgia in questi anni, che hanno reso questo luogo lindo e ordinato ma asettico, privandolo delle piccole imperfezioni e dei segni del tempo che lo rendevano autentico. Anche i monaci che cantano i salmi ai turisti in cambio di un piccolo obolo ricordano troppo i gladiatori davanti al Colosseo, un genere di spettacolo che speravo di essermi lasciato alle spalle scendendo dall’aereo. Rimane pur sempre innegabile la bellezza del luogo, con il fiume che si snoda pigro e circonda il promontorio roccioso immerso nel verde scuro dei boschi circostanti, che da sola giustifica una deviazione al monastero.
Con un taxi di fortuna, chiamatoci da un parcheggiatore abusivo in un luogo in cui non ci sono né parcheggio né macchine da parcheggiare, torniamo nel centro di Kutaisi, davanti al Teatro dell’opera Lado Maskhishvili, un edificio razionalista color grigio-ocra inaugurato nel 1955 che si affaccia sulla piazza della Colchide.
Ci fermiamo un attimo nel parco a sinistra della piazza, un’area verde con qualche statua, diverse fontane e alberi, per un po’ di refrigerio. Qui ci sono, se possibile, ancora più cani randagi che nel resto della Georgia, con ognuno dei quali faccio amicizia, prima che mi abbandoni perché non ho cibo da dargli. Dal parco si gode un silenzio irreale, a pochi metri dal traffico caotico e congestionato di Kutaisi. I Georgiani alla guida sono folli, non rispettano, quelle rare volte in cui c’è, la segnaletica, stanno affiancati in due in una corsia, non si fanno scrupoli a guidare per metà o per intero fuori dalla carreggiata e ignorano i limiti di velocità: vanno a una velocità incredibile sempre, tranne davanti ai dossi, anche il più basso, che per qualche strano mistero (o più probabilmente perché le loro auto non hanno più alcun tipo di ammortizzatore) superano al massimo ai 5 km orari.
Dopo aver gentilmente salutato una vecchia testimone di Geova che ci ha fatto leggere un opuscolo su Dio, ci incamminiamo verso il bazar. È un mercato chiuso, con le luci al neon che illuminano i banchi e le pareti di cemento come il soffitto: pare di essere in un parcheggio sotterraneo. Nelle bancarelle, vecchie col capo coperto puliscono la verdura, intrecciano ceste e ci sono anche alcuni venditori che dormono. A ben cercare vi si trova di tutto, specialmente ogni varietà di frutta e verdura e non solo le angurie e pesche che si trovano ad ogni angolo di strada. A queste si aggiungono carni, formaggi, erbe aromatiche, farina, vino, tabacco e soprattutto le strisce multicolore di churchukhela, il dolce tradizionale fatto di noci tritate ricoperte con del caramello ricavato dal succo d’uva, che pendono come salsicce. Impregna l’aria l’odore forte delle spezie, su tutte curry, pepe e coriandolo, con quest’ultimo che non può mai mancare in un piatto georgiano. L’arcobaleno di colori e sapori delle bancarelle contrasta con il luogo in cui il mercato si trova e, a mio parere, meglio di tanti altri esempi illustra l’anima della Georgia moderna, che pur in un ambiente grigio e impersonale come quello imposto dall’Unione Sovietica ai suoi stati satellite, è riuscita a mantenere il suo spirito gioviale fatto di brindisi, spacconeria e giovialità: un’anima decisamente più mediterranea che russa. Qui tutto sembra gridare, e come riporta Terzani, lo faceva anche prima del 1992, «Non confondeteci con l’URSS!».
Già negli anni trenta, il viaggiatore polacco Mieczyslaw Lepecki scriveva: «Paragonando le vie di Tiflis a quelle di Mosca o di Kiev mi stupivo di quanto differissero tra loro. Qui nel Caucaso, malgrado le difficoltà economiche, malgrado la miseria e la censura politica, la gente è infinitamente più allegra, vivace e sicura di sé. Per le strade di Mosca non si vedono che facce scure, il riso vi suona incongruo e quasi sinistro. A Tiflis è tutto diverso. La gente è più serena, più cortese, meno depressa». Gli fa da eco il più celebre connazionale Kapuscinski quando, visitando il Caucaso, aggiunge: «Alla nostra immaginazione l’Urss appariva una creazione uniforme, monolitica, dove tutto era ugualmente grigio e cupo e, per giunta, monotono, fatto in serie. […] Quindi mi recai nelle repubbliche non russe dell’Impero. Cosa mi colpì? Ebbene, malgrado la rigida corazzatura militaresca dell’autorità sovietica, queste piccole ma antichissime nazioni è riuscito di conservare qualcosa delle loro tradizioni, della loro storia, del loro orgoglio nascosto per necessità, della loro dignità personale. Vi scoprii un tappeto orientale steso al sole, che in molti punti conservava ancora gli antichi colori e attirava l’attenzione con la varietà dei disegni originali». Ne consegue che trovare un’identità, per una terra che è il crocevia fra due continenti e tre culture (quella europea, quella russa e quella arabo-mediorientale) non è impresa banale. I Georgiani stanno tuttora discutendo su quale area sia più affine a loro e non è una discussione da poco, dal momento che si lega indissolubilmente al modello politico sociale ed economico da adottare nei prossimi anni per crescere. Ad accomunarla alla Russia è la storia degli ultimi due secoli, ma le relazioni diplomatiche sono ai minimi storici; anche il Medioriente non sembra un’alternativa plausibile, come potrebbe essere invece per il musulmano Azerbaigian. Per questo, da anni ormai, i Georgiani cercano di stringere legami con l’Europa, specialmente l’area mediterranea con Grecia e Italia in prima linea, con cui condividono il passato più remoto e la religione. La Georgia, infatti, tra i primi regni a dichiarare il Cristianesimo come religione ufficiale, in precedenza aveva fatto parte dell’Impero Romano. Resasi indipendente negli ultimi anni dell’Impero, come l’Armenia era diventata uno stato cuscinetto controllato, a periodi alterni, dai Romani, indipendente o dai Parti, l’altra grande civiltà vicina.
Del bazar una cosa, infine, mi colpisce: accanto ai prodotti alimentari trovo in vendita una quantità spropositata (ogni banco ne ha circa una decina) di scope di saggina. Il perché ci fossero così tante scope in vendita è un mistero che, nonostante abbia chiesto a molte persone, è rimasto irrisolto.
Torniamo, alla fine di una lunga giornata, in ostello e conosciamo Riccardo, il ragazzo che nella notte ci aveva aperto. Chiariamo l’equivoco della sera prima, compiliamo i moduli per il soggiorno e scopriamo che lui è ligure e insieme ad Alberto, un suo amico per metà spagnolo e per metà italiano, che è in vacanza in Argentina ma che torna domani, ha deciso di aprire questo ostello dopo essere venuto a Kutaisi un anno prima ed essersene innamorato.
«Da febbraio dell’anno scorso è cambiato già tantissimo» – ci spiega – «Quando sono arrivato, la metà di queste strade non era asfaltata e ancora sino a un mese fa non era possibile cambiare i soldi [i lari georgiani, che si usano solo qui] all’aeroporto. Questo è un paese che sta facendo grandi passi avanti, si sta aprendo al mondo. Potrei sbagliarmi, ma credo che fra non molto tante imprese e società si accorgeranno della Georgia e arriveranno qui». La Georgia corre in fretta incontro all’Occidente, verso cui ha sempre guardato ma che solo ora può tentare di raggiungere, essendosi liberata del controllo di Mosca. Spero di sbagliarmi, ma credo che chiunque voglia veramente scoprire questa terra deve sbrigarsi, prima che si tradisca e diventi totalmente “europea”, abbandonando tutta la ricca storia e cultura (oltre ai paesaggi naturali mozzafiato) che la rende un luogo unico al mondo. Allora da vedere rimarranno solo musei e monumenti: una perdita immensa.
Stavamo discutendo di ciò, quando i gattini che Terry ed io avevamo conosciuto la notte precedente arrivano ad elemosinare qualche coccola e del cibo. «Si chiamano Tibi e Kuti, come Tbilisi e Kutaisi» – racconta Riccardo – «Li abbiamo trovati qualche settimana fa, abbandonati ai lati della strada, mentre andavamo a fare il bagno al fiume. Non potevamo lasciarli lì e così li abbiamo presi e ne abbiamo fatto le nostre mascotte».
Treno Kutaisi-Tbilisi, 10 luglio
È già ora di lasciare, anche se solo provvisoriamente, Kutaisi: ci torneremo negli ultimi giorni, dato che da lì prenderemo l’aereo per il ritorno. Partiamo in direzione Tbilisi, via treno. Da Kutaisi per la capitale, ogni giorno partono due treni: uno alle sei meno dieci di mattina l’altro a mezzogiorno e venticinque. Optiamo per il secondo, che arriva a destinazione alle cinque e mezza e, prima di partire, decidiamo di prendere il pane da uno dei tantissimi panettieri della città. Pane e prodotti da lui derivati, di cui tratteremo in seguito, sono centrali nella dieta georgiana, tanto che nei menu di tutti i ristoranti, oltre a una sezione per primi, una per le carni e una per il pesce, ve ne è una dedicata alle “pastries”. Solo in Francia ho visto un popolo dare tanta importanza al pane, ma neppure lì c’era la quantità spropositata di panetterie che ho trovato sotto al Caucaso. Ne ho trovate diverse in ogni villaggio che ho visitato, anche il più piccolo. Ovunque si presentano alla stessa maniera: caseggiati bianchi la cui unica apertura sulla strada è una finestra scorrevole su cui è incollato un foglio contenente i prezzi. Da un lato della finestra c’è la strada, il caos e tu che vuoi comprare, dall’altra parte del vetro un’oasi di calma. Accanto al panettiere, che ha le braccia bianche sino al gomito a causa della farina, una serie di mensole su cui sono ordinatamente posti i pani, dalla tradizionale forma di gondola schiacciata al centro. Dietro di lui si possono intravedere due o tre piccoli cilindri bianchi isolati da una cupola di metallo: sono i forni dove il pane viene cotto. Dentro il cilindro si trovano le braci. L’impasto viene gettato contro le sue pareti, cui si attacca, cuocendo uniformemente. È un metodo tipico delle repubbliche caucasiche, della Turchia e di quei paesi di cui si dice barbaramente “che finiscono in -stan”.
Preso il pane, qualche pomodoro e della frutta, chiediamo a Riccardo di chiamarci un taxi per la stazione con un’app locale apposita. Il taxi arriva e, salendo, mi accorgo che ha il volante di fronte al sedile anteriore destro. “Eppure la guida è a destra” – penso – “come in Italia”. Incuriosito, passo il viaggio a spiare, nelle numerose macchine che incontriamo, da quale parte stia il volante e noto che la maggior parte delle vetture ce l’ha a sinistra, ma alcune ce l’hanno a destra, come il nostro taxi.
Scoprirò solo qualche giorno dopo come stanno le cose: in Georgia si guida a destra, come mi era parso, e una buona maggioranza delle auto ha il volante a sinistra perché è stata prodotta in Europa o Russia. C’è però anche un fiorente mercato di auto di seconda mano giapponesi (dove la guida è a sinistra) e sudcoreane (dove la guida un tempo era a sinistra e ora a destra): da qui arrivano le macchine col volante a destra.
Mentre mi perdo a osservare volanti e a fare congetture, il taxi si ferma in una piazza congestionata per il traffico, con persone a piedi, taxi, auto e quei piccoli pulmini, da massimo venti posti, che qui vengono chiamate “marshrutka” e che sono il principale mezzo di locomozione pubblica georgiano. Il tassista si volta verso Terry e me dicendo «Bus station!», per farci capire che siamo arrivati a destinazione. La stazione del treno però è da tutt’altra parte e allora Terry prova a spiegargli in un inglese impeccabile, degno di Oxford. «Sorry sir, but there is a mistake. Maybe you didn’t understand that…» Il tassista la guarda confuso, non capendo cosa succede. Provo allora io, in inglese maccheronico, a spiegargli che noi vogliamo andare alla stazione del treno, non in quella dei pullman – «No bus station, train station! Train!» -, ma ancora nulla. In un ultimo tentativo, inizio a fare «ciuff ciuffff» e a muovere le braccia avanti e indietro come le rotaie dei treni ottocenteschi. Il volto dell’autista si colora di rosso: è furioso ma non importa, almeno ha capito. Subito prende il cellulare e ci fa vedere come sull’app fosse segnata come destinazione la stazione dei pullman. L’app però è in georgiano e non solo non capiamo cosa vi sia scritto, ma proprio non riusciamo a decifrarne i caratteri: l’alfabeto è infatti unico al mondo, vecchio di oltre duemila anni. Riusciamo però a fargli capire che se ci porta alla stazione giusta, lo pagheremo di più, basta che ci porti. A questo punto si calma, ingrana la retromarcia e in un attimo siamo di nuovo nel traffico della periferia di Kutaisi.
Di fronte alla stazione c’è una statua equestre su una larga pedana di quattro o cinque metri. Raffigura il re Davit, il costruttore, a cavallo. Nella mano sinistra stringe una spada, mentre nel palmo della destra tiene il modellino di una chiesa. «Prima di finire qui», dice una voce alle mie spalle, in italiano, «era nel centro di Kutaisi, dove ora c’è la fontana della Colchide. L’hanno spostata nel 1955, se non mi sbaglio». Mi giro e vedo Riccardo, insieme a una ragazza americana piccola e bionda che si presenta come Margareth. Riccardo mi spiega che ha deciso su due piedi di andare a fare serata a Tbilisi e voleva portarci Margareth, perché il giorno dopo sarebbe partita «e non poteva farlo senza aver visto prima la capitale».
Davanti alla stazione non c’è nessuno, solo due anziani che giocano a backgammon e fumano una sigaretta.
Saliamo sul treno, uno di quei vecchi modelli inglesi. C’è un unico vagone e i posti sono numerati. Sulla destra si sviluppa uno stretto corridoio, separato dai vari scompartimenti da una piccola parete con una porta a scorrimento. In ogni scompartimento ci sono sei posti in due file da tre. Fra i due posti accanto alla finestra c’è un minuscolo tavolino dove è possibile scrivere e appena sopra le teste dei passeggeri un ripiano dove posare i bagagli. Per il resto, è completamente spoglio. Nel nostro, oltre a me e Terry, si siedono Riccardo e Margareth e una coppia di Australiani di mezza età che sta chiudendo con la Georgia un tour di un mese e mezzo attraverso le repubbliche del Caucaso. Ci raccontano, fra le altre cose, che i mezzi in questo paese sono decisamente migliori rispetto a quelli in Armenia e Azerbaigian e che la nazione stessa in generale è molto più sviluppata e aperta all’Occidente rispetto alle sorelle caucasiche. «Paragonata all’Armenia, la Georgia è il bengodi: case migliori e più ricche, vigneti più grandi, belle greggi di pecore e mucche, vaste piantagioni di tabacco, prati d’erba verde e succosa», scriveva già trent’anni fa Kapuscinski. Evidentemente, le cose non sono molto cambiate.
Fortunatamente la compagnia è piacevole, sennò il viaggio di cinque ore, in uno scompartimento afoso a causa della mancanza di aria condizionata, sarebbe eterno. Resta comunque molto lungo: in questo paese ci vogliono cinque ore per fare meno di duecento chilometri. Il treno fa infatti una fermata ogni dieci minuti e non riparte prima di altri dieci, come accadeva in Italia cinquant’anni fa. Fra le fermate, boschi selvaggi e piccoli paesini con un paio di case.
Regolarmente, per tutta la durata del viaggio, un’inserviente ci rimprovera perché non abbassiamo le tende dall’unico finestrino dello scompartimento: «così non entra il caldo e si sta meglio», ripete ogni volta in tono sempre più spazientito. Non le diamo mai retta, preferiamo guardare il paesaggio, al costo di soffrire un po’ di più il calore. La coppia australiana scende a Gori, il paese natale di Stalin, uno di quei luoghi che a malincuore abbiamo dovuto tagliare dal nostro itinerario, per mancanza di tempo. Noi proseguiamo sino al capolinea. In quattro nel vagone da sei, devo ammetterlo, si sta piuttosto comodi.
Arriviamo così a Tbilisi per una toccata e fuga: domani partiremo per Kazbegi e il confine russo. Non guardiamo neanche il centro e andiamo direttamente in un ostello in periferia, vicino alla stazione degli autobus di Didube. Attraversiamo ampi viali, piuttosto anonimi, come i giganteschi palazzi di vetro che si susseguono ai lati. Sulla cima di alcuni svettano cartelloni lunghi oltre 5 metri che pubblicizzano le varie compagnie telefoniche o inneggiano alla squadra di calcio di casa: la Dinamo Tbilisi. Così la prima immagine di Tbilisi non è quella di “Venezia del Caucaso” che mi ero creato con le mie lettura, quanto quella di una metropoli moderna e occidentale. Dove sino a pochi decenni fa c’era il bosco che segnava la fine della città, ora si trovano quei «megaquartieri di case popolari tirati su alla meglio, in economia, senza un piano regolatore», che caratterizzano le città dell’Unione sovietica, per dirla di nuovo con Kapuscinski.
L’ostello in cui pernottiamo è gestito da Iraniani, la terza comunità di immigrati in Georgia, dopo i Cinesi e i Turchi. Non potrei esserne più felice, adoro la terra degli scià. Nel giardino incontriamo Freddie e Ghazal, marito e moglie, anch’essi iraniani, amici dei proprietari, che soggiornano nell’ostello durante i mesi estivi. Freddie è nato negli USA – ce lo racconta davanti a un tè caldo da lui offertoci – e insegna business a New York. In quanto cittadino americano, non può tornare in Iran, specialmente da quando Trump ha rialzato – usando una retorica a lui cara – i muri che Obama aveva iniziato a demolire, specialmente riguardo l’accordo sul nucleare.
Un anno – continua – per ritrovare i parenti rimasti in Iran, Freddie aveva avuto un’idea. Siccome lui non avrebbe potuto raggiungerli nel suo paese natale e loro non sarebbero potuti entrare negli States, si sarebbero trovati in un terzo paese, in cui tutti erano benvenuti. La scelta, per differenti motivi, era ricaduta sulla Georgia. Fu stato durante quel viaggio che Freddie conobbe Ghazal, di cui si innamorò e che poi sposò. Ora lei vive in Georgia, perché, avendo sposato un Americano, non può più tornare in Iran, e attende di ottenere il permesso di soggiorno per raggiungere suo marito negli Stati Uniti. Mentre aspettano, lui viene ogni estate a trovarla e, mentre è qui, insegna inglese a Tbilisi.
È senza dubbio la persona più simpatica conosciuta sinora e ci intendiamo subito, ma, non appena dimostro di conoscere un po’ di cultura persiana, è come se fossimo migliori amici da sempre. Gli mostro il mio tatuaggio in persiano, un verso di Hafez – il Dante persiano, per dirla in breve – e trascorriamo la sera parlando di Iran e Italia. Andiamo infine a dormire, con il rammarico di dover lasciare una così piacevole compagnia, perché domattina ci sveglieremo di buon’ora.
Kazbegi, 11 luglio
Ci alziamo con il sole per arrivare il prima possibile alla stazione degli autobus di Didube, la più grande di Tbilisi. Qui, per la prima volta, ritrovo luoghi e situazioni che mi ricordano l’Asia. Nel centro nevralgico dei trasporti nazionali, da dove partono marshrutke per ogni direzione, si sviluppa un caos visto prima d’ora solo a Kathmandu: autisti che urlano, famiglie che aspettano mangiando sui marciapiedi, biglietterie congestionate e tassisti che prepotentemente cercano di convincere i turisti a scegliere i loro mezzi piuttosto che pullmini lenti e scomodi. Dato il grande affollamento, in mezzo alla stazione, che altro non è che due spiazzi con una biglietteria nel centro, è sorto un mercato – e qui si vede lo spirito asiatico – che nasce la mattina e muore la sera. Ogni ambulante, con i suoi ortaggi e la sua frutta, si appropria del primo spazio che riesce a trovare e vi monta un piccolo banco in legno. Così, ogni anfratto è occupato o occupabile e il mercato ogni giorno è diverso, per composizione e grandezza. Solo il trambusto dei commercianti e dei clienti in attesa del bus resta uguale. La prima volta si rimane veramente intimiditi dall’aria di casa che si respira, cui si sente di non appartenere. Nell’ansia di trovare il mezzo giusto fra i tanti parcheggiati, sperando non sia già partito, è facilissimo perdersi e perdere le speranze: ci si ritrova, confusi, fra un cane che scorrazza e una vecchia che cucina due ciambelle per venderle a pochi centesimi. Qui in pochi ti aiutano, tutti cercano di venderti qualcosa.
Siccome la marshrutka per Kazbegi sarebbe partita solo alle 10, decidiamo di prendere uno dei taxi senza licenza che, per 5 lari a testa in più (meno di 2 euro), ci promette di portarci su in metà del tempo rispetto al pullmino. Inoltre, ci assicura due fermate durante il viaggio, in corrispondenza di monumenti, per fare foto. Accettiamo e saliamo su una vecchia Audi, assieme a due ragazze del Belgio che non aprono bocca per tutto il viaggio.
La prima fermata è a settanta km a Nord di Tbilisi sulla Strada Militare Georgiana, che dalla capitale porta in Russia, per visitare la fortezza di Ananuri. Questa è composta da una parte alta, in cui ci sono due chiese e una torre di guardia circondate da massicce mura merlate, e da una cittadella nella parte bassa, il tutto risalente al XVII secolo. Purtroppo, essendo troppo presto, non abbiamo visitato l’interno delle chiese ancora chiuse, ma ci siamo accontentati di passeggiare attraverso le rovine della cittadella, godendoci la spettacolare vista del castello sul lago artificiale di Zhinvali.
Sulla strada per Kazbegi ci fermiamo anche al Monumento all’amicizia dei popoli di Russia e Georgia, una struttura semicircolare nella cui parte interna un murale di piastrelle raffigura scene della storia russa e georgiana in stile naïf e con colori accesi. Più che il monumento in sé, merita la fermata il luogo in cui si è deciso di costruirlo: una cresta panoramica che si getta a strapiombo sulla valle sottostante e da cui, a giudicare dalla quantità di persone che lo propongono ai turisti, si è soliti gettarsi con il parapendio. Quando ci siamo fermati le nuvole basse e cariche di pioggia impedivano di vedere gli oggetti oltre i venti metri, rendendo il monumento, una massiccia costruzione in pietra e cemento, quasi etereo, uno schizzo su sfondo bianco.
Lascio il murale chiedendomi cosa deve pensare un Georgiano che lo vede in questi giorni. Poco prima del nostro arrivo (giovedì 20 giugno 2019, per la precisione), un deputato russo, Sergej Gavrilov, ha tenuto un discorso al Parlamento della Georgia in occasione di una riunione dell’Assemblea interparlamentare sull’ortodossia, un’organizzazione internazionale creata dal Parlamento greco nel 1993 per facilitare le relazioni tra parlamentari di religione cristiana ortodossa di vari paesi. I leader dell’opposizione filoeuropeista si sono indignati e hanno organizzato una protesta su Rustaveli Gamziri, la via principale di Tbilisi, cui hanno partecipato oltre diecimila Georgiani. Ali più facinorose hanno tentato di entrare nel parlamento per impedire il discorso di Gavrilov, assaltando l’edificio. Le forze dell’ordine sono intervenute e negli scontri sono rimaste ferite ben 240 persone, 160 manifestanti e 80 agenti. Il giorno successivo, Irakli Kobakhidze, presidente del Parlamento, reo di avere permesso l’intervento del deputato russo, si è dimesso, ma le reazioni non sono finite qui. Putin, irritato dalla manifestazione, da lui definita «una provocazione antirussa», ha approvato un decreto che vietava alle compagnie russe di volare da e verso la Georgia, prevedeva il rimpatrio dei cittadini russi attualmente nella repubblica caucasica e raccomandava ai tour operator di non indirizzarvici i propri clienti.
A scatenare questo vortice di violenze e incidenti diplomatici, nato da un evento piuttosto banale come un discorso in parlamento di un politico straniero, è stato il fatto che i Georgiani non perdonano tutt’ora alla Russia l’ingerenza nelle repubbliche autonome di Abkhazia e Ossezia del Sud, due delle tre repubbliche caucasiche – assieme al Nagorno Karabakh, conteso da Armenia e Azerbaigian – autoproclamatesi indipendenti ma non riconosciute come tali dalle Nazioni Unite. Alla fine dell’ottobre del 1993 gli Abkhazi, sulla spinta delle rivendicazioni nazionalistiche sorte alla caduta della CSI (la Comunità degli Stati Indipendenti, prosecuzione ideale dell’URSS), avevano preso la capitale Sukhumi e, con l’aiuto delle truppe russe, avevano fissato sul fiume Inguri i confini del neonato stato di Abkhazia (che ancora oggi è riconosciuto solamente da Russia, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Vanuatu, Tuvalu e Siria). Questo conflitto, che provocò la morte di molti civili georgiani residenti nella regione di Sukhumi e l’esodo di 250 mila profughi in Georgia, non aveva trovato una risoluzione, e tutt’ora l’Abkhazia ha un governo indipendente guidato da Mosca e protetto in buona parte dall’esercito russo.
Quindici anni dopo questo fatto, nel 2008, la storia si è ripetuta, questa volta nella zona dell’Ossezia del Sud. Anche qui gli Osseti, come gli Abkhazi, avevano deciso di creare una propria repubblica indipendente con l’aiuto militare russo. La regione era già quella che i reporter di guerra chiamano una “zona calda”. Negli anni passati c’erano infatti stati scontri per il suo controllo fra il governo georgiano e quello russo, tanto che, una risoluzione del 1992 firmata da Shevarnadze e Eltsin voleva che fosse un’area smilitarizzata. Non si sa se provocato in qualche maniera dalla Russia, che dal canto suo si fece subito trovare pronta, come se lo aspettasse, o se ubriacato dall’ampio consenso di cui godeva e dalla buona situazione economica, il presidente Shevarnadze nel 2008 aveva inviato un contingente nella regione per riprendersi “la provincia di Tskhinvali”, come la chiamano qui, non accettandone neppure il nome russo. A questo attacco, la Russia aveva risposto energicamente, colpendo la Georgia e arrivando a bombardare e occupare, per una intera settimana, la città di Gori, a novanta chilometri da Tbilisi.
A questo punto, la Georgia si era arresa e la Russia, sotto la pressione della comunità internazionale, si era ritirata, ricreando lo status quo che regnava prima dell’attacco georgiano. Da quel momento in poi le relazioni fra i due paesi sono ulteriormente peggiorate, tanto che oggi basta una piccola incomprensione come quella avvenuta in questi giorni per scatenare rivolte dagli esiti fatali.
Non finisco di pensare a tutto ciò che sono quasi giunto al confine con la Russia, dove assisto a uno spettacolo alquanto insolito. Sul lato della strada sostano oltre un centinaio di camion, posti ordinatamente in fila uno dietro l’altro per oltre due chilometri. Nel frattempo, anche il paesaggio è cambiato. I boschi fitti che caratterizzano la parte centrale della Georgia hanno lasciato il posto ai prati verde brillante della montagna, dove le mucche brucano in pace. Con questo sfondo, la coda suscita più effetto di quanto avrebbe fatto nella periferia di una città o sulla superstrada che da Tbilisi si spinge verso Ovest. «Questi camion aspettano di superare il confine», ci spiega il tassista in inglese, «ma la Russia adesso ha istituito un embargo, anche se non totale. Possono passare solo dodici camion al giorno. Se non passi, o torni indietro o resti fermo qui, sapendo che il tuo turno può arrivare anche dopo più di una settimana».
Faccio una stima dei camion in fila e arrivo alla conclusione che, se quotidianamente ne passano solo dodici, gli ultimi della coda staranno fermi almeno dieci giorni; è un’enormità, considerato che la maggior parte porta prodotti deperibili, come ortaggi, vino, formaggi e altri generi alimentari.
Kazbegi, detto anche Stepantsminda, è un villaggio a 1700 m sul livello del mare che si trova a pochi minuti dal confine russo, ai piedi del monte Kazbek, un colosso di oltre cinquemila metri che incombe sulla cittadina, ricordando costantemente agli abitanti come l’uomo sia piccolo rispetto al creato. Ci troviamo in uno di quei luoghi – ve ne sono un altro paio in Georgia – in cui si ha la chiara sensazione che, se non si inizia a credere in Dio qui, non lo si potrà mai fare da nessun’altra parte.
Sin dai primi passi, si respira un’aura di sacralità: che sia la chiesa di Tsminda Sameba (Santa trinità) che, posta su una cima di fronte alla città, ti osserva ovunque tu sia, oppure il silenzio irreale che regna nella città, non è chiaro. Per le strade si cammina come in chiesa. Addirittura, i cani randagi, sempre pacifici, abbaiano minacciosi contro le comitive di escursionisti che fanno troppo rumore, come se essi stessi capissero l’importanza della quiete in quel luogo.
Siccome non abbiamo pranzato, prima di visitare la chiesa Terry prende da un fornaio un khachapuri a testa, da mangiare una volta arrivati in cima. Il khachapuri, una forma di pane farcita con formaggio, si contende il titolo di piatto nazionale con i khinkali, ravioli al vapore speziati e ripieni di carne, formaggio, funghi o patate. Questa sorta di focaccia ripiena, è tanto diffusa che ogni regione possiede la sua variante e quella dell’Adjara, il Khachapuri Acharuli, è sicuramente la più appariscente: una grande focaccia a forma di barca che si ripiega lasciando all’interno una conca riempita di burro e formaggio fuso, con sopra un uovo appena scottato. Più diffusa e relativamente meno calorica è la variante dell’Imereti, piatta e tonda, più piccola ma più spessa di una pizza, ripiena di formaggio fuso. Vi sono poi altre versioni più rare, come il Khachapuri Megruli, una focaccia tonda ripiena di formaggio con altro formaggio fuso sopra, o il Khachapuri Achma, con strati di pasta e formaggio. Il terzo piatto tipicamente georgiano è il lobiani, identico in tutto e per tutto al khachapuri, ma ripieno di un impasto di fagioli e spezie.
Per raggiungere da Kazbegi il monastero di Tsminda Sameba è possibile prendere un taxi, che porta i turisti più pigri sino all’entrata attraverso una strada sterrata di sei chilometri, oppure percorrere un sentiero a piedi, in una camminata che dura circa un’ora con un dislivello di cinquecento metri, alla portata perciò anche di escursionisti non esperti. Salendo ci si imbatte per prima cosa in una torretta diroccata che domina sulla valle sottostante. Da lì si continua attraverso un paesaggio che ricorda molto quello alpino della Valle d’Aosta, con ruscelli che corrono impetuosi verso valle o prati di un verde acceso, dove brucano molte mucche, qualche capra e pochi cavalli.
Al vero spettacolo si assiste, però, una volta arrivati in cima. È la classica cartolina dalla Georgia: le due chiese che spuntano dalla cima della montagna con il monte Kazbek sullo sfondo. Anche qui le nuvole che coprono il sole gettano una luce quasi spettrale sull’incredibile panorama.
Le due chiese all’interno sono molto simili alle altre che abbiamo già visto e che continueremo a vedere durante il viaggio, anche se la loro antichità – risalgono al XIV secolo – è evidente e incute un riverente rispetto, come sempre fanno le chiese in montagna. Sono entrambe molto piccole e buie, tanto che l’occhio, per abituarsi e scorgere qualcosa, deve attendere qualche minuto. All’inizio distingue solo le sottili fiamme delle tante candele accese sotto le solite icone dei santi. L’odore della cera che brucia permea l’aria.
Durante la discesa incontriamo una coppia di giovani russi, che la sera prima era nell’ostello a Tbilisi con noi. Ci riconosciamo e salutiamo. Lui è allegro e gioviale, pieno di energie, mentre la ragazza è dieci metri sotto e fatica a salire, fermandosi continuamente per posare lo zaino e riposarsi. «Stiamo andando a fare un trekking», spiega il ragazzo a me e a Terry, «e stanotte dormiremo vicino al ghiacciaio. Abbiamo preso la tenda». Noi guardiamo stupiti la sua povera fidanzata che, stravolta, approfitta della pausa per riposarsi, mentre lui continua: «l’anno scorso sono andato in cima all’Elbrus. È stato molto facile e fra qualche giorno voglio andare sul Kazbek. Questo piccolo trekking infatti serve come allenamento per la salita». Li salutiamo, chiedendoci quanto la ragazza, minuta e biondissima, sia entusiasta dei piani del fidanzato.
Tbilisi, 12 luglio
La mattina del quarto giorno lasciamo Kazbegi in direzione Tbilisi, questa volta per starci almeno un paio di giorni. La prima cosa da visitare nella capitale è la fortezza di Narikala, posta sull’omonima collina, da cui è possibile vedere tutta la valle di Tbilisi.
La cittadella, costruita dagli Arabi nell’VIII secolo, è stata nei secoli conquistata, distrutta o modificata da tutte le popolazioni che sono passate per questo spicchio di mondo: Turchi, Persiani, Ottomani, Georgiani e, infine, Russi. Dell’edificio originale non resta più molto, solo rovine su cui è possibile arrampicarsi per sorpassarle, sino a raggiungere una statua di venti metri, posta sempre sulla cresta delle colline, che raffigura una donna. È la madre Georgia: nella destra tiene una spada, da usare contro i nemici del paese, mentre nella sinistra stringe una coppa di vino, da condividere con gli amici. Questa statua gigantesca si scorge da tutta Tbilisi, basta alzare la testa per incontrarne lo sguardo, che controlla costantemente tutti i suoi figli.
Nella fortezza si può visitare la chiesa di San Nicola, un edificio moderno color beige, ricostruito dalle fondamenta negli ultimi anni e privo di particolari suggestioni.
Una volta raggiunta la cresta della collina, se ci si volta da un lato, non vi è assolutamente nessun segno della presenza umana, ma solo vegetazione di tutti i tipi: la zona è tanto ben preservata perché sino al XIX secolo ospitava i giardini reali, che nel 1845 furono trasformati in giardino botanico, dove è tutt’ora possibile passare un paio d’ore al riparo dall’afa per il modico prezzo di un lari (circa 30 centesimi di euro). Dall’altro lato, invece, si estende la città, con i suoi abitati che si perdono nell’orizzonte.
Appena sotto la fortezza, a destra, vi sono le case antiche coi balconi di legno intagliato che compongono la città vecchia – K’ldis Ubani (quartiere di roccia) -, da cui spiccano la Cattedrale Armena di San Giorgio, del XIII secolo, al cui esterno è seppellito il celebre poeta armeno Sayat Nova, che conserva una stupenda pala d’altare raffigurante immagini dei santi e scene della vita di Cristo, e le chiese di Jvaris Mama e Norashen, che condividono il giardino d’entrata con un panettiere. La seconda è chiusa dal 2015 per restauro e attraverso le finestre se ne possono vedere le enormi colonne e le fondamenta, dato che manca anche il pavimento. Nella prima, invece, oltre ai ricchi affreschi multicolore con azzurro, bianco, rosso e oro a predominare, abbiamo la possibilità di ammirare un rituale religioso. Una beghina, china su un leggio, canta leggendo da un gigantesco libro. Le risponde, dalla zona dedicata agli officianti, una voce forte, che canta anch’essa. Dopo vari minuti di canto, dalla sacrestia esce un prete, barba lunga e tunica nera, che, seguito da un chierichetto, facendo roteare ritmicamente un turibolo, asperge la chiesa con dell’incenso, lasciandosi dietro l’odore pungente. Nessuno, escludendo i tre attori, è presente, all’infuori di Terry e me, che, pur rapiti dallo spettacolo, non sappiamo se restare o andarcene, temendo di disturbare un momento che dall’esterno risulta tanto intimo.
Dalla città vecchia, scendendo verso il fiume che attraversa Tbilisi, il Mtkvari, si trova il Meidan, che in georgiano significa semplicemente “piazza”. Un tempo sede del principale bazar di Tbilisi, ora è solo una piazza congestionata dal traffico, su cui si affacciano ristoranti, caffè e un locale a luci rosse e dove i rappresentanti dei viaggi organizzati cercano di vendere un tour per le principali attrazioni della città.
Dal Meidan, attraversando il ponte, si giunge alla chiesa di Metekhi, un edificio suggestivo costruito su una piccola rupe che si getta a capofitto sul fiume. Sulla rupe, vuole la leggenda – l’ennesima storia di religione e sangue -, è stato ucciso il martire Abo, un Arabo che, arrivato nella città quando faceva parte del califfato, aveva imparato il georgiano, scoperto le sacre scritture e si era convertito infine al Cristianesimo. Per questo fu ucciso, la sua salma fu bruciata proprio ai piedi della rupe, in modo che nessuno potesse venerarne il corpo, e le ossa furono gettate nel Mtkvari in un sacco di pelle di pecora. Sul lungofiume dove Abo fu bruciato sorgono ora due cappellette molto caratteristiche. In alto, a fianco della chiesa, troneggia la statua di Vakhtang Gorgasal, il re che secondo la leggenda fondò la città di Tbilisi. La chiesa è colorata e decorata e, a differenza di tante in Georgia, molto illuminata, grazie a un grande lampadario su cui sono dipinte le onnipresenti immagini dei santi. Fuori piove, un classico acquazzone estivo che si esaurisce in pochi minuti, dunque restiamo un attimo in più nella chiesa, aspettando il sereno. Il silenzio e il caldo delle candele all’interno contrastano con il freddo e il rumore del temporale che impazza all’esterno. D’altronde, la chiesa non è forse sempre stata un rifugio durante le tempeste, sia esterne che interiori?
Proseguendo lungo il corso del fiume, dal lato opposto rispetto alla chiesa, si arriva al quartiere di Abanotubani, anch’esso ai piedi della collina di Narikala. Qui si trovano le famose terme, con i caratteristici tetti a cupola, frequentate, fra i tanti, da Dumas e Puškin. Qui pulsa il cuore primigenio della città: il nome Tbilisi significa, infatti, “sorgenti calde”. Non è quindi difficile immaginare che le prime persone che si stabilirono qui lo fecero proprio perché attirate dalle acque termali. Le due leggende sulla fondazione di Tbilisi ne confermano la centralità. La prima vuole che Vakhtang Gorgasali, durante una battuta di caccia da queste parti, avesse colpito un fagiano che, caduto in una sorgente calda, ne era uscito cotto a puntino. La seconda narra invece che il sovrano colpì un cervo, il quale bagnò la ferita con l’acqua e guarì miracolosamente. Qualunque sia la verità, è certo che il sovrano decise di costruirvi una città e di farne la sua capitale trasferendovi la corte, che si trovava prima nella vicina Mtshketa.
Passeggiando oggi nel quartiere, invece, si avverte il passato arabo e persiano della città; le case dai balconi cesellati con motivi floreali e arabeschi, i colori accesi, le finestre e le porte sormontate da cupole a punta e altri elementi tipici dell’architettura islamica catapultano il viaggiatore nella Baghdad delle Mille e una notte. Salendo per la strada principale, si incontra la moschea, con un bianco minareto a fianco.
All’interno la prima cosa a colpirmi è l’incredibile luminosità del luogo. Tutte le moschee in cui ero stato sinora erano molto buie, mentre qui tutto sprigiona luce: dalle grandi finestre che danno sulle terme al colore dei tappeti bianchi e azzurri, sul pavimento e alle pareti. Poche persone discutono in gruppi da tre o quattro; al muro, una piccola biblioteca di testi sacri in arabo è posta sotto una balaustra dove trovo Terry: è l’area dedicata alle donne.
Dirigendo lo sguardo verso Nord, dalla fortezza di Narikala, si può trovare il ponte della pace, che come un serpente attraversa il fiume. Si tratta di un’opera piuttosto controversa e vistosa: una passerella in acciaio e vetro di color acquamarina, progettata dall’italiano Michele de Lucchi e inaugurata nel 2010.
Appena prima del ponte, si riesce a distinguere la cattedrale di Sioni. L’edificio, che prende il nome dal monte Sion di Gerusalemme, è molto caro ai Georgiani. Costruito nel V secolo sotto Vakhtang Gorgasali, fu più volte distrutto e rifondato: la chiesa attuale risale al XIII secolo. Qui si trova una replica della sacra croce di Santa Nino, un crocefisso che la leggenda vuole sia stato realizzato dalla santa intrecciando i suoi capelli a rami di vite. Circondato da edifici di ispirazione islamica, è il primo baluardo della fede che incontriamo colmo non di turisti, bensì di fedeli. È infatti in corso una cerimonia religiosa: dopo quanto visto nella chiesa di Jvaris Mama, mi imbatto finalmente in una vera messa! Mi posiziono in un angolo e con il taccuino prendo appunti, profondamente colpito dalle differenze rispetto alla nostra messa. Rimango stupito, poiché ero convinto che i Georgiani fossero cattolici.
La Chiesa apostolica autocefala ortodossa georgiana – questa la titolatura ufficiale – è molto antica e ha origine nel I secolo. Influenzata molto dalla chiesa ortodossa, differisce sensibilmente nel rito da tutte le altre confessioni cristiane ed è un elemento centrale della cultura georgiana, tanto che ben l’85% della popolazione – numeri che nella nostra religiosissima Italia neanche intravediamo – la professa attivamente. In passato, infatti, la religione fu l’unico modo per i Georgiani di distinguersi dai conquistatori. Finché questi erano Arabi, Ottomani o Persiani, bastava essere Cristiani per differenziarsi. Questo non fu più sufficiente, però, quando, fra il XVIII e il XIX secolo la Georgia fu annessa all’impero russo. Allora, il rito si distinse rispetto a quello ortodosso russo, tanto che a Mosca nel 1811 fu abolito lo status di autocefalia della chiesa georgiana, che essa si riprese oltre un secolo dopo, nel 1917 con la rivoluzione di febbraio, ma che non fu riconosciuto dai popi russi sino al 1943.
Riguardo alla liturgia, quello che, da scampoli di cerimonia, ho potuto notare, è che non vi sono banchi dove sedersi e i fedeli stanno perciò in piedi, sparpagliati in modo piuttosto uniforme; buona parte della messa è cantata, in parte dall’officiante e in parte da un coro femminile; ad un certo punto, il “prete” e i “chierichetti” spargono l’incenso sull’uditorio, facendo oscillare un grande turibolo. Ho anche letto – ma purtroppo non vi ho mai assistito – che la comunione è fatta con del pane vero e proprio, che il prete acquista dal vicino rivenditore, benedice e poi distribuisce ai fedeli. Un piccolo gesto, che però rimanda alla semplicità della chiesa delle origini.
Continuando verso Nord dalla cattedrale di Sioni, si imbocca una via stretta di sampietrini, rossi come i muri delle case, turistica ma ben tenuta, con molte piante e su cui si affacciano bar, ristoranti e negozi di souvenir. Al termine della strada, sulla destra, si trova la basilica di Anchiskhati, la più antica chiesa della città, risalente al VI secolo. Sull’ingresso, incorniciato da due palme, l’immagine di un Cristo con un’espressione a metà fra il triste e il contrariato invita i passanti a entrare. I grandi e consunti blocchi di pietra che formano i muri danno l’idea dell’antichità della chiesa già dall’esterno, ma solo dentro si riesce a coglierne pienamente l’età. L’interno è spoglio e oscuro e gli affreschi, dipinti secoli addietro, sono ormai indecifrabili, corrosi e anch’essi scuriti dal tempo. La sensazione che si ha è quella di dover rispettare un misterioso silenzio, in attesa che qualcosa accada; si ha sempre l’impressione che da lì a un attimo un manipolo di frati incappucciati possa fare capolino cantando nenie religiose. Ricordo di aver sempre provato qualche cosa di simile solo nelle chiese paleocristiane, come la basilica di San Vitale a Ravenna.
Una ventina di metri più avanti si trova poi una delle principali attrazioni di Tbilisi. La torre dell’orologio è stata costruita pochi anni fa da Rezo Gabriaze, regista teatrale, pittore e scultore georgiano, e segna l’entrata del teatro delle marionette. I disegni e le forme cubiste uniscono lo spirito fiabesco a quello della più antica tradizione georgiana, ma non c’è nulla che meriti una fermata di più di un paio di minuti. Allo scoccare dell’ora, un angelo esce sul balcone e batte con un bastone su una campana tante volte quante sono le ore segnate, prima di tornarsene nella torre ad aspettare che passino altri sessanta minuti.
La via centrale, punteggiata di monumenti è azzimata e ripulita, ad uso e consumo dei turisti, ma basta andare nella prima traversa per trovare un’altra città. Le strade non sono più così pulite e le facciate delle case non così eleganti. Ai ristoranti e ai bar iniziano a sostituirsi le bancarelle di money exchange, le agenzie turistiche, che propongono gite in giornata o tour attraverso tutto il paese, tantissime vinerie e qualche mendicante, che per la prima volta vedo in un luogo diverso dall’ingresso di una chiesa. Bisogna proseguire in direzione opposta al fiume per imbattersi in una zona residenziale, dagli edifici antichi ma non pittoreschi come quelli della città vecchia, e per questo motivo di scarso interesse per i visitatori. Gli stranieri che passeggiano per queste vie sono infatti esclusivamente di due tipi: quelli che evitano le rotte troppo turistiche per scoprire il vero spirito di una nazione parlando con i suoi abitanti e quelli che si sono persi.
Io e Terry siamo a metà fra i due e ci avventuriamo in questa zona, dove il vecchio sa di vecchio e basta, senza avere la dignità del tempo di una cattedrale o di una fortezza. Le strade sono grigie come i muri dei palazzi. Ragazzi in infradito e costume da bagno si inseguono su biciclette fatiscenti, mentre una signora anziana spazza la polvere davanti all’uscio di casa, dove vende poca frutta, il cui prezzo è scritto su di un pezzo di cartone con del carbone. Passeggiando, finiamo in una piccola piazzetta dedicata a Lado Gudiashvili, artista fra i più importanti del Novecento georgiano. Al centro di un piccolo quadrato delimitato da un’area verde, con qualche panchina e una fontana, si erge la statua in pietra di due amanti che si riparano sotto un ombrello. Attorno, dei lavori in corso rendono inagibile metà delle strade; sacchi di calce, betoniere e altri attrezzi sono lasciati incustoditi, in attesa di essere ripresi l’indomani. Alzando gli occhi sopra il livello della strada, si vedono case sventrate e attraversate dalle impalcature. In un edificio, il cui secondo piano è in fase di demolizione, è rimasta, spenta, una gru. L’indomani continuerà il suo lavoro; con pazienza distruggerà anche il resto – quel trave portante del tetto spaccato a metà, il pavimento in legno già dissestato – cancellando un altro piccolo pezzo della Tbilisi di ieri.
Con la torre termina la zona storica di Tbilisi. Da lì in poi si entra nella parte ottocentesca della città. Per farlo, si attraversa un basso, ma lungo, sottopassaggio. Ai lati della zona pedonale, decine di piccoli negozi, molti dei quali sono panetterie. «In Georgia anche i sottopassaggi sanno di pane, a differenza che nel resto del mondo», chiosa icasticamente Terry.
Uscendo dal sottopasso, a sinistra si ha Piazza della libertà, un tempo piazza Lenin. Al posto della statua del dittatore, abbattuta nel 1990, si trova ora, in cima ad una altissima colonna, un san Giorgio dorato – è il patrono della nazione -, che con la lancia trafigge il drago. Dalla piazza inizia l’arteria principale di Tbilisi, Rustaveli Gamziri, ovvero via Rustaveli, dedicata al grandissimo scrittore, poeta e cortigiano che, nell’epoca d’oro georgiana, durante il regno della regina Tamar, compose Il cavaliere dalla pelle di leopardo, un poema epico di cui ogni georgiano che si rispetti conosce a memoria almeno un paio di quartine. Sul viale, che ospita una statua del poeta proprio di fronte all’uscita della metro, si possono trovare i principali musei del paese, ovvero la Galleria Nazionale, il Museo di Belle Arti e il Museo della Georgia, diverse chiese e l’ex palazzo del parlamento.

Il Parlamento, infatti, si riunisce ora in un edificio moderno della periferia di Kutaisi, ma molti politici non sono contenti della sistemazione e vorrebbero tornare nella capitale, perciò la situazione potrebbe cambiare nuovamente in futuro. Quello che è certo è che l’edificio imponente che fronteggiamo è stato teatro di alcuni dei fatti più famosi e tragici della storia georgiana recente. Da qui partì la rivoluzione di febbraio, che nel 1917 portò la Georgia a ottenere l’indipendenza dall’impero russo. Indipendenza che sarebbe durata solo quattro anni, fino alla cacciata del primo ministro Noe Zordania da parte dei bolscevichi e il suo ritiro, in esilio, a Parigi, dove sarebbe morto senza aver potuto rivedere la sua terra. Qui, nel 1921, la popolazione georgiana si ribellò al colpo di stato bolscevico. Qui, il 9 aprile del 1989, venti uomini che manifestavano per l’indipendenza georgiana vennero barbaramente uccisi dai militari sovietici. Qui si combatté durante i difficili anni della transizione, dopo l’uscita dall’Unione Sovietica, per la democrazia, soprattutto nell’ambito della guerra civile fra Shevarnadze e Gamaskurdija. Sempre qui ebbe luogo la rivoluzione delle rose del 2003, due settimane di manifestazioni che ebbero lo scopo di cacciare Shevarnadze, ritenuto colpevole di aver truccato i risultati delle elezioni, e il suo governo illiberale e corrotto. Ogni sanguinosa tappa che ha fatto della Georgia lo stato democratico che è ora si è svolta qui, di fronte a questo palazzo dalle grandi colonne risorgimentali bianche.
Anche adesso qualcosa sta accadendo. Un giovane, uno studente forse, parla in tono dimesso davanti a un microfono, mentre una folla di un centinaio di persone, eterogenea e composta, lo ascolta sventolando bandiere della Georgia. Due televisioni stanno riprendendo il discorso, mentre attorno diverse volanti della polizia monitorano la situazione per evitare disordini. Mi avvicino allora ad una coppia di poliziotti per chiedere cosa stia accadendo. Al mio inglese rispondono solamente, in malo modo, “Ruski?”, che può voler dire “parli russo?”, perché è facile che sia l’unica lingua straniera che conoscono, o “sei russo?” oppure che la manifestazione ha a che fare con la Russia. Lo confesso, penso a quest’ultima ipotesi probabilmente influenzato dalle notizie di cronaca dell’ultimo mese. Non riuscendo a farmi capire né a capire le risposte datemi, mi allontano senza aver compreso bene cosa stia succedendo.
Davit Gareja, 13 luglio
Partiamo per Davit Gareja (o Gareji), un complesso monastico al confine con l’Azerbaigian. Siccome è molto fuori mano e i taxi costano cari, per risparmiare ne dividiamo uno con una ragazza tedesca molto loquace, la quale ci racconta che lavora per un’agenzia immobiliare a Berlino, pur essendo lei di Monaco di Baviera. L’autista, un uomo sui quaranta, coi capelli brizzolati e molto giovanile, appena sente che la nostra compagna di viaggio è tedesca, inizia a raccontarci che anche lui ha vissuto in Germania, poi in Francia e in altri paesi europei, prima di tornare in Georgia a mettere su famiglia. In Italia non ha mai vissuto, ma ci è passato una volta in macchina per andare in Francia. Ne ha comunque un ricordo molto piacevole perché a Milano è stato fermato senza documenti e senza patente e, quando ha detto che li aveva a casa in Francia, dove stava tornando, i carabinieri lo hanno lasciato andare con un’alzata di spalle. «In Germany this is not possibile» chiosa. No, decisamente no.
Il viaggio è molto lungo, sulle quattro ore circa, sia perché il luogo è molto lontano sia perché nella parte finale la strada non è asfaltata e si procede ai venti all’ora. Iniziamo a parlare con l’autista, che ci racconta del suo paese, specialmente rispetto agli ultimi anni. È in questa circostanza che vengo a scoprire che le macchine che hanno il volante a destra arrivano da Giappone e Corea del Sud ed è lui a spiegarmi per filo e per segno il terremoto sociale e politico causato da Sergei Gavrilov, il politico russo che aveva tenuto il discorso al Parlamento georgiano, e le sue conseguenze, come l’embargo che ha creato la coda di camion sul confine. Rivela inoltre che Gavrilov fu comandante dell’esercito russo quando questo invase Abkhazia e Ossezia, notizia che nessun media internazionale riporta e che perciò ritengo una fake news del governo georgiano.
Ci racconta anche che su Rustavi TV, un canale televisivo georgiano, si possono trovare sempre più spesso in onda i discorsi che un ragazzo tiene contro Putin, denunciandone il comportamento nei confronti del mondo e della Georgia in particolare. Mi chiedo se non sia lo studente che avevo visto il giorno prima tenere un comizio davanti al palazzo dell’ex parlamento. «I vecchi amano la Russia, i giovani l’Europa», sintetizza, «I dont’know what happened».
Parla poi della mafia georgiana: «fino a venticinque anni fa, molta mafia. Ti rubavano tutto, anche la giacca. Nel 2003 poi è cambiato il governo e la mafia è andata via in Europa, Stati Uniti e Russia». Abbozziamo un tentativo di replica a questo facile ottimismo e allora l’autista corregge il tiro: «cioè, i grandi mafiosi ci sono ancora, vivono qui, ma in pace». Non capisco quindi se i mafiosi hanno solo appaltato all’estero i loro affari oppure se sono diventati talmente potenti da non aver più necessità di ricorrere all’omicidio e alla microcriminalità per arricchirsi. Per non irritare il nostro ospite preferisco tenere per me questi dubbi. Nel mentre, lui continua «ora il paese è molto tranquillo. Puoi camminare sino a tardi la sera e non ti succede nulla, puoi anche dormire fuori se vuoi! E per i turisti ancora di più. Se fai un crimine contro uno straniero, ad esempio gli rubi il portafogli, paghi tre volte di più che se lo fai a un Georgiano». L’ennesima riprova di come questo paese stia con tutte le forze cercando di aprirsi al mondo, dopo l’isolamento sovietico, passando per il turismo.
Nel frattempo, il paesaggio continua a cambiare. Ben presto le case della periferia di Tbilisi iniziano a rarefarsi, sino a venire soppiantate da sporadiche fattorie con le mucche che, puntualmente, attraversano la strada proprio un attimo prima che la macchina arrivi. Ai lati, coltivazioni di mais e grano stanno immobili sotto il sole che brucia l’erba. Per il resto, il paesaggio è infatti molto arido e ricorda quasi la savana: pochi alberi isolati, storti e spogli, ai cui piedi sta erba secca o bruciata, gialla e marrone. Sembriamo distanti anni luce da Kazbegi. La Georgia, infatti, pur essendo grande come Lombardia, Veneto e Friuli messi insieme, racchiude regioni e climi molto differenti tra loro.
Siamo ora in Kakheti, che Gorecki definisce «la Toscana della Georgia» e non è difficile capire perché. A pochi chilometri dalla terra brulla si apre infatti un’area di boschi e colline coltivate a uva, proprio come quelle del centro Italia. Qui viene prodotta la maggior parte del vino georgiano, di cui gli abitanti vanno fieri; dopotutto, è da oltre 8000 anni che i Georgiani lo producono e lo bevono, tanto che qualcuno ritiene addirittura che ne sono stati gli inventori. I nomi hanno un che di poetico: Mukuzani, Achasheni, Saperavi, Tsinandali, Tvishi, Manavi, Napareuli, Aleksandrouli, Vanchakara o Rkasiteli sono solo alcune delle varietà presenti. Molto più dolce e fruttato dei vini piemontesi cui sono abituato, il Saperavi è una delle varietà più celebri, onnipresente su ogni tavola del paese.
Non è raro infatti imbattersi in un banchetto improvvisato al bar fra qualche amico o a una riunione di familiari al ristorante. Ovunque il vino scorre a fiumi, ad accompagnare kachapuri, lobiani, khinkhali e altre pietanze georgiane, come l’ajapsandali, uno stufato freddo di melanzane, patate, pomodori, peperoni ed erbe aromatiche, la kupati, una salsiccia molto speziata, l’ojakuri, uno stufato di carne e patate, servite a mo’ di tapas. Il banchetto in Georgia è un’istituzione e in quanto tale ha delle regole ben definite. Prima di sedersi a tavola bisogna scegliere un tamada, ovvero un commensale che ha il compito di animare l’incontro. Usando le parole di Gorecki, a cui rimando se qualcuno volesse approfondire questo curioso aspetto, che mostra appieno lo spirito georgiano: «la tavolata georgiana è qualcosa di più di una semplice tavola: è perfino qualcosa di più di una tavola sovraccarica di zuppiere, ciotole, vassoi, insalatiere, salsiere, fiaschi, damigiane, caraffe e brocche. È qualcosa di più di un gruppo di ospiti riuniti intorno a un mobile: può svolgersi all’aperto e, al limite, anche in uno scompartimento ferroviario. È un banchetto svolto secondo un ordine prestabilito, uno spettacolo dove ciascuno recita la sua parte, un rito, un’istituzione sociale. Anima della tavolata, suo conduttore, è il tamada. È lui ad annunciare i successivi brindisi, è lui a dare la parola ai convitati e a imprimere il ritmo al convito. Accomuna tra loro i convenuti e bada a che tutti si sentano a proprio agio».
«Il Kakheti sapeva di pace. Meno monumentale che in Megrelia, i villaggi fittamente inseriti nel paesaggio collinoso vi apparivano più famigliari, più popolosi e più allegri. La strada serpeggiava al ritmo dei meandri del fiume, invisibile dietro alle case; i galli cantavano; intorno alle abitazioni scorrazzavano oche e maiali pezzati. Le fontane lungo la strada sembravano piccole cappelle», scriveva sempre il giornalista polacco passando per la stessa strada che stiamo percorrendo ora. Le vigne ci accompagnano per molti chilometri, sino a quando superiamo il villaggio di Sagarejo, dove invece di proseguire verso est e raggiungere Telavi e Sighnaghi, le città più importanti della regione, svoltiamo a sud sulla strada che porta in Azerbaigian. A quel punto le case scompaiono, così come le colline, le vigne e qualsiasi altro tipo di vegetazione. A destra e a sinistra della carreggiata, solo coltivazioni di noci e ogni tanto girasoli. A interrompere la monotonia dei filari piantati nella terra senza un filo d’erba, qualche piccolo casolare, un mulino o un container finiscono per fare assomigliare questi luoghi all’immagine che ho degli stati centrali dell’America: Oklahoma, Kentucky, Ohio o Tennessee. Dopo qualche minuto attraversiamo il paesino di Udabno, che conferma questa mia impressione. Vi sono più mucche che abitanti, poche costruzioni, di cui due sono un ristorante e un negozio di alimentari, dove fanno tappa i turisti diretti a Davit Gareja, e le altre tutte aziende agricole con stalla e granaio. Mentre superiamo il gruppetto di case vedo un ragazzino che circola sulla strada sterrata e polverosa con una bicicletta blu scassata. Mi immagino quale possa essere il suo futuro. Rimarrà qui, sposerà una coetanea del posto e, come suo padre, farà l’allevatore e il contadino oppure andrà via e si lascerà tutto questo alle spalle? Dopotutto, solo a un’ora e mezza di auto sta Tbilisi e di lì il mondo intero.
Appena superato Udabno, i campi spariscono lasciando il posto a un deserto roccioso e inospitale che ricorda in maniera impressionante il paesaggio lunare: Davit Gareja non deve essere lontana.
Davit Gareja è il nome di un complesso monastico che sorge al confine fra Georgia e Azerbaigian e prende il nome da uno dei tredici Padri siriani asceti che nel VI secolo dal Medio Oriente arrivarono in Georgia a predicare il Cristianesimo. Questa figura, a metà fra lo storico e il mitologico, è fra le più amate dai Georgiani, assieme a Santa Nino, Davit il costruttore e la regina Tamar. «Gli Azeri dicono che Davit è più azero che georgiano, ma non ha senso, loro sono mussulmani e lui cristiano. Deve per forza essere georgiano», spiega la guida, irritata per quello che lui, come tutti i suoi connazionali, ritiene un tentativo di appropriazione indebita. La leggenda vuole che abbia compiuto vari miracoli, il più celebre dei quali racconta che, mentre predicava in una città, una donna aveva dichiarato pubblicamente di essere rimasta incinta di lui, quando in realtà il padre era un garzone con cui la ragazza aveva una relazione clandestina. Questo aveva suscitato grande scandalo tra i fedeli, che mai si sarebbero aspettati che Davit, il quale predicava astinenza, cedesse ai piaceri della carne. Il santo negò le accuse, ma senza prove la sua credibilità era a rischio. Un giorno Davit vide la giovane che lo stava calunniando, le si avvicinò e le toccò il ventre. In quell’istante il bambino si trasformò in una pietra che la donna avrebbe partorito di lì a poco e che ancora si trova nel museo della Georgia, a Tbilisi, in fronte al vecchio Parlamento.
Quel che è certo è che il santo fondò il nucleo originario del monastero di Lavra, ovvero “eremitaggio”, che i discepoli poi espansero, scavando nella roccia altre celle e portando il complesso alla grandezza attuale: dodici monasteri disseminati in un’area di 25 km quadrati. Il colpo d’occhio è notevole. Dall’entrata, posta ai piedi della montagna, si vedono le celle che spuntano dalla terra senza uno schema preciso, scavate nella roccia in gruppi di cinque o sei.
Alle spalle, la desolazione desertica del paesaggio lunare, davanti, i tre piani del monastero di Lavra, che fa da porta al complesso. Da un lato un costone di roccia nel quale sono state incavate le celle, dall’altro la chiesa e altri alloggi, circondano un piccolo cortiletto dove crescono due piante di melograno che fanno ombra alla lapide del santo, seppellito proprio sotto i nostri piedi.
Salendo sulla montagna per raggiungere l’altro monastero visitabile, quello di Udabno, basta guardarsi intorno per capire come mai Davit abbia costruito proprio in questo luogo isolato e impervio un monastero. Anche qui, come già a Kazbegi, ma in maniera totalmente differente, si riesce a sentire il soffio divino. Terry, che sembra intercettare i miei pensieri, si volta e dice: «Se non trovi Dio qui, lontano da tutto…».
Continuiamo a salire e finalmente giungiamo sulla cresta: alle nostre spalle c’è la Georgia, di fronte a noi l’Azerbaigian. A questo punto vorremmo proseguire verso il monastero di Udabno, ma due militari azeri, mitra alla mano, ce lo impediscono. Non è possibile raggiungerlo, ci dicono, perché è territorio azero. La guida ci aveva avvertito: siccome non vi è un confine preciso fra le due nazioni, diverse truppe pattugliano la cima della montagna. Alcune lasciano passare i turisti e altre no. A questo punto non ci resta che fare una passeggiata sulla cresta, introducendoci in alcune celle sparse sul crinale, con il rammarico che arrivare un paio di ore prima o dopo ci avrebbe permesso di trovare due guardie più affabili e di vedere il monastero con i suoi celebri affreschi.
Dopo un giro di due ore sotto il sole di mezzogiorno, decidiamo di tornare a Tbilisi. Purtroppo siamo tutti stanchi e durante il viaggio di ritorno la conversazione latita, per cui l’autista decide di deliziarci con una pessima compilation di musica pop russa. Il viaggio diventa così eterno e neanche provando a dormire passa più in fretta. Dopo quattro ore che sono parse durare quattro giorni, arriviamo finalmente a Tbilisi.
Lì, prima di cenare, decidiamo di andare a visitare un’altra chiesa (tanto per cambiare), che si trova leggermente fuori dal centro città, nella zona ad est del Mtkvari. Per arrivarci si attraversa un quartiere esterno rispetto al centro storico e piuttosto povero, a giudicare dalle case dimesse e dalla strada polverosa. I palazzi sono di cemento, il cui grigio sporco trasuda trascuratezza, e le imposte marroni sono stinte dagli anni e dall’incuria. Tutto ciò a pochi metri dal monumento più opulento del paese.
“Imponente” è l’unico aggettivo che viene alla mente quando ci si trova di fronte alla cattedrale di Tsminda Sameba, omonima di quella, più famosa, di Kazbegi. Grazie ai suoi 84 metri e alla copertura dorata spicca sullo skyline di Tbilisi come la torre Eiffel su quello di Parigi; da ogni punto della città è possibile vederla. Solo quando la si fronteggia però si può coglierne la vera magnificenza. Qui tutto è fatto per colpire il visitatore, a partire dal sito stesso su cui sorge, ovvero in cima alla collina di Elia, da cui si domina l’intera città. È stata una scelta controversa, scopro poi, perché per costruire la chiesa è stato necessario demolire e spostare un cimitero armeno.

Sulla collina sorge una cittadella che, per la sua simmetria nelle architetture, la pulizia, l’ingresso trionfale, con croci poste su colonne che incorniciano la via per la cattedrale, fontane, giardini curatissimi e piscine, mi ricorda le residenze sabaude di Torino, come Venaria. A confermare che ci troviamo in un luogo sacro, come se ci potessero essere dubbi, con la monumentale cattedrale in fronte, chiese e cappelle sparse costeggiano il perimetro dell’area. Sempre ai lati della chiesa, un elemento ci ricorda che siamo in Georgia: una casetta molto umile, dalle mura bianche e scrostate, un piccolo orto e i panni a stendere su un filo. Anche nel momento di massimo splendore e modernità, spunta qualcosa che richiama la semplice praticità di questo popolo e il suo tenersi stretto alle proprie radici.
A dominare è il colore bianco. Bianca la strada e le scale che separano la chiesa dall’ingresso; bianche le chiese e cappelle ai lati; bianche le colonne sulle cui cime splendono le croci in ferro; bianca la piazza antistante la chiesa, tanto vasta che già prima di entrare nell’edificio ti senti minuscolo e insignificante.
L’interno colpisce, se possibile, anche di più. La ripetizione dello schema classico dell’architettura religiosa georgiana, per cui tante parti introduttive sono sovrapposte prima della centrale area campanaria, ha permesso non solo a questa chiesa di raggiungere un’altezza vertiginosa, ma anche di avere una forma molto allungata, invece della classica quadrata. Per il resto, l’interno è molto simile alle altre chiese che abbiamo visto: le titaniche colonne che separano le cinque navate sono colme di quadri di foggia bizantina raffiguranti santi che – lo vedo per la prima volta – i fedeli baciano tre volte recitando nenie ripetitive e facendosi tre volte il segno della croce alla maniera georgiana, ovvero passando la mano prima a destra e poi a sinistra del petto prima di chiuderle nell’amen. Noto inoltre solo ora come tanti fedeli siano anche miei coetanei o comunque giovani sui 30-35 anni, ulteriore testimonianza di come la religione sia una parte centrale dell’identità di un Georgiano.
Sopra la sezione dedicata all’officiante, un gigantesco affresco che raffigura Cristo, in abito blu e nell’atto di benedire, attrae tutti gli sguardi, sfidando la penombra. Una parte del fascino dell’interno di Tsminda Sameba è data, infatti, dal fatto che i primi tre metri sono molto illuminati, da lampadari elettrici e dalle onnipresenti candele, qui in numero elevatissimo, mentre la restante parte è completamente buia.
Per tornare in centro attraversiamo il ponte Baratashvili, appena a Nord rispetto a quello della pace. Dedicato al poeta romantico Nikoloz Baratashvili, le sue ringhiere sono decorate con figure bronzee a grandezza naturale molto stilizzate di uomini e di donne nelle più varie posizioni: due innamorati si fissano, un uomo si getta nel fiume mentre i passanti cercano di fermarlo, tre amiche passeggiano. Una piccola chicca che, per qualche strana ragione, non viene segnalata su nessuna guida.
Mtshketa, 14 luglio
Nel nostro ultimo giorno a Tbilisi decidiamo di andare a Mtskheta, antica capitale della Georgia le cui chiese – e cosa sennò? – sono entrate nel 1994 a far parte dell’UNESCO come patrimoni dell’umanità. Proprio da qui iniziò la cristianizzazione del paese ad opera di Santa Nino. Da ragazza viveva a Gerusalemme e a 12 anni entrò sotto la protezione della guardiana del tempio Miapori, che le raccontò la vera storia della tunica che Cristo indossò durante la passione: questa era stata consegnata a un gruppo di Ebrei di Mtskheta andati in pellegrinaggio a Gerusalemme i quali la riportarono nella loro città natale. Nino allora partì alla sua ricerca e, giunta in Georgia, predicò la vera fede facendo miracoli e curando i malati, fra cui Nana, la regina del Kartli, regno della Georgia orientale, che riuscì a convertire. Il re Mirian, suo sposo, invece non voleva accogliere la nuova religione predicata da Nino, preferendo gli idoli pagani adorati dai suoi padri. Un giorno però, durante una battuta di caccia, si ritrovò perduto e schiacciato dall’oscurità del bosco. Pregò i suoi dei affinché gli dessero la luce necessaria per ritrovare la strada di casa, ma nulla accadde. Allora si ricordò di quel Dio predicato dalla santa: lo pregò e la luce tornò, permettendogli di tornare a casa, dove si convertì.
Mtskheta oggi è una piccola cittadina a mezz’ora di marshrutka dalla capitale, a partire dalla stazione dei bus di Didube. Per raggiungerla prendiamo la metro da Rustaveli gamziri, vicino a Liberty Square. Arriviamo al livello sotterraneo dei treni passando su due scale mobili molto lunghe e veloci, tanto che bisogna fare attenzione a scendere. Terry ed io abbiamo rischiato di lasciarci più volte le caviglie. A compensare la velocità delle scale mobili arriva puntuale la lentezza della metro, che in oltre venti minuti ci porta a destinazione. Da notare, come per i sottopassi, come vi siano un ordine e una pulizia svizzeri, che colpiscono in un paese la cui popolazione sembra animata quasi esclusivamente da un indolente pressapochismo, per nulla fastidioso, mi si intenda, quanto piuttosto curioso e caratteristico. Varie volte durante il viaggio ho visto gruppi di cinque o sei cantonieri e muratori che lavoravano a turno: uno lavorava e gli altri lo guardavano, chiacchieravano fra loro o fumavano sigarette, sino a che il lavoratore non si stancava e un altro gli dava il cambio. Metro e sottopassaggi, poi, sono fra i primi posti a imbruttirsi nelle città in via di sviluppo. Il fatto che qui non sia successo dà una qualche speranza per il futuro del paese.
Non regala nessuna speranza, invece, la stazione degli autobus di Didube, dove il caos e il rumore non sono cambiati dalla nostra prima visita: per trovare il nostro autobus facciamo un giro e mezzo di tutta l’area e, chiedendo indicazioni, riceviamo risposte contrastanti: «Vai tutto in fondo e lo trovi sulla destra», «Ma no, no appena dietro la biglietteria, nel centro», «Mi spiace, dovete tornare indietro, da qui partono quelle per Batumi» etc. Rispetto a qualche giorno fa però siamo meno intimiditi e alla fine riusciamo a prendere la marshrutka. Rimane comunque incredibile che un luogo tanto caotico sia così vicino al centro di Tbilisi, tutto infiocchettato: sembra di essere in un altro continente.
Ripercorriamo la strada fatta per andare a Kazbegi, attraversando la periferia nord della città, ma, invece di continuare dritto, a un certo punto giriamo a destra e in tal modo raggiungiamo Mtshketa.
La marshrutka ci lascia di fronte alla chiesa di Samtavro, un complesso religioso il cui nome deriva dal georgiano mtavari che significa “luogo del sovrano”. Oltre alla chiesa ci sono diverse cappelle, un museo e un dormitorio per monaci, che scopro poi essere il principale seminario teologico della Chiesa ortodossa georgiana La leggenda vuole che una delle piccole cappelle laterali, nucleo originario del complesso, sia stata costruita dal re Mirian in onore di Santa Nino.
L’edificio principale è però la chiesa del Redentore, dell’XI secolo, dove sono stati sepolti Nana e Mirian. La chiesa ha il classico colore ocra dell’architettura georgiana e sembra molto più moderna di quanto non sia. Siccome oggi è domenica, entrando ci imbattiamo in una messa, la più partecipata fra tutte quelle viste nei dieci giorni di viaggio e non credo sia una coincidenza, dal momento che ci troviamo nella chiesa meno turistica della città. È quasi impossibile muoversi e vi ritroviamo, fermi in piedi, tutti i Georgiani che avevano preso la marshrutka con noi, a partire dalla nostra vicina, una ragazza giovanissima che accarezza spesso il suo pancione, che porta fiera.
Ben più celebre è invece la cattedrale di Svetiskhoveli, la chiesa più importante di tutta la Georgia, dove ancora oggi il capo della chiesa autocefala georgiana, il Katholikos Pangeorgiano, celebra le funzioni. Anche qui, come nella cattedrale di Tsminda Sameba, un muro di cinta separa l’area della chiesa dal resto della città. Lì, oltre all’edificio sacro, si trovano le solite cappelle votive, qualche campanile e un piccolo tappeto erboso che circonda l’area. Con la gigantesca chiesa tbilisina, Svetiskhoveli condivide anche la forma allungata, ma non l’altezza spropositata: «la chiesa fu costruita dall’architetto Arsukidze e dopo che l’ebbe costruita, si racconta, lo zar gli fece mozzare la mano, in modo da non poter superare sé stesso con opere più belle», spiega a un gruppo di Francesi una guida, che continua: «prima della chiesa attuale ve ne fu un’altra, voluta da Santa Nino nel IV secolo. La leggenda vuole che quando si scolpì da un cedro una colonna per la chiesa, questa iniziò a fluttuare nell’aria. Tutti furono spaventati dal prodigio, tranne la santa, che radunò dodici donne e pregò per una settimana sotto la colonna volante. Alla fine dei sette giorni, questa scese a terra e si posò da sola nel sito in cui sarebbe poi nata la chiesa. Si capì allora che lì era stata sepolta la tunica di Cristo, artefice del miracolo. Per secoli poi la colonna fu legata a miracoli, molti di guarigione, e da qui deriva il nome: Svetiskhoveli significa infatti “colonna che dà la vita”».
Entriamo quindi nella chiesa, per sfuggire alla calca di turisti che inizia ad affluire, e ci imbattiamo in un’altra messa. L’officiante e il coro stanno cantando mentre i fedeli sono ritti in religioso silenzio. A Terry e a me viene la pelle d’oca. La chiesa, poco illuminata, con una minuscola fenditura dietro la “sagrestia” come principale fonte di luce, obbliga il visitatore ad acuire gli altri sensi, scatenando così tutta la potenza del canto. L’acustica della cattedrale è infatti perfetta: Svetishkoveli è una chiesa da visitare con le orecchie, prima che con gli occhi.
Ci allontaniamo allora da Mtshketa per dirigerci verso la chiesa di Jvari, situata su una collinetta di fronte alla città. Lasciandola, realizzo che non ho percepito la stessa spiritualità respirata a Davit Gareja o a Kazbegi. Mtshketa è, piuttosto, il cuore storico e identitario di una Georgia che, come già detto, per tanti secoli della sua storia ha avuto sempre la religione a differenziarla dai suoi conquistatori: Arabi, Persiani o Russi. Non si sente tanto la presenza di Dio fra le mura delle chiese, ma risuona forte lo spirito dei Georgiani, il loro orgoglio per la propria tradizione e la propria storia, di cui questa cittadina è l’ipostasi. Mai nel mio viaggio ho visto tanti fedeli a messa cantare insieme e sentirsi parte di una sola cosa come qui, l’unica città dove i Georgiani possono ricordarsi di essere stati grandi.
La chiesa di Jvari sorge sul luogo in cui il re Mirian – chi altri se non lui? – fece erigere una croce dopo essere stato convertito da Santa Nino al Cristianesimo. Jvari in georgiano vuol dire appunto croce. L’edificio è a pianta ottagonale e la simmetria domina anche nell’interno circolare, con una croce al centro. Dalla collinetta su cui sorge si ha un panorama unico, con la città di Mtshketa incuneata alla confluenza dei fiumi Mtkvari e Aragvi.
È il primo luogo in cui soffro la presenza dei turisti, decisamente troppi per un sito non più grande di un chilometro quadrato, compresi il piccolo giardino circostante e la scalinata che porta alla chiesa dal parcheggio.
Tornati a Tbilisi, decidiamo di visitare il più grande mercato della Georgia, che si trova di fronte alla stazione. Il desertirebis bazari, ovvero mercato dei disertori, prende il nome dai disertori che negli anni ’20 vendevano qui le proprie armi. Col tempo è diventato zona di mercato, tanto che la municipalità di Tbilisi, per evitare l’agglomerarsi di banchetti in mezzo a piazze e strade cittadine, ha deciso di costruire un grosso hangar dove i commercianti avrebbero potuto stabilirsi. Gran parte di questi, però, non volendo pagare per avere il posto all’interno, non si è spostata dalla piazza o dalla strada, continuando a congestionare il traffico. Un giro nel mercato, grande come un isolato, mostra come con taciti accordi si siano suddivisi perfettamente l’area. Sotto i portici puoi trovare i macellai, con i polli spiumati ma interi in bella vista dietro le teche, nella piazza antistante l’hangar ci sono i contadini che vendono frutta e verdura, con camion carichi di angurie posteggiati accanto al banchetto, mentre nella zona Nord si vendono latticini, pane, khachapuri, lobiani e i tipici dolci georgiani. Nella via che fronteggia la stazione, invece, vi sono solamente negozi di ottici, il che mi colpisce. Già a Kutaisi e nelle altre zone di Tbilisi abbiamo trovato tanti negozi di questo tipo. Possibile che ci sia un mercato tanto grande di occhiali in Georgia?
Al desertirebis compriamo qualche pesca per il pranzo e più tardi andiamo a visitare il mercato del ponte secco, ovvero un mercato di antiquariato che si trova appena più a nord del ponte della pace, sulla sponda ovest del Mtkvari. Per raggiungerlo, bisogna superare un ponte che sovrasta non un fiume, ma una strada molto trafficata, il ponte secco da cui prende il nome. Scrive Gorecki che un tempo qui si poteva trovare di tutto, «dalle posate Fraget al pugnale ceceno, dall’icona georgiana in rame ai pezzi di ricambio del televisore Elektronika VL-1000 […], dall’ombrello in quasi buono stato ai cd musicali piratati e agli ancor più piratati programmi per computer», ma che da anni è diventato un mercatino delle pulci in cui scovare qualche chincaglieria o pezzi di mobilio. La mia delusione è tanta quando arrivando trovo un grosso parco colmo di venditori di cornici e tele che ritraggono Tbilisi o la Georgia. Pensavo di visitare un mercatino dell’antiquariato popolato da Georgiani che contrattano sul prezzo e mi trovo invece in un hotspot per turisti in cerca di un souvenir più sofisticato del magnete che offre il negozio in centro. Con Terry faccio un giro per le vie ammirando i quadri: alcuni sono veramente ben fatti, per carità, ma io mi aspettavo tutt’altro.
Dopo un pomeriggio di shopping per Terry e di riposo e letture per me, andiamo in stazione centrale per prendere il treno-notte che porta a Zugdidi, da cui prenderemo una marshrutka per Mestia, nello Svaneti. Come all’andata, il treno è lentissimo: meno di trecento chilometri in otto ore, ma almeno questa volta si potrà dormire nelle cuccette, quattro per scomparto. Alle 21:45 partiamo, lasciando ormai col buio la periferia di Tbilisi, una città fuori dal tempo. Come tutte le capitali è ormai, specie nelle aree più periferiche, il trionfo del cemento e dell’asfalto, e anche il centro cittadino sfoggia molte costruzioni post moderne volte a mostrare come Tbilisi sia una moderna città europea (un pensiero comune nelle repubbliche meridionali dell’ex Unione Sovietica, come dimostra Astana, in Kazakistan, una delle città più moderne del globo). Ciononostante si può vedere in ogni angolo di Tbilisi, in ogni suo atto, il modo georgiano di fare le cose, un po’ bonario e con quella capacità di adattarsi e sbrigarsela che caratterizza lo spirito mediterraneo. Ne è un esempio la torre dell’orologio, moderna ma dal sapore tutto caucasico, come le statue di Japaridze sul ponte Baratashvili o la casetta di campagna costruita all’ombra di Tsminda Sameba.
Rimane però una grande verità: dietro di me lascio una città che, per correre dietro al futuro, sta abbandonando il suo passato, senza riuscirci però completamente. Ciò era già successo due secoli fa d’altronde, quando la conquista russa privò la Georgia, e soprattutto Tbilisi, della sua metà asiatica, interrompendo i contatti con il Medio Oriente. Come allora, il popolo georgiano, per abbracciare la modernità, che a quel tempo era incarnata nel potere forte e riformista dello zar, ha voltato le spalle al suo passato, ma questo ha resistito, non solo nell’architettura, ma anche nell’arte, nella poesia e nei tanti modi di fare di cui i Georgiani hanno cercato invano di sbarazzarsi. Così resisterà, pe quanto sia forte la volontà dei governi di allontanarsene, anche la Tbilisi che Terzani solo vent’anni fa vedeva dalla sua finestra, che era «come il sogno di una città: le rovine di un antico castello, la guglia di un vecchio campanile, le case attaccate alla roccia come fossero nidi di aquile giganti, gli intarsi di legno, come merletti che ornano i balconi delle eleganti residenze lungo il fiume. Una gioia trovarsi dinanzi alla diversità della fantasia, dinanzi a una città che ogni volta ha saputo rinnovarsi sulle rovine della precedente!»
Attorno a questo nucleo però già incombono i palazzi tutti uguali della periferia. «Come il resto delle zone meridionali dell’Impero, anche la Georgia ha adottato il modello di sviluppo tipico di tutti i paesi del Terzo Mondo, che consiste nella forzata e innaturale crescita edilizia della capitale» scriveva trent’anni fa Kapuscinski. Ora la situazione non è più tanto greve, ma è indubbio che la spinta verso la modernità è in forte contrasto con l’orgoglio georgiano per la propria cultura e storia. In questo insanabile contrasto sta, oggi, il cuore di Tbilisi, cartina di tornasole dell’intero paese.
Mestia, 15 luglio
Il treno arriva a Zugdidi alle 6:05 del mattino, in perfetto orario. Ad aspettarci sulla banchina della stazione una decina fra tassisti e autisti di marshrutka che urlano a gran voce «Mestia! Mestia!». Terry ed io guardiamo queste ultime cercandone una quasi piena. In Georgia è normale che il pullman non parta sino a che non ha riempito i suoi posti e non abbiamo nessuna voglia di rimanere bloccati per chissà quanto tempo qui. Finalmente ne troviamo una e ci catapultiamo sopra.
Se – lo scriveva Gorecki – il Kakheti è riconducibile alla Toscana, la Svaneti è la Sicilia. Più che la Sicilia a me ricorda la regione greca del Mani, nella parte più meridionale del Peloponneso, stretto fra Laconia e Messenia. Entrambe le regioni, ad esempio, si gloriano di non essere mai state conquistate da nessuno e in ambedue i luoghi la natura è selvaggia. Rocce brulle e una terra arida e secca caratterizzano quella greca, un insieme di valichi e creste difficili da superare, specialmente in inverno con la neve, quella dello Svaneti. A noi che arriviamo in estate la vegetazione appare lussureggiante, con pascoli per le mucche e tanti campi coltivati. La neve sulla punta delle cime più alte, che in questa stagione ho trovato solo qui, pur essendo stato ai piedi di un 5000, fa presagire come in inverno l’intera zona sia isolata dal resto del mondo.
Pochi chilometri oltre il villaggio di Mestia, dove ci fermiamo, c’è il villaggio di Ushguli, che dall’alto dei suoi 2100 metri di altezza è il più alto insediamento permanente d’Europa, irraggiungibile da settembre sino allo scioglimento della neve, a metà primavera. Passeggiando per Mestia ho l’impressione di essere in un luogo molto diverso da quelli visitati sinora. È vero che la meta è molto turistica, soprattutto per gli amanti dell’alpinismo o dei trekking in montagna, dato che da Mestia partono infiniti sentieri che portano a laghi dai colori surreali o in cima a montagne da cui si ha l’impressione di essere sul tetto del mondo. Ciononostante, lontano dalla via principale, si entra nella vita di una placida cittadina di montagna europea di inizio novecento. Le guest house spariscono per lasciare posto alle stalle dove cani arrabbiati abbaiano dietro a portoni cigolanti e arrugginiti, mentre le galline alle loro spalle beccano in una piccola aia con anatre e oche. Le mucche camminano tranquillamente per le strade, nessuna delle quali è asfaltata, tranne la principale, cercando di rubare le mele a un banchetto improvvisato dove una signora anziana vende frutta e verdura. Sembra di vedere la valle d’Aosta del secolo scorso, riflessa in uno specchio deformante.
Appena superati i confini del villaggio, ecco la natura a reclamare il suo spazio: basta attraversare un piccolo torrente per trovarsi in un bosco, da dove, salendo per poche centinaia di metri, si è in uno spiazzo da cui si può ammirare dall’alto il paese e pranzare a pane e pomodori.
Il secondo elemento che mi ricorda il Mani è la presenza delle torri. Il paesaggio dello Svaneti è infatti punteggiato di queste costruzioni di pietra dalla muratura spessa: «le dimensioni variano dall’una all’altra, ma sono alte solitamente una decina di metri e alla base hanno un quadrato di 4 metri per lato», ci spiega il monaco di un piccolo monastero costruito accanto ad una di esse, contento di sfoggiare la sua erudizione. Ci dice di essere di Tbilisi, ma di essersi fermato in questo luogo dopo essersene innamorato. Gli spiego allora che queste costruzioni me ne ricordano alcune che ho trovato nella Grecia continentale. Lì erano state costruite dalle varie famiglie che si dividevano il controllo del territorio ed erano implicate in mortali faide con i vicini: le torri servivano per nascondervisi e provare ad uccidere i membri della famiglia rivale.
«Oh no! No no no, qui le torri erano fatte per protezione, non per uccidere», ci spiega il monaco, sbiancato al mio racconto. «Lo Svaneti era la regione da cui entravano in Georgia gli eserciti provenienti da nord e perciò gli abitanti, stufi delle continue invasioni, costruirono queste torri inespugnabili per proteggersi durante il passaggio delle truppe e nascondere i beni e gli ori che possedevano. Questa qui», dice indicando la torre che sorge a lato del monastero, «era dedicata a nascondere tutti i monaci, i paramenti religiosi, le croci e gli altri oggetti preziosi della chiesa».
“Una natura selvaggia fa uomini selvaggi”, riflettiamo tornando verso casa dalla nostra passeggiata a Mestia e negli immediati dintorni. Gli abitanti del luogo infatti non sono loquaci, privi di quella sbruffoneggiante joie de vivre dei Georgiani incontrati sinora; sono uomini di montagna, chiusi, schivi e circospetti. Non vedono di buon occhio i turisti che, ogni anno di più, con un’impennata da quando è in funzione a Mestia un aeroporto che la collega con Tbilisi e Kutaisi, visitano la zona. Persino i tassisti, che nel resto del paese in tutti i modi cercano di convincerti a salire sul loro taxi finché non cedi, qui vengono una sola volta, quasi malvolentieri, a chiederti se vuoi un passaggio per Ushguli. A una risposta negativa, metà tirano un sospiro di sollievo, mentre gli altri grugniscono offesi, come se ti avessero fatto un favore a venire da te e tu li avessi rifiutati maleducatamente. Impossibile non amarli.
Da Mestia ad Akhaltsikhe, 16 luglio
Lasciamo Mestia il giorno dopo il nostro arrivo, alle 8 del mattino, con l’unica marshrutka giornaliera, partendo per Kutaisi, da dove ne prenderemo un’altra che ci porterà ad Akhaltsikhe, nel Sud, vicino al confine turco. Dovremmo arrivare per le 17. La stazione di Kutaisi è più piccola e decisamente meno intimidatoria rispetto a quella di Didube. Le persone sono cordiali e ci aiutano a trovare il nostro mezzo ancor prima che gli chiediamo aiuto: una bella differenza rispetto ai tbilisini che urlavano e ti strattonavano pur di venderti un passaggio in macchina. Veniamo accompagnati vicino alla marsrutka che dobbiamo prendere, l’ultima delle tre giornaliere che da Kutaisi partono per Akhaltsikhe, e vediamo che tutti i posti sono occupati. «No problem» ci dice l’autista, che da sotto un sedile estrae tre sgabelli di legno, spiegandoci che possiamo sederci lì se la cosa non ci disturba. A noi va benissimo e allora l’autista incastra gli sgabelli nel piccolo corridoio. Alla fine qualche passeggero inspiegabilmente se ne va e così riusciamo a trovare due posti leggermente più comodi, anche se la vecchiaia di questi mezzi rende poco comodi anche i sedili, la cui imbottitura è solo un ricordo lontano. Ci prepariamo a partire quando sopraggiungono altri passeggeri. L’autista ferma il mezzo, scende e posiziona di nuovo gli sgabelli per i nuovi arrivati, che però sono più dei posti disponibili sugli sgabelli. L’autista allora, con una vis da consumato attore teatrale, convince una mamma con tre figli a tenerne due in braccio, per fare posto ai signori. La ragazza accetta con una smorfia scocciata, ma siamo finalmente pronti a partire.
Siamo in 24 su un pullmino pensato per 18 persone. Fa caldo e i posti vicini ai finestrini sono occupati da anziani che non li aprono per paura dei colpi d’aria. L’arrivo è previsto fra quattro ore, ma l’unico pensiero che ci fa andare avanti, in quello che non si può chiamare altrimenti che un “viaggio della speranza”, è la possibilità che molti scendano a Borjomi, l’altra fermata della tratta, fra “sole” tre ore.
Borjomi, dopo Gori e il vicino sito di Uplistikhe, è il secondo grande assente del nostro viaggio in Georgia, dovuto a pura mancanza di tempo. Quel poco che so della città è che è stata riqualificata molto durante il periodo sovietico, in cui i russi erano soliti visitarla specialmente per le sorgenti termali. Oggi è conosciuta soprattutto per l’acqua minerale frizzante che qui producono. Dal finestrino della marshrutka si presenta come una cittadina piacevole, circondata dal verde e attraversata dalle acque di mille sorgenti.
Fortunatamente, come sperato, tanti scendono alla fermata. Finalmente, dopo tre ore di caldo torrido su di un autobus troppo affollato, possiamo fare un’ora di viaggio in completa comodità, riuscendo addirittura ad allungare le gambe, a cui avevo perso la sensibilità. Anche gli anziani che tenevano in ostaggio i finestrini sono scesi, perciò possiamo aprirli, facendo entrare un po’ di aria fresca: una sensazione divina.
Akhaltsikhe è il capoluogo del Samtskhe-Javakheti, regione meridionale della Georgia che confina con la Turchia e l’Armenia, come è evidente dalla composizione degli abitanti: secondo il censimento del 2017 infatti il 50,52% della popolazione è armeno. La città di Akhaltiskhe in sé si trova invece molto più vicina alla Turchia, a soli 18 chilometri dal confine. Siamo in provincia e la vita, senza gli eccessi di sfarzo e di miseria che caratterizzano le grandi città, scorre placida. È il luogo dove, se fossi georgiano, vorrei far crescere i miei figli. Moderna, ma attaccata alle origini rurali – ogni casa ha un piccolo orto coltivato -, con ragazzini che giocano nelle aree verdi attrezzate, anziani che giocano a scacchi o backgammon nel parco o confabulano sulle panchine e adolescenti che giocano a fare i grandi, imitando ridicolmente il modo di fare e di vestirsi dei loro coetanei americani e lamentandosi del fatto che «la sera ad Akhaltiskhe non c’è nulla da fare: meglio vivere a Londra, Los Angeles o New York». La provincia è uguale un po’ dappertutto.
Non si respira la storia passeggiando ad Akhaltiskhe. Nessun edificio storico, escludendo il castello di Rabati, anche lui del resto molto modernizzato, e nessuna rovina. Anche le chiese sono tutte contemporanee.
Qui si trova però, a detta di molti Georgiani, l’unica statua della regina Tamar, in un piccolo spiazzo circondato da panchine su cui siedono gli anziani e alla cui ombra si riposano i cani randagi. Proseguendo, per la strada si trova una statua – certamente non l’unica nel paese – del poeta Rustaveli, che alla corte della regina Tamar visse e scrisse il suo capolavoro. Solo in questa cittadina, dunque, lontano dai principali poli turistici o dalle città più importanti, si sono ricongiunti i due vecchi amici, pilastri della georgianità, orgoglio di un paese che troppo spesso ha dovuto rivolgersi al suo passato per non fissare il giogo che nel presente lo opprimeva.
Vardzia, 17 luglio
Da Akhaltsikhe, risalendo il corso del Mtkvari, il Mekong del Caucaso, si giunge a Vardzia, il monumento più iconico della Georgia. La valle del Mtkvari, oltre a colpire per la sua grande biodiversità di flora e fauna – solo dalla macchina in corsa si possono scorgere diverse specie di uccelli e piccoli mammiferi -, è costeggiata da tanti siti storici, artistici o religiosi che meritano una fermata. Partiamo così la mattina presto con Mehrab, un tassista conosciuto la sera prima, un tipo curioso, molto gentile e disponibile, che per la colorazione olivastra della pelle parrebbe armeno, ma che come tutti i Georgiani si fa tre volte il segno della croce davanti a qualsiasi chiesa, edicola, cappella o cimitero che incontriamo sul percorso.
La prima fermata è il castello di Khertvisi. Posto alla confluenza dei fiumi Paravani e Mtkvari, su uno sperone di roccia da cui è possibile controllare la valle per molti chilometri a destra e a sinistra, questa fortezza è ora in rovina, ma le sue mura resistono salde e forti. L’interno è stato riconquistato dalla natura, con l’erba sempre ben tagliata dal giardiniere, che è anche bigliettaio e guida turistica all’occorrenza, ovvero quando riceve una piccola mancia. Anche le due torri, che si affacciano sulla valle, sono in ottimo stato, tanto che è possibile salirvici sopra e visitare la piccola cappella che ospitano. Stupisce lo stato di conservazione della fortezza, a maggior ragione se è vero che, come racconta la leggenda, questa fu fondata ben prima della venuta di Cristo; qualcuno dice che si sia fermato al suo cospetto persino Alessandro Magno. Quel che è certo è che fu costruita prima del X secolo, dato che le mura all’interno della chiesa riportano un’iscrizione del 985.
Proseguendo in direzione Sud, si incontrano poi due siti posti uno di fronte all’altro, separati solo dal fiume. A destra c’è il castello di Tmogvi, o, meglio, ciò che ne resta. Non rimane molto di quello che doveva essere un complesso colossale; i resti dei vari edifici che lo componevano, che occupano tutto l’enorme sperone roccioso, dalla cima sino quasi al fiume, su cui la fortezza era situata, danno l’idea di quanto fosse imponente. Non stupisce quindi che nei secoli sia stato ritenuto inespugnabile e solo il tempo e l’abbandono siano riusciti a vincerlo.
Di fronte, si trova Vanis Qvabebi, un sito monastico scavato nella roccia, molto simile a quello di Vardzia, anche se più piccolo, meno celebre e meno visitato. Non capiamo perché, ma una guardia che si trova all’entrata, un centinaio di metri sotto le celle scavate nella roccia, ci dice che non è possibile salire, come d’altronde già suggeriva la strada sbarrata. Non ci resta quindi che ammirare da lontano le celle e la chiesa, che si distingue molto bene anche dalla nostra postazione.
Finalmente arriviamo a Vardzia. Mehrab si ferma in un piccolo spiazzo da cui si ha un incredibile colpo d’occhio sulla città scavata nella roccia. Di fronte a noi abbiamo la montagna, per metà traforata da buchi, un ordito di cui non si riesce a cogliere la trama. Visto da qui non si può non chiedersi come qualcuno abbia anche solo potuto pensare di costruire in quel luogo un’intera città. Perché di un’intera città si tratta, con una precisa pianificazione, scelte “urbanistiche” e strade. Si sviluppa su 13 livelli, per un totale di 400 stanze, 13 chiese e 25 cantine per il vino. La sua costruzione risale al XII secolo ed è opera del re Giorgi III, che vi fece costruire una fortificazione. Sua figlia Tamar, cui toccò presiedere alla fine dei lavori, trasformò la fortificazione in un monastero dove, nel periodo di massimo splendore, arrivarono a vivere 2000 monaci. Sempre alla mitica regina si riconduce il nome del luogo. La leggenda vuole infatti che, durante una battuta di caccia con lo zio e la sua corte, Tamar si fosse persa nelle grotte. Lo zio iniziò a cercarla e alla domanda «dove sei, Tamar?» questa rispose «Sono qui zio», che in georgiano suona come “Aq var dzia”.
Non vedo l’ora di entrare in questo dedalo di cunicoli e celle, per poterne ammirare la complessità e coglierne il mistero. Pertanto rimango basito quando Mehrab, ad un incrocio, al posto di girare a destra, dove le indicazioni spiegano esserci l’entrata del sito, curva verso sinistra: «I take you to one place before», spiega timidamente. Dopo un paio di minuti, il taxi si ferma in un piccolo spiazzo sterrato. Siamo ad upper Vardzia, in un monastero di suore. L’atmosfera è surreale, ci troviamo in un luogo che pare isolato dal mondo e dalla folla di turisti che assale la città nella roccia, solo poche centinaia di metri più in basso. Qui, oltre a me, Terry e Mehrab, ci sono solo 4 suore, tutte molto giovani e minute, ricoperte di nero, con le solite vestaglie lunghe e il copricapo che nasconde i capelli. Tutto è ben curato e tenuto con amore e affetto, come la chiesa del IX secolo in cui le donne si riuniscono a pregare. A colpire di questo luogo – complice il nostro esserci arrivati presto la mattina, prima di altri visitatori – è la sensazione di calma e pace che si respira e il silenzio, enfatizzato, più che rotto, dai canti dei diversi uccelli fra le fronde dei rami.
Dopo una breve sosta nella pace del monastero, siamo pronti a rigettarci nell’abisso del turismo di massa, in direzione di Vardzia. Il complesso ha appena aperto, non sono ancora arrivate le prime marshrutke da Akhaltsikhe o Borjomi e di conseguenza il numero di turisti non è tanto alto da rovinare l’esperienza.
Vardzia è un labirinto di celle e cunicoli sotterranei dove, senza un guida che vi indica cosa avete di fronte, potete vagare per ore senza capire di essere in una vera città. In compenso, si riesce comunque a rimanere rapiti dalla resilienza di un popolo che ha scavato la roccia e costruito case e chiese in luoghi tanto impervi. Passeggiare poi fra le strette, basse e buie scalinate, salendo e scendendo piani come in un quadro di Escher, ti permette di immergerti nel passato, una sensazione che provo sempre più raramente visitando siti storici.
Non mi stupirei se in cima alla scalinata spuntasse un monaco medievale a intimarci il silenzio o semplicemente a riempire i corridoi del salmodiare lento e monotono della sua preghiera. Nei cunicoli interni, infatti, la voce degli altri visitatori, anche se lontani, rimbomba e rimbalza contro le pareti; non posso che immaginare come fosse in passato, quando al posto delle poche centinaia di turisti attuali c’erano due migliaia di monaci. I canti liturgici, intonati da un lato del complesso, con pazienza attraversavano i corridoi, permeandone l’aria e facendo venire la pelle d’oca a coloro che li percorrevano. Una parte del canto poi, rifranto dall’eco delle caverne, giungeva singolarmente in ogni singola cella, a bussare all’orecchio dei confratelli in preghiera.
Oltre all’esperienza unica di immergersi in un luogo che pare uscito dalla penna di George R. R. Martin, Vardzia regala anche un panorama spettacolare sulla valle e si può rimanere incantati dal volo degli uccelli, che a gruppi entrano veloci nelle grotte e ne escono altrettanto rapidamente, forse alla ricerca di un poco di frescura. Suggestiva anche la chiesa dell’Assunzione, l’edificio meglio conservato, il cui interno è tappezzato di bui affreschi, nodo centrale da cui si dipartono le principali strade della città incassata nella roccia.
Dopo due ore di vagabondaggi, scendiamo una lunga scala da cui, sbattendo la testa più volte di quanto dovremmo confessare, usciamo da Vardzia. Mehrab ci aspetta sorridente, interrompendo le chiacchiere con i suoi colleghi tassisti. Ci chiede: «Go home?». Annuiamo e partiamo.
Dopo aver superato la fortezza di Khertvisi, però, noto un cartello che segnala il monastero di Saro. Non ne ho sentito parlare in nessun libro o guida sulla Georgia, ma, spinto dalla curiosità, chiedo al nostro amico se può portarci anche lì. Lui acconsente ma, ci confessa, in tanti anni non ci è mai andato, quindi non sa come possa essere la strada.
Saro è stata forse la scoperta più bella dell’intero viaggio, unico villaggio di una Georgia autenticamente contadina, che disperavo ormai di trovare. Quando vi si giunge sembra di essere catapultati nell’Ottocento; l’unico elemento moderno che si incontra sono le carcasse di automobile lasciate ad arrugginire nell’aia. Per il resto, la strada è sterrata, con buona pace del nostro autista, e vi scorrazzano galline, oche e un paio di tacchini. Ai lati, case rovinate dall’usura e aggiustate alla bene e meglio e tettoie in lamiera abusive per proteggere il bestiame, perlopiù mucche e maiali, da pioggia e neve d’inverno e caldo d’estate. E, ancora, campi di grano e girasoli, oppure interi spazi già riconquistati dalla natura. Rispetto a Udabno, sulla strada per Davit Gareja, Saro è decisamente più selvaggio.
Attraversato il villaggio, si giunge poi alla fine della strada, di fronte ad un cancello di ferro arrugginito. Mehrab suona il clacson e due suore escono da un piccolo caseggiato per aprirci, mentre tacchini iniziano ad avvicinarsi alla macchina, fissando curiosi gli pneumatici e gloglottando spaventati a ogni movimento. Entriamo dal cancello e si apre dinnanzi a noi uno degli squarci più spettacolari dell’intera Georgia.
Saro si trova sul crinale di una collina e dallo spiazzo del monastero si ha la visione sull’intera valle, per chilometri e chilometri. Sbucare dal villaggio, dove il sole non arriva quasi a toccare terra a causa delle fronde dei rami, per poi giungere qui, nel sole più pieno del primo pomeriggio, è molto suggestivo. Macchie indaco, per le viole che vi crescono, colorano la montagna in fronte a noi.
La chiesa stessa è perfettamente calata nell’ambiente: è una chiesetta di campagna, molto semplice, ma, come il resto del villaggio, dotata di una sua composta dignità. Per vederne l’interno dobbiamo aspettare che arrivi una delle anziane del paese, l’unica a possederne le chiavi. Anche dentro non è molto grande, ma basta a raccogliere gli abitanti del villaggio per le celebrazioni. Già li immagino. Le madri con il velo in testa che fanno attenzione che i figli non si sporchino col fango nel tragitto fra casa e chiesa, i ragazzini che, dal canto loro, corrono in giro disordinatamente con gli amichetti mentre i padri, appena lasciati la falce e i lavori nei campi, con l’abito da festa indosso, fumano tabacco e discorrono con gli altri uomini della generosità della terra di quell’anno, della salute degli animali e delle precipitazioni. Ci sono anche gli anziani, seduti su qualche pietra, ad aspettare comodi l’inizio della celebrazione. Quando sta per cominciare la cerimonia, poi, le famiglie si ricompongono e in gruppi ordinati, come tante piccole cellule di un unico corpo, assieme vi assistono, prima di separarsi nuovamente alla sua fine: i ragazzini torneranno a giocare con i coetanei, i padri a parlare con i padri, le madri con le amiche e le nonne e i nonni con gli altri anziani.
Ad Akhaltsikhe arriviamo nel pomeriggio e, dopo un pranzo veloce, andiamo a visitarne il castello, anche perché all’interno vi è l’infopoint dove vogliamo scoprire gli orari della marshrutka per Kutaisi che dovremo prendere l’indomani.
La parte più bassa del castello di Rabati – questo il suo nome – è adibita a uso turistico, con il centro informazioni, un albergo, qualche ristorante, bar e negozi, che si affacciano sugli antichi giardini, ben curati, i cui colori e le cui composizioni simmetriche restituiscono al visitatore quel sapore di giardino orientale. L’intero complesso è infatti in stile arabo, con la tipica architettura mussulmana già vista altre volte in questo paese, che per tanti secoli è rimasto sotto il controllo degli Arabi, dei Persiani e degli Ottomani.
La parte superiore, separata da mura interne dal primo livello, è dedicata alla visita e vi si può accedere solo pagando un biglietto. Il secondo livello è costituito da un altro elegante giardino, incorniciato da una cinta muraria poco elevata e da una altrettanto bassa galleria sorretta da arcate. Salendo una piccola rampa di scale, alla cui destra si trova una chiesa, enclave cristiana in un monumento mussulmano a sua volta collocato in una nazione cristiana, si raggiunge il terzo e ultimo livello. Una gigantesca piazza, totalmente bianca, con giardini, piante, tante fontane e piscine – l’acqua è un elemento centrale per l’architettura araba – abbaglia il visitatore. Al centro la moschea Ahmadiyya e la sua cupola dorata catalizzano tutti gli sguardi. Lo sfarzo e la cura con cui sono tenuti i giardini e il castello in generale stonano con l’interno della moschea, spoglio e grezzo. Nessun tappeto alle pareti o per terra, nessuna scritta in arabo; solo quattro mura in pietra grigia e la cupola in mattoni rossi. La luce entra dalle piccole finestre, spezzata dal segno delle inferriate ai vetri. All’interno, buio e silenzio, fuori, il biancore della piazza e lo stormire degli alberi.
Da Akhaltiskhe a Kutaisi, 18 luglio
Oggi ci svegliamo presto. Prima di prendere la marshrutka delle 10 vogliamo visitare il monastero di Sapara, un complesso di chiese a pochi chilometri da Akhaltsikhe, posto sul fianco di una montagna e completamente circondato dai boschi, che lo nascondono sino a quando non ci si trova innanzi. Si parcheggia sulla strada e si continua a piedi.
Non c’è ancora nessuno, vista l’ora, e, nel più completo silenzio, io e Terry ci incamminiamo sulla strada di sanpietrini che conduce all’ingresso, mentre la luce del mattino filtra tra i fitti rami degli alberi. Sebbene la guida Lonely Planet dica che vi siano dodici chiese, ne abbiamo viste solo cinque. La più grande, Santa Saba, è appena sotto la strada, e dietro di essa vi sono due altri edifici. Altri due ancora, una casa e un campanile, si trovano invece appena sopra la strada.
Proseguendo in avanti vi è un piccolo spiazzo con dell’acqua corrente, che, sommato al ronzio delle api presenti in alcune arnie poco lontane, crea un rumore quasi assordante nel silenzio della mattina. Dopo il corso d’acqua, c’è un’area dedicata ai monaci, con refettorio e dormitori. Non c’è nessuno oltre a me e Terry, che ci avventuriamo tra le case, almeno sino a quando un monaco sui trent’anni, mettendo le braccia a X, ci fa capire che non possiamo stare in quella zona e così torniamo indietro nell’area delle chiese.
Nel frattempo, Santa Saba, che prima avevamo trovato chiusa, è stata aperta da un altro monaco piuttosto giovane, e quindi possiamo visitarla. Al suo interno vi trovo alcuni fra i più begli affreschi del viaggio, secondi forse solo a quelli di Gelati. Sotto la cupola, un Cristo in abito blu acceso benedice su sfondo rosso, mentre ai muri i disegni sono scuri e stinti: il portare il peso degli anni regala loro una bellezza dal sapore antico, di un tempo in cui anche per noi Europei la fede era ancora forte e bastava entrare in una chiesa per sentirsi parte di qualcosa. Peccato solo per l’illuminazione, elettrica e non fornita dalle solite candele sottili, che tradisce l’atmosfera e l’ambiente naturale che fanno di Sapara uno dei luoghi più belli che abbia durante il viaggio.
Tornati alla stazione degli autobus partiamo per l’ultima volta in marshrutka, in direzione di Kutaisi. Anche in questo caso – credo sia una legge non scritta di cui Terry ed io ignoravamo l’esistenza – due vecchietti si siedono accanto al finestrino, lasciandolo inesorabilmente chiuso e impedendoci per le successive quattro ore di respirare.
Giunti a Kutaisi, ritorniamo in centro grazie alle prodezze di un tassista inferocito col traffico, ma che per ottenere una facile mancia cerca di risultare simpatico, chiedendoci «Where are you from?… Ah, Italy, very beautiful, Roma and Milano… I’ve been to», prima di inveire selvaggiamente contro un compatriota che gli ha tagliato la strada o per un pedone in mezzo alla carreggiata.
Kutaisi è la classica cittadina di campagna che cerca di diventare una grande città internazionale, soprattutto ora che i voli verso la città stanno aumentando esponenzialmente, ma che, dietro il suo modo di fare, continua a dimostrare il suo carattere provinciale, per quanto si imponga di nasconderlo.
Ugualmente lontana da Akhaltsikhe e dalla sua pace e dalla grandiosità storica e moderna di Tbilisi, Kutaisi in questi anni è un flusso amorfo. Come le sue strade in continuo cambiamento, come i lavori in corso, questa città, che un tempo era la seconda del paese – ora terza poiché sorpassata da Batumi, località balneare sul Mar Nero -, rappresenta in pieno la Georgia che corre verso il futuro senza sapere cosa l’aspetti.
Ultima tappa del nostro itinerario, decidiamo di visitare la cattedrale di Bagrati, situata su una collinetta posta sulla sponda occidentale del fiume Rioni, da dove domina la città. Questa chiesa caratterizzata, come solo il monastero di Gelati, dalle tegole color verde smeraldo, è stata costruita nell’XI secolo, abbattuta nel 1692 dagli Ottomani e ricostruita e restaurata solo a partire dagli anni ’50 del secolo scorso, come testimoniano strutture di acciaio e di metallo molto moderne. Questi innesti stonano di proposito con le parti originali dell’edificio, per evidenziarne il contrasto. Sebbene io sia consapevole che l’arte del restauro stia seguendo questa direzione, un tale modo di fare suscita in me sempre sentimenti contrastanti: da un lato capisco l’esigenza di mostrare chiaramente cosa non sia autentico, dall’altra però questa scelta impedisce la sospensione dell’incredulità del visitatore medio, che poco e nulla sa della chiesa e vuole semplicemente immergersi in una realtà differente, assaporarne la novità e imbeversene attraverso il suo valore estetico. Trascurando ciò, l’interno, constatata l’assenza di affreschi, è simile in tutto e per tutto a quello delle altre chiese già visitate, anche se l’inedita forma allungata e la grande altezza la rendono unica nel proprio genere. In una teca a muro è conservata quella che sembra essere una copia della sindone di Torino, senza nessuna spiegazione, il che ha parecchio confuso Terry e me.
All’esterno, un prato verde digrada seguendo la collina, con i resti di qualche colonna e un piccolo campanile, mentre la città di Kutaisi si affaccia appena sotto, attraversata dal pigro scorrere del Rioni.
Kutaisi, 19 luglio
Siamo pronti a ripartire. Prima di prendere il nostro volo alle due del pomeriggio, abbiamo ancora il tempo di fare un giro al bazar per comprare una bottiglia di vino da bere con gli amici in Italia.
Andando all’aeroporto, poi, possiamo per un’ultima volta esperire la guida georgiana, in tutta la sua essenza. A pochi chilometri dalla meta c’è stato un brutto incidente, che ha visto protagoniste due marshrutke e un’auto. Si forma dunque la coda, ma vedo una cosa che mi lascia basito. Tutte le macchine che prima erano normalmente in coda l’una dietro all’altra nella propria corsia, iniziano, per guadagnare pochi metri, a spostarsi, come se lo avessero concertato in precedenza, un poco a destra, sulla zona sterrata vicino alla strada, o a sinistra, posizionandosi attaccate alla linea bianca che separa le due corsie. Per ogni corsia vi sono quindi tre file parallele, in entrambe le direzioni di marcia, così che, una volta che sono arrivate le forze dell’ordine e il traffico ha iniziato a defluire, circolano contemporaneamente sei file di macchine, facendo somigliare la piccola stradina statale che separa Kutaisi dall’aeroporto alla tangenziale di una grande città nell’ora di punta o a un’autostrada nei weekend da bollino rosso.
Questo, più che l’attesa nel minuscolo aeroporto da tre voli al giorno di Kutaisi, è l’ultimo ricordo che mi porto della Georgia. Un paese che ha conservato un cuore rurale e contadino, ma che con troppo entusiasmo sta abbracciando la modernità nei suoi aspetti più truci. Sono però la maggioranza i luoghi immersi nella natura; nelle piccole o medie città i tetti delle case spuntano ancora da un mare di alberi, come si può vedere, ad esempio, dalle foto di Sagarejo, o di qualunque altra cittadina, che si possono trovare anche solo cercando su google; nei villaggi tutti hanno un giardino, con un piccolo orto e qualche animale. Dove non vi sono insediamenti, i boschi regnano incontrastati.
Pensando a ciò, torna in mente una vecchia favola georgiana sull’origine di questa terra, riportata da Francesco Trecci in Georgia: il paese che Dio voleva per sé:
«Mentre Dio stava distribuendo le terre ai popoli del mondo, i Georgiani erano seduti a una lunga tavola imbandita di vino e pietanze, impegnati in una grande festa. Si era al brindisi, il momento più importante della tradizione celebrativa georgiana che non poteva essere interrotto. Il popolo georgiano pertanto arrivò in ritardo al cospetto di Dio per la spartizione delle terre. Dio disse loro che ormai tutte le terre erano state distribuite ma i Georgiani prontamente risposero che erano in ritardo perché avevano brindato in onore di Dio Onnipotente. Dio fu così felice che decise di regalare a quel simpatico e festoso popolo la parte di Terra che aveva riservato per sé».
«Per capire dove va un paese devi guardarne la capitale» mi è stato però insegnato. E allora viene da chiedersi, mentre l’aereo abbandona il suolo, quanto ancora la Georgia resterà così. Questo paradisiaco paese ai piedi del Caucaso, infatti, si trova davanti a una scelta: rimanere coerente con sé stesso e, citando Voltaire, cultiver son jardin, oppure perseguire una pericolosa occidentalizzazione, rischiando di bruciarsi come una falena contro una lampada al neon? La Georgia è chiamata a decidere e davanti a sé ha un’occasione da (non) perdere.