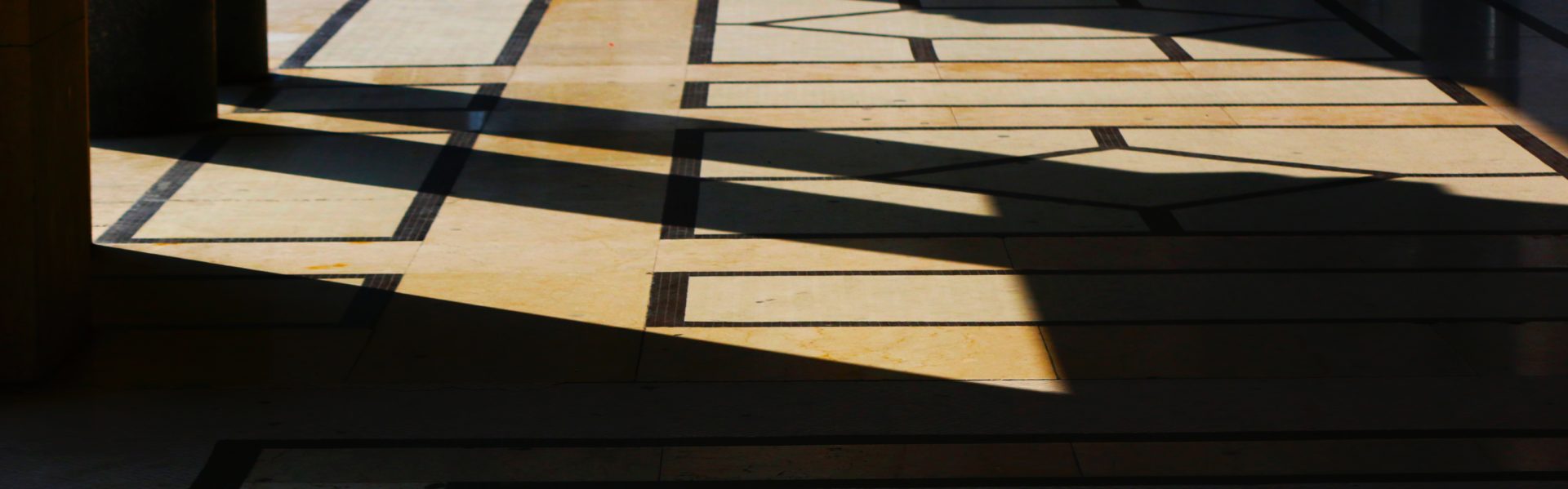Chi studia o vorrebbe studiare all’università le lettere e la filosofia, chi sta frequentando un dottorato in materie umanistiche, chi le insegna o lavora in contesti che le concernono, prima o poi si sentirà immancabilmente porre un’unica, spietata, crudele domanda ormai sempre più ribadita come un nevrotico mantra: «Sì, ma a cosa servono le cose che studi?».
Personalmente ho assistito a molte discussioni di amici umanisti che, posti di fronte a questa domanda, facevano di tutto per cercare di giustificarsi, di arrampicarsi sugli specchi a volte, si torcevano le mani come se dovessero giustificare un furto o un atto impuro di fronte agli occhi inquisitòri del loro super-io. Cercavano quindi di trovare, quasi su due piedi, un senso in quello facevano, e cercavano, spesso senza successo, di spiegarne l’importanza ai propri interlocutori.
Negli ultimi tempi però mi sono accorto che la maggior parte dei giovani umanisti (chiamiamoli così per comodità) che mi circondano sono molto scoraggiati, non tentano più neanche di rispondere e quasi quasi rispondono facendosi la stessa domanda, spesso con il classico: «Eh! Me lo chiedo anch’io!». Io li capisco, siamo tutti un po’ frustrati da una società che va in tutt’altra direzione marginalizzandoci sempre di più. Per questo molti di noi si sono convinti che sì, avete ragione voi, non ha nessun senso studiare queste cose e quanto mai non mi sono iscritto a qualcos’altro di più utile: a quest’ora sarei medico, ingegnere, avvocato! E invece…
Uno spettro si aggira per le scuole e le università e stavolta non è il comunismo, ma un ospite inquietante, una forma serpeggiante di nichilismo che appiattisce tutto al livello dell’utile. Insomma, il concetto è che va bene tutto, è tutto davvero bellissimo, la storia, la letteratura, la filosofia, però alla fine qual è davvero l’utilità finale di tutto questo? Il punto è proprio il concetto di utilità.
Qualcuno molto astuto risponde: «Che sciocchezza! La domanda è mal posta: la categoria dell’utile riguarda l’economia, non le scienze; le scienze ricercano il vero, non l’utile». «Sì, va bene – ribatte l’ospite inquietante – ma allora ha senso che nell’economia generale di uno stato si stanzino fondi per i dipartimenti, che ne so, di filologia? Insomma, quale ne è l’utilità?».
Affermare che la domanda sull’utilità degli studi umanistici è mal posta in effetti non soddisfa neanche chi ne è convinto. Criticare la domanda è comunque un non rispondere e una non-risposta lascia in sospeso una domanda che continuerà a logorarci da dentro, a macerarci, a farsi sempre più inquietante, cinica e feroce finché ci farà suoi schiavi e ci costringerà a rispondere come vuole lei. C’è anche chi, come Nuccio Ordine, ha parlato autorevolmente a questo proposito di «utilità dell’inutile», ma anche questi giochi di parole in fondo non sembrano così convincenti e rischiano di apparire come criptiche discolpe di una colpa che in realtà non c’è.
Io di solito quando sento i miei amici parlare di questi argomenti sto in silenzio. Sto in silenzio perché nella mia idea di realtà non c’è nessun problema nel fatto che qualcuno sia pagato da uno stato per studiare, per esempio, la politica matrimoniale dei sovrani aragonesi del medioevo: è così e basta. Per questo non voglio partecipare a un dibattito che non mi sembra necessario. Dibattere sul perché si debbano investire soldi in ricerca umanistica è un po’ come se in una repubblica si dibattesse sul perché bisogna imporre una tassa per il mantenimento del re e della corte: il problema non si pone proprio.
Evidentemente però, se in tanti ne parlano, è perché il problema si pone (è perché qualcuno lo pone) e l’emergere così esteso di questa domanda è certamente un sintomo. E allora non posso più neanch’io fare finta di niente (ma, lasciatemelo dire, resta comunque il fatto che fare finta di niente è un atteggiamento di un’eleganza, ma di un’eleganza…). Insomma, non posso passare sempre per lo snob di turno e allora ho deciso che anche io voglio dare una risposta a questa inquietante domanda.
Io penso una cosa molto semplice: finché non torneremo tutti hegeliani si continuerà per sempre a essere assillati da questo tipo di domande. Sì, avete capito bene: voglio parlare di Hegel. E perché? direte voi. È pazzo! Cosa c’entra Hegel adesso?
C’entra eccome! Infatti, il modo in cui noi oggi percepiamo le nostre discipline, soprattutto quelle umanistiche è, in fondo, debitore dell’idealismo hegeliano. Lo stesso nostro sistema scolastico, al cui fondamento sta la riforma di Giovanni Gentile (filosofo idealista), è hegeliano fino al midollo. Non vi siete mai chiesti perché la storia, la filosofia e la letteratura alle scuole superiori vengono insegnate dividendo il programma per secoli secondo una progressione in parallelo con la progressione cronologica degli anni scolastici? Non è mica una cosa scontata. Perché in terza si studia il medioevo, in quarta l’età moderna e in quinta l’età contemporanea? Perché crescendo l’età degli alunni deve crescere anche il numero dei secoli?
Il motivo sta nel titolo di questa mia nota che è una citazione tratta dalle Lezioni di storia della filosofia di Hegel: lo Spirito, secondo Hegel, ha compiuto «quasi due millenni e mezzo di lavoro serissimo, per diventare oggettivo a sé stesso, per conoscersi». Per questo noi studiamo la storia: studiamo il cammino dello spirito, e studiandolo lo ripercorriamo per ritornare infine in noi e ri-conoscerci. In più Hegel ha detto anche – nella sua Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio – che le età della vita hanno un significato filosofico e quindi crescendo ci si avvicina sempre di più, passando attraverso un processo dialettico, al proprio riconoscimento. Il crescere è un ripercorrere in senso filosofico tutta la storia dell’umanità.
Dunque qual è secondo Hegel l’utilità delle materie umanistiche? Raffinare l’autocoscienza dello Spirito, tenere in vita e fare avanzare il processo per cui la ragione trova se stessa nel suo contenuto, riattivare quel cammino grazie a cui l’uomo prende pieno possesso di sé e diviene libero «determinandosi indipendentemente dalle condizioni accidentali e limitatrici nelle quali vive» (Abbagnano). Sono in special modo i saperi umanistici quelli grazie ai quali lo Spirito giunge a sapere ciò che esso è veramente. E a seguito di questa autocoscienza si può oggettivare questo sapere, si può realizzarlo «facendone un mondo esistente».
Quando vi chiederete allora perché state studiando la guerra di successione polacca, la filosofia di Rosmini o i madrigali inediti del Seicento italiano rispondetevi pure così, con coraggio e ottimismo: «In me la totalità della realtà giunge all’autocoscienza di una parte di sé, di una tappa del suo cammino (la guerra di successione polacca, il pensiero di Rosmini, i madrigali)». Ditevi: «Io sono parte di una totalità e sono in grado di far pervenire la totalità (perché non ci sono scissioni nella totalità quindi se questo avviene in me, avviene in tutto) all’autocoscienza di sé». «Niente si perde, tutti i principi si conservano», dice Hegel: lo Spirito tiene insieme tutto, l’Idea è una, e in me, studente di Lettere e Filosofia, si chiude un ciclo cosmico.
Che cosa rispondere allora all’ineluttabile domanda «Ma a che cosa serve quello che studi?»? Con tranquillità e serietà diremo: «Serve a chiudere un ciclo cosmico». Lo so, sicuramente ci diranno che siamo degli idealisti, ma noi prontamente risponderemo che sì, è vero, siamo idealisti, ma c’è una bella differenza tra un idealista un po’ hippie che sogna ad occhi aperti guardando il cielo con un fiorellino in bocca e un idealista prussiano del XIX secolo. Non so se avete presente Hegel.