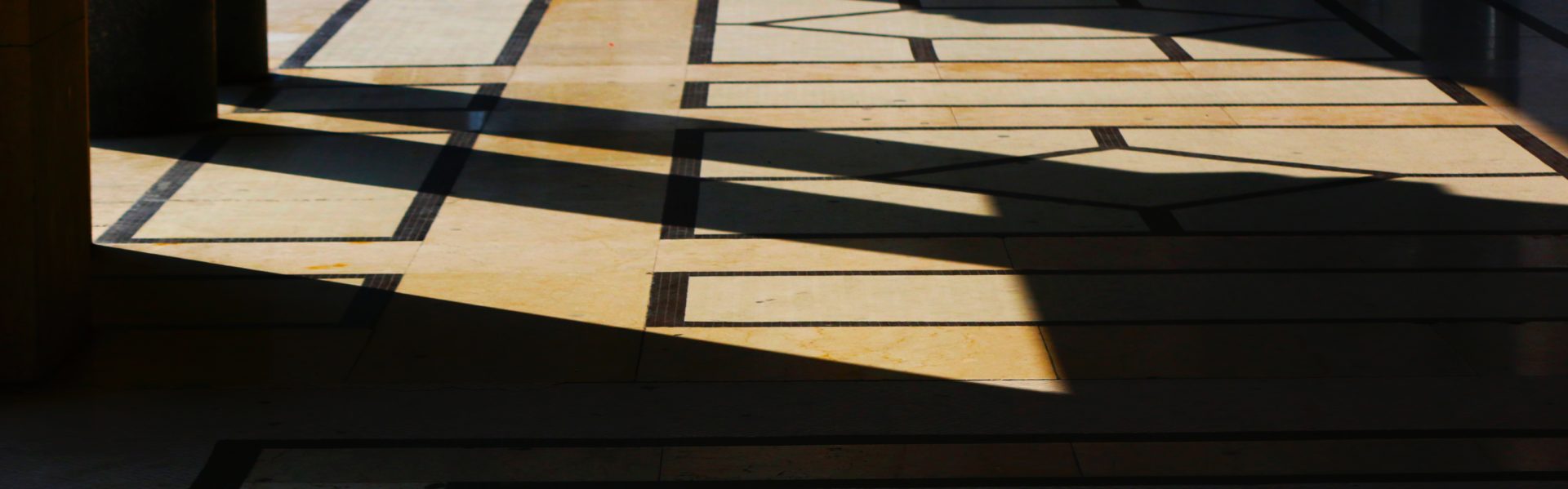Il posto non era affatto male. Luci tranquille, divanetti logori ma che sapevano di casa. Il modellino di un camper hippie piazzato all’ingresso, vicino a un pannello a canneto. Gli sembrava di essere nel salotto di casa di un amico e questo lo tranquillizzava. Un posto in cui rilassarsi, in cui bere qualcosa e ascoltare buona musica.
Prese una media scura doppio malto.
– Io credo – disse a M mentre il barista consegnava loro i bicchieri – che nei posti si stia per due motivi: o perché ci si trova tremendamente bene e non si vorrebbe essere da nessun’altra parte; o perché non si vuole assolutamente stare in un altro posto e quindi ci si concentra al massimo su dove si è. In entrambi i casi le cose riescono benissimo. Bevve un sorso.
– Se le cose non riescono, se la serata o la giornata va a puttane, se non sei a tuo agio con la vita che stai conducendo, beh allora è perché sei nel limbo.
– Ti trovi bene qui al nord, tu? – gli domando M.
– Si.
– E per quale delle due opzioni?
Era a Milano da un anno, ormai. Non aveva nostalgia della sua terra, non aveva mai provato quella sensazione nella sua vita. Nemmeno quando effettivamente passava molto tempo lontano da casa. E non perché non tenesse alle sue origini: amava visceralmente i suoi natali in una terra aspra, abbandonata e bella. Ma il senso di attaccamento si manifestava in lui a livello talmente profondo da risultargli per certi versi fisiologico. L’evocazione del sapore del mare e l’odore delle montagne circolavano in lui come sangue, quasi egli stesso fosse stato in realtà plasmato con sale e fichi d’India.
Con un tale senso di attaccamento alle proprie radici, pensava S, bastava chiudere gli occhi per avere davanti a se la distesa luccicante, cosi come la vedeva dal balcone della sua casa natia. Il rumore della risacca al crepuscolo andava a coprire lo sferragliare della metro; il baluginio a scaglie, sotto il sole di mezzogiorno, si sostituiva al cemento dei palazzi. Aveva spesso meditato di andare a farsi tatuare, armato di fotografie, i colori di quel mare su una spalla. Come fosse una sorta di esorcismo, per sentirsi in qualche modo protetto mentre era impegnato a guardare avanti, lungo la strada che aveva scelto, e anche un memento: tra tutto l’inevitabile grigio, tra tutto lo schifo che poteva incontrare nel mondo c’era anche il bello. Un memento a tinte azzurre, arancio e viola.
Milano era una realtà diametralmente opposta alla sua cittadina marina. Se n’era reso conto molto presto. L’antitesi era tale che nei primi mesi si stupiva praticamente di qualunque cosa, anche laddove non c’era niente di eccezionale. Non era andato a Milano digiuno riguardo cosa l’aspettasse: le numerose visite fatte nell’infanzia lo avevano preparato al cambio di realtà, ma nonostante la preparazione lo stupore iniziò a manifestarsi per tutto quello che gli altri consideravano se non abitudinario almeno normale.
Ovvietà.
Era ovvio che la metro da Cologno Nord si inabissasse dopo le prime fermate fatte all’aperto, ma sentì ugualmente un senso di spaesamento la prima volta che la prese da: vedere binari in pieno sole laddove si aspettava una discesa nel girone metropolitano. Non se ne raccapezzava.
Era ovvio che nei bar l’acqua insieme al caffè si desse previa richiesta, spesso addirittura a pagamento (a meno che non si chiedesse «l’acqua del sindaco»), e la perplessità era legata alla ventennale e naturale abitudine di ricevere sempre il bicchiere d’acqua come accompagnamento. Una delle prime volte in cui si fermò in un bar per fare colazione, chiese un caffè lungo e preparo un euro. Domandò poi alla ragazza anche un bicchier d’acqua, ma si senti rispondere «Abbiamo solo le bottigliette, naturale o frizzante?». Preso alla sprovvista, non seppe ritrattare la sua richiesta. S usci da quel posto con uno scontrino di 2.50, pensando che allo stesso prezzo nel bar centrale della sua cittadina avrebbe preso 3 caffè macchiati o una grappa. Non vi rimise più piede meditando di acquistare piuttosto un thermos, che lo avrebbe certamente aiutato a non lasciare che la caffeina provocasse un dissesto delle sue finanze.
Era ovvio che, salutandosi, ci si lasciasse con un semplice e vocale ciao, sorridente certo, ma veloce, nessuna interazione corpo a corpo. Le prime volte aveva avvertito un senso di incompletezza: per S il contatto fisico al momento del saluto era imprescindibile, era il simbolo del mi sto allontanando con la mia mente e la mia massa, ma ti lascio un po’ del calore della mia massa, oltre che del mio affetto, per farti capire che non ti lascio veramente. Ci volle un po’ prima che gli amici di S imparassero la cosa. G gli rivelo, una volta, di limitarsi al saluto acorporeo perché non riusciva a capire quando arrivasse il momento di confidenza tale da potersi permettere di salutare più affettuosamente, e lui le spiego che in realtà, almeno da dove veniva lui, c’erano tre semplicissimi step per le ragazze: quando mi presento per la prima volta la stretta di mano, come dappertutto; dalla seconda volta due guancia a guancia e quando arrivi a essere più in intimità con la persona in questione il guancia a guancia diventa due baci effettivi sulla guancia. A livello di amicizia, poi, tali problemi non sussistono nemmeno: ti saluto come voglio, con quanti abbracci voglio, con quanti baci voglio. Per i ragazzi era ancora più semplice, spiegava lui. Superata la fase della stretta di mano e del saluto formale a due baci, pacche forti sulle rispettive spalle. Il contatto è necessario, non faceva che ribadire S: i legami non si possono reggere solo sulle parole, senza toccarsi.
Era ovvio ci fosse una varietà pressoché infinita di gusti e modi di vedere, comportarsi, pensare. Ma soprattutto di interessi. Quando M gli disse di suonare il sax in una band reggae, ad esempio, S lo tempesto di domande, con una genuina curiosità, per poi spiegargli che non gli era mai capitato in tutta la sua vita di conoscere una persona che facesse quello che, al nord, era considerato una passione come un’altra.
Era ovvio puntare su un aperitivo quando si voleva vedere qualcuno o andare a mangiare al ristorante giapponese, cosa che giù costituiva più un esperimento, un provare qualcosa di insolito. S si accorse invece della metodica propensione dei suoi amici ad affidarsi a quei rotolini di riso e alghe e tutto il corteo di varietà connesso a essi. Ma nonostante fosse stato trascinato più di una volta all’All you can eat dal volere comune, l’idea del pesce crudo non riusciva ancora a reggere la sfida, nella sua mente, con un salatissimo e sanissimo panino ripieno di tutto.
Era ovvio, infine, che muovendosi in bicicletta bisognasse andare sulla strada, lateralmente, e che auto e pullman rallentassero per questo, ma lui non riusciva a vincere la paura folle di assistere a un investimento, o di essere lui stesso investito qualora avesse deciso di muoversi su due ruote. «Ok, va piano e sei a lato» commentava mentalmente quando il pullman su cui si trovava passava rasente a un ciclista, sul ciglio della strada (quindi praticamente ogni giorno) «ma se dovessi perdere l’equilibrio ti schiaccia. Porcogiuda, ti schiaccia. E se ti schiaccia che fai? Dici mi paga? Ma perché non vai sul marciapiede al posto di costeggiarlo?». Se poi era notte la paura triplicava. In bici col buio era sintomo di pazzia, o di incoscienza. E no, non importava che le bici fossero appositamente dotate di luci. Resti un incosciente, era il suo rimprovero silente.
Scopri solo in seguito che muoversi con la bicicletta non era cosi fuori dal mondo come pensasse, che i rischi in realtà, in una metropoli, erano connaturati allo spostarsi in qualunque modalità, soprattutto a piedi. Provò, e provò anche di notte, e dopo la prima volta, macchiata da un sentore di disagio, si abituò all’idea, continuando tuttavia a reputarla strana e a meravigliarsi con se stesso, ogni volta, di essere riuscito ad arrivare salvo a casa.
La straordinarietà di Milano stava, per S, proprio nella sua ordinarietà. Era proprio il suo essere, la sua realtà esattamente com’era, a fornirgli ogni giorno motivazioni per stupirsi, ora in positivo ora in negativo, in quanto era un essere diverso dall’essere di giu. Abitudini, canoni, persone, modi di fare, modi di dire, modi di comportarsi, modi di pensare sono il complesso che rende una realtà ciò che e. Con tutte le sfaccettature, anche nere. E questo complesso è anche ciò che rende unico e speciale qualcosa rispetto a qualcos’altro. Anzi, qualcuno rispetto a qualcun altro.
A S non spiaceva parlare di Milano e della sua terra, ponendole pero a confronto con un taglio che le vedesse in primis come realtà umane, quasi come se esse stesse avessero assunto specifici connotati antropici e fisionomici.
Quando M gli pose quella domanda, dunque, S andò nel panico. Cercava sempre di glissare quel genere di interrogativi. Domande come «Ti trovi bene qui al nord?» o «Ti piace più Milano o già?» nella sua ottica equivalevano a «Vuoi più bene a tuo padre o a tua madre?» o «Ti piace più la pizza o le lasagne?» e presupponevano una risposta che si sarebbe inevitabilmente scolpita nella memoria, senza possibilità di scampo, assumendo una forma lapidaria che lo avrebbe condannato alla gogna da ambo le parti, a seconda appunto della risposta. Sei uno che rinnega la sua terra madre oppure Sei uno che non apprezza la sua terra d’adozione. Nessuna via di scampo e lui non voleva prendere le parti di nessuno. Premettendo che qualunque giudizio sia in ogni caso soggettivo (e potrebbe uscire formulato con parole non adeguate e quindi essere passabile di fraintendimento), a S risultava difficile, anzi impossibile, stabilire con assolutezza il primato di una delle due realtà, in quanto non esisteva un metro di paragone adeguato a porre a confronto due realtà cosi diverse.
Certamente Milano, ad esempio, era imbattibile a livello di trasporti, dotata di mezzi di qualunque sorta in grado di collegare ogni suo più periferico punto e per S ciò rappresentava possibilità praticamente illimitate di percorsi e libertà, diversamente da giù, dove gli autobus passavano non si sapeva quando e non si sapeva dove.
Ma Milano aveva prezzi esorbitanti, S aveva speso più in biglietti che in cibo nella prima settimana e una classica margherita, cosa impensabile, veniva a costare 6 euro, mentre già i prodotti erano freschi, genuini e la vita nient’affatto costosa. S ripensava all’aneddoto raccontatogli da tre suoi amici brianzoli che qualche mese prima, in vacanza sulla Costiera Amalfitana, erano andati dal fruttivendolo in cerca di verdure e dopo aver acquistato finocchi, peperoni, sedano e quant’altro, si erano sentiti dire un prezzo cosi irrisorio che uno dei tre aveva ingenuamente domandato «A testa?» «No, e il totale. E il sedano ve lo aggiungo io». Non era questione di migliore o peggiore, bensì di lati positivi e lati negativi. A ognuna il suo, pensava S, questa e la verità.
Come due persone vere, avevano due caratteri diversi.
Milano era gli uomini in giacca col telefono sempre incollato all’orecchio, le manager coi tacchi che macinavano le strade con sicurezza, i turisti eterogenei in piazza Duomo, i ragazzi dai capelli verdi, le ragazze col velo che leggevano sul tram, le persone che salivano alla fermata Centrale con lo zaino da trekking o i valigioni e lo sguardo da viaggio, la sciura tranquilla, pacata, composta, organizzata e soprattutto tremendamente controllata nelle azioni e nel tono. S era sconcertato (ancora una volta) dal fatto che i milanesi si arrabbiassero usando gli stessi decibel che un meridionale avrebbe usato per sostenere una normale e cordiale conversazione. Vuoi per una convenzione, vuoi per naturale disposizione, ma pareva davvero che non riuscissero a far vibrare le corde vocali di qualche tono più alto, come se esse fossero paralizzate sempre in una modalità controllata anche quando di controllato non doveva esserci molto. S si stupì molto, quindi, la volta in cui sul 31 assistette a un litigio dai toni alti e pesanti tra due donne. Una imputava l’altra di maleducazione, in quanto aveva lasciato sulla panca della fermata precedente una bottiglietta di plastica vuota. L’altra rispondeva all’accusa sostenendo che il tram fosse in arrivo e che non aveva trovato in quel momento un cestino vicino e di non averla neanche potuta mettere in borsa in quanto si era rotta la tracolla e stava pensando a recuperare gli oggetti e a non perdere il mezzo.
La sua terra era invece il vecchietto che gioca una briscola con gli amici al circoletto, i baristi che fumano una sigaretta sull’ingresso del locale mentre conversano con un amico, le ragazze sedute ai tavolini esterni di una pasticceria per ore, davanti una brioche e un caffè, i venditori di mazzi di origano con l’Ape -S una volta, all’amico che gli proponeva un ape nel pomeriggio, rispose che l’unica Ape che conosceva era un mezzo a tre ruote-, le signore che fanno la passeggiata mattutina sul lungomare, i mandriani che a Dicembre fanno la transumanza passando anche per i paesi, le comitive che attendono l’alba sulla spiaggia intorno a un falò. La sua terra era natura coerente: il mare, nel punto in cui il sole crea la scia del suo riflesso, ricordava a S la consistenza della salsa, quella alla cui preparazione tutta la sua famiglia dedicava un’intera giornata ogni anno, d’estate, una sorta di rituale. E il mare ricordava la consistenza corposa della salsa fatta in montagna, quando e ancora nel cesto foderato di canovacci, appena spremuta fuori dai pomodori di cui restano le bucce sottili come pellicole, densa, calma, rugosa e sottilmente increspata, la consistenza che ha prima di esser travasata nei boccacci di varie forme già allineati sul tavolo, guarniti di qualche foglia di basilico, vuoti come prima di un pranzo, mentre l’acqua del succo in eccesso ormai cola e gocciola dai bordi.
E si, S pensava il confronto tra una città e una regione intera, per un motivo semplice: Milano aveva in se stessa e nel suo interland tutta la varietà, la varietà della sua terra andava invece ricercata in tutto il suo territorio, dalle montagne odorose fino alle acque di Ionio e Tirreno.
Milano lo aveva accolto, e bene, questo restava un dato innegabile. Faceva parte della miscellanea natura di Milano, che era «Il mondo in una sola città»: cosi lo definiva S ogni volta che qualcuno dei suoi vecchi amici gli chiedeva come fosse la città. E di conseguenza anche il mondo con ogni sua stranezza, come il sessantenne che gli domando, mentre era seduto ai tavolini del bar della biblioteca, «E aperta?», commentando poi, senza attinenza con la risposta affermativa di S «E un giorno infausto, oggi, eh? E’ venerdì 17. Ma a me non mi e mai successo niente, non ci credo a queste cose. Quindi e aperta?». Stranezze che davano a S un motivo per sorridere, ricordandogli che la realtà umana era tutto fuorché piatta.
Milano era il ragazzo che incrocio per strada e gli disse «Stammi lontano, sono nero».
Milano era la donna rovinata, coi capelli rossi e spessi chiusi in due treccine laterali, vestita con una giacchetta di jeans e i calzettoni fucsia, che beccava sempre sul 4 mentre accompagnava ogni giorno un uomo basso in ospedale.
C’erano pero giorni in cui S non riusciva ad affidarsi al suo spirito di avventura e adattamento. Erano i giorni no, giorni dettati dall’accumulo di stanchezza, troppa caffeina, giornate pesanti e notti in cui lo spazio per dormire si riduceva a cinque ore. L’accumulo straripava, riversandosi dalla sua mente ai suoi sensi, offuscando la convinzione di S che marcio e sano esistono ovunque, ma occorre saper scegliere a cosa dare preminenza.
Cosi S lasciava che Milano lo incupisse. Ad esempio pensando a come ormai da mesi soffiasse via dal naso un muco scuro, misto a polveri pesanti e sangue. Nelle sue rimpatriate nella sua terra natale, allora, si rifugiava in montagna e respirava a pieni polmoni l’aria e quando l’avvertiva entrare sentiva il suo peso buono e salutare che lo riempiva e
quasi lo schiacciava, perché aveva dimenticato come fosse l’aria vera. Allo stesso modo i suoi occhi si rendevano conto che, nelle belle giornate, il cielo azzurro non era veramente azzurro e le volte in cui era tornato giù per un brevissimo periodo il cielo lo aveva accolto con un colore cosi pieno e saturo da ferirlo. I colori comparivano, nei giorni no, smorti, scarichi, e S si rendeva conto di come l’abitudine l’avesse indotto a reputarli reali. La sua attenzione veniva risucchiata dalle insegne al neon che scorrevano fuori dal finestrino dei pullman, amorfi ectoplasmi fluorescenti che fluttuavano nella notte, e quando tornava a rivolgere lo sguardo all’interno del vagone la sua concentrazione era minata, capiva e non capiva, in uno stato di coma, e si sentiva stupido. Al suo olfatto, nei giorni no, arrivava più intenso, a vampate, l’odore dei corpi non lavati, schiacciati l’uno contro l’altro, nella metro, odore di sudore e bocche col sapore di sonno. E spesso, troppo spesso, da uomini e donne avvolti in cappotti logori più grandi di loro, incerti nel passo, dai capelli incrostati di sporcizia e gli occhi spenti dalla fame e dal freddo, si aggiungeva un odore acre, un odore di sporco misto a odore di nulla: consapevolezza di nulla, speranza di nulla, se non di uno spiccio chiesto con voce impastata col fiato pesante. L’abitudine l’aveva condotto anche a non avvertire più con il magone il degrado di molte situazioni: S si rimproverava di essere arrivato a pensare che il decadimento, il basso e le disparita fossero insite nella natura cosmopolita di Milano, che fossero troppo per lui. Il troppo era diventato la norma, le scene sempre davanti agli occhi delle zingare sulle scale dell’ingresso della metro a chiedere l’elemosina o dei senegalesi con la scatola di braccialetti portafortuna erano state metabolizzate da non riuscire più a far leva sulla sua empatia come nei primi giorni. Sono diventato insensibile? domandava a se stesso in quei giorni, muovendosi per inerzia su percorsi ormai noti a menadito, catturato dal moto inarrestabile e fagocitante della città.
S usciva dai giorni no quando qualcosa lo colpiva e riattivava la sua naturale propensione all’analisi. Una volta, appoggiato a una delle barre verticali della metro gialla stanca della sera, fu colpito dal vedere, seduti ai lati opposti di una fila, due uomini che parevano sorprendentemente copia speculare l’uno dell’altro. Avvolti nello stesso giaccone, con lo stesso naso a tagliare lo stesso profilo, aventi gli stessi colori e le stesse forme. Ma uno era un ragazzo, l’altro un uomo sulla cinquantina. La somiglianza si
trasfiguro poeticamente nella mente di S. Se uno avesse guardato a sinistra, avrebbe visto gli errori non ancora commessi e le gioie non ancora provate, se l’altro avesse guardato a destra avrebbe visto gli errori che avrebbe commesso e le gioie che gli sarebbero toccate. Se si fossero guardati l’un l’altro, parlati, forse sarebbero stati contenti di sapere cosa si aspettavano, cosa si lasciavano dietro. Se si fossero parlati, forse avrebbero cambiato qualcosa del loro passato o evitato qualcosa del loro futuro. Nella mente di S si guardarono. Nella metro stanca della sera, l’uomo scese a Zara e il ragazzo si mise a scrutare lo schermo del telefono. S si chiese se fosse stato meglio cosi.
Diede molto da pensare a S un incidente sulla strada che percorreva ogni giorno. Era sul pullman e dal finestrino vide un motociclista steso a terra, una moto rovesciata e un paio di persone che stavano attendendo i soccorsi. Sembrava che quel punto stesse esercitando una sorta di repulsione magnetica, per cui i mezzi si spostavano curvando un poco e riprendendo poi la via dritta. Anche l’autista virò semplicemente intorno al cerchio composto dai detriti dello scontro e prosegui nella corsa.
Era successo qualche metro prima. Ma qualche metro dopo la vita continuava, forse nessuno si era accorto di nulla. Nel car wash le attività proseguivano, le persone entravano nei bar a prendere il cappuccino mattutino, le auto marciavano in senso contrario, la signora si accendeva la sigaretta trascinando il cane. Come se non li riguardasse, come se non fosse successo veramente, come se fosse successo ma in un blocco, in uno scomparto della realtà mattutina, che iniziava dalla punta degli stivali supini del motociclista e finiva nell’area occupata dall’ultima scheggia del manubrio distrutto. Un’area piccolissima dunque. Qualche metro dopo, un centimetro oltre quest’isola distrutta -l’isola del disastro- un altro blocco, un’altra realtà. Una realtà in cui non c’era stato alcun incidente. Il manutentore riconsegnava le chiavi dell’auto alla donna, la donna entrava in macchina, le persone posavano la tazzina togliendosi con un tovagliolo la schiuma dalle labbra, le auto proseguivano la loro marcia in senso contrario, la signora col cagnolino era ormai lontana e la sigaretta spenta. S penso che un evento del genere, giù, avrebbe bloccato il traffico, distolto un numero imprecisato di persone dalle loro occupazioni che ne avrebbero discusso e il tutto avrebbe avuto una risonanza cittadina, rimbalzando di voce in voce, di sussurro in sussurro, ora come semplice commento, ora con un pizzico di preoccupazione, ora con un accenno polemico paternalistico sul quanto siano pericolose le moto. L’impatto avrebbe avuto un impatto. Ma S non capi per quale comportamento fosse il rammarico e per quale il sollievo che provo, mentre il pullman superava l’incidente.
– Oh, ci sei? Tutto ok? S si riscosse quando M gli prese il braccio.
– Tu lavori troppo, te lo dico io. Comunque non hai risposto alla mia domanda, per quale delle due opzioni?
– Non l’ho ancora capito. Bevve un altro sorso.