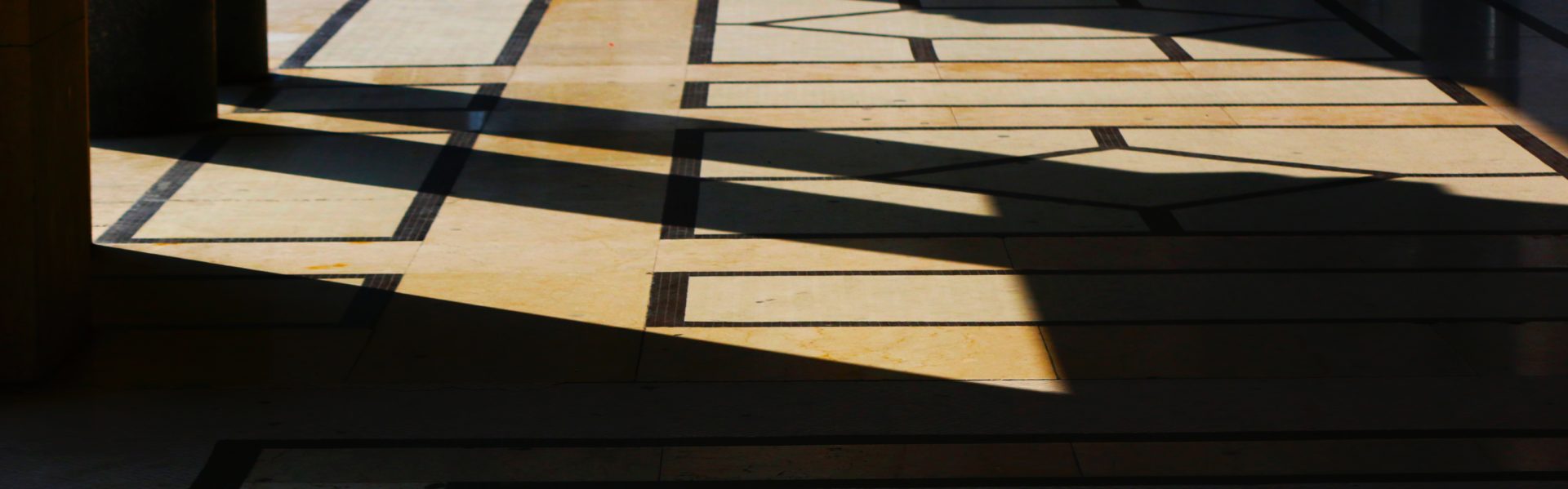Per sfatare un mito: chi ha radici in montagna non ci torna per ritrovare genericamente un se stesso sepolto da qualche parte sotto la neve. Ci torna per dimenticare, temporaneamente o definitivamente, quello che è stato fino a quel momento. O meglio, ci torna per gettare uno sguardo su un se stesso alternativo, per capire chi sarebbe potuto essere se avesse fatto scelte differenti: cosa sarebbe potuto diventare? Non necessariamente per dare una svolta alla propria vita, anche solo per ricominciarla più consapevole di prima. Questa è l’intenzione di Maria Dolores Vergani, protagonista dell’ultimo romanzo di Elisabetta Bucciarelli, il noir “Dritto al cuore” (2013, E/O) argomento dell’appuntamento conclusivo di Ayas Littéraire, fissato per giovedì 17 agosto alle 21.15 al Monterosaterme di Champoluc. Il luogo prescelto dall’ispettrice, volto già noto nella produzione dell’autrice, è la casa d’infanzia, una baita walser affacciata sull’Alta Via all’altezza della Val d’Ayas. Ma la vacanza dura poco: in un area poco battuta del bosco, sepolto dal muschio, viene rinvenuto il cadavere di una giovane mai vista prima. Il caso, che si infittisce sempre più, richiede la competenza della Vergani: in termini di esperienza professionale, ma soprattutto di conoscenza dell’animo umano. Anche se l’ispettrice può mettere in discussione la propria carriera nella polizia, l’indole dell’investigatrice le appartiene per natura.
Lo stesso suo sguardo analitico contraddistingue anche Elisabetta Bucciarelli, che alla scrittura ha dedicato la sua vita: a livello teorico in quanto autrice di diversi saggi sul tema, ma soprattutto a livello pratico con racconti, sceneggiature cinematografiche, televisive e teatrali, nonché articoli di giornale e ovviamente, dal 2005, romanzi. La curiosità per i meandri della psiche umana e il dono (rinnovato da anni di esperienza) di una scrittura tanto evocativa quanto cruda e sincera a ogni costo l’hanno portata alla vittoria del Bloody Mary Award nel 2008 per “Femmina de luxe” e nel 2009 per “Io ti perdono” e dello Scerbanenco 2010 con “Ti voglio credere”. È però la Menzione speciale della giuria riservata a “Io ti perdono” allo Scerbanenco 2009, «per l’originalità della scrittura e l’indagine psicologica», a catturarne tutta l’abilità di romanzista. L’indagine sui personaggi è condotta attraverso pennellate impressionistiche − una battuta, un gesto, uno sguardo, un silenzio − che riunite danno vita a ritratti sfaccettati e chiaroscurali: non si tratta di maschere letterarie in azione, ma di uomini e donne (e animali) in carne e ossa obbligati ad interagire tra loro. Zefiro, Ariel, Pietro, la Vergani stessa e tutti gli altri − in un romanzo corale in cui ogni elemento è indispensabile − hanno ognuno una battaglia privata da combattere, ma non possono farlo da soli, a maggior ragione a 2000 metri, in un villaggio dimenticato dal mondo. Si tratta infatti di un mondo altro rispetto alla frenetica città o, meglio, si tratta del “centro del mondo” − questo si insegna ai pochi bambini che ancora lo popolano. Uno spiraglio su un passato di tradizioni in via d’estinzione, di vita adeguata ai ritmi della natura (e non viceversa), di condivisione − per necessità forse più che per libera scelta − in cui “l’unico passo […] fecondo e capace di costruire qualcosa era da sempre quello della fatica”. Di questo è convinto Zefiro, che, in quanto capovillaggio, ha sempre l’ultima parola.
Ciò non significa che il sistema sia perfettamente giusto ed equilibrato, anzi: “c’era una cattiveria diffusa, un gusto di sopraffazione, una volontà di esibire un potere che non passava attraverso l’autorevolezza bensì attraverso la forza”. Il microcosmo ripete su scala ridotta le dinamiche della società moderna: insomma, pare che dove arrivano le persone arrivino i problemi. Lo stesso vale anche per il bosco, contaminato dal cadavere e da qualche scelta umana sconsiderata e irrispettosa − è intelligentemente sottile il messaggio ambientalista. Ma in ogni caso la montagna non accenna a perdere la sua aura sacra, che la mantiene inviolata e inviolabile nonostante tutto: “Le montagne, i boschi, i prati e il sole erano sempre al loro posto. Tutto era tornato silente, così come doveva essere”. Non è un caso che vi trovi spazio anche una presenza soprannaturale, inafferrabile, che porta con sé quella simbologia ancestrale propria delle cose immutabili. Ciò che resta quando tutto passa − minuti, stagioni, turisti, pensieri − è infatti pressoché impercettibile per l’umano e, soprattutto, non lo riguarda direttamente. L’unica cosa che può fare per coglierlo è imparare a riconoscere i pochi momenti in cui si manifesta, affacciarsi alla finestra di una casa walser, tendere i sensi e aspettare. Che cosa? L’eco di un campanaccio, il profumo del sottobosco dopo la pioggia, un capriolo che sparisce tra i pini, la freschezza della nebbia mattutina sulle guance addormentate.