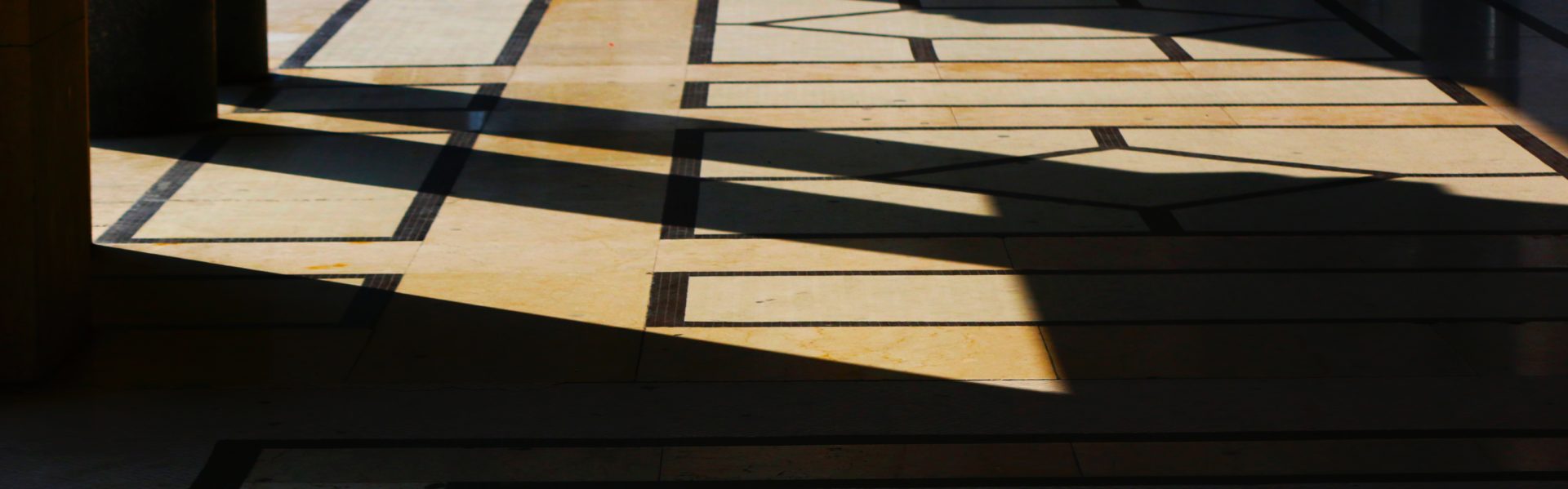C’è qualcosa che si annida nell’Artico. Alcuni lo chiamano Tunbaaq, ciclopico e scimmiesco orso a metà tra la zoologia e il soprannaturale, felice divoratore di uomini; per altri ha nome Sedna, dea della fertilità e dell’abbondanza, benevola e vendicativa, che elargisce il proprio corpo di donna per ogni pagliuzza brillante negli eterni ghiacci del Circolo Polare. Due facce della stessa medaglia: questi esseri non possono esistere l’uno indipendentemente dall’altro. Allo stesso modo non si può cominciare The Terror, serie di dieci episodi su Amazon Prime, prodotta tra gli altri da Ridley Scott, senza prima aver messo in conto di leggere I fucili (The Rifles) di William T. Vollmann, pubblicato in Italia da Minimum Fax e in libreria dallo scorso novembre. E viceversa. Perché entrambi parlano di un viaggio tra i ghiacci e delle conseguenze da esso derivate per chi, in un misto di superbia e belle speranze, abbia avuto l’ardire di intraprenderlo.
Le vicende alla base, storicamente reali, sono quelle della spedizione a Nord-Ovest comandata dal capitano John Franklin: il convoglio, salpato da Greenhithe, Kent, nel 1845, era composto da due navi equipaggiate di tutto punto, la Erebus – comandata da Sir Franklin stesso – e la Terror (da cui il titolo della serie) – comandata da Sir Francis Crozier. Entrambe erano già esperte dei mari del Nord, avendo partecipato a precedenti esplorazioni sotto la guida di Sir James Ross. In questo caso, però, la loro missione non aveva precedenti: tentare di individuare una porta navigabile dall’Atlantico al Pacifico attraverso le regioni artiche oggi canadesi, sopra il Nord America. All’epoca della spedizione Sir John Franklin era un rispettato e ormai anziano ufficiale della Marina inglese; dopo aver ricevuto la vocazione navale già in precoce adolescenza, aveva sia fatto parte dell’equipaggio di Horatio Nelson che partecipato a numerose azioni militari in giro per il mondo, per poi dedicarsi esclusivamente alle esplorazioni geografiche.
Sposato due volte, il secondo matrimonio lo aveva visto legarsi, nel 1828, a Jane Griffin; fu poi proprio Lady Franklin, trascorsi tre anni dalla partenza senza aver ricevuto notizie, a lanciare i soccorsi per la spedizione del marito; fu però solo nel 1850 che un secondo convoglio, capeggiato da Sir Robert McClure, fu inviato a rintracciare quello di Franklin. Da qui in poi, le nebbie attorno all’accaduto si diraderanno lentamente, e le indagini proseguiranno, a vario titolo, fino al Novecento.

Ciò che emerse fu che i due nomi “infernali” delle imbarcazioni si erano effettivamente rivelati tristemente presaghi: inverni inaspettatamente rigidi, scarsa conoscenza geografica del luogo, e, non da ultimo, infiltrazioni di piombo sia nel cibo in scatola caricato a bordo che nel sistema di condutture per l’acqua avevano bloccato la spedizione. L’equipaggio era stato costretto ad abbandonare le navi, incagliate in un ghiaccio che per due interi anni non aveva accennato a sciogliersi, tentando un disperato ritorno a piedi. Stremati dal viaggio, dal clima rigido e dall’avvelenamento alimentare nessuno dei marinai fece mai ritorno in Inghilterra. Si dovrà aspettare Robert McClure per veder realizzata l’impresa: fu questi infatti il primo, durante la spedizione di soccorso, a completare il passaggio nel 1854.
Queste le vicende che, anche dopo 160 anni, non smettono di affascinarci, tanto che ne abbiamo qui due versioni: la serie che possiamo trovare su Amazon Prime, ambientata negli stessi anni della spedizione di Franklin, con protagonisti il Capitano e tutto il suo equipaggio, e il romanzo di Vollmann, il quale, ambientato negli Anni Novanta dello stesso secolo, ha per protagonista un certo Capitan Sottozero, parallelo, quasi una reincarnazione, di Franklin stesso. Entrambi i racconti però, è bene precisarlo, rielaborano liberamente le (scarse) informazioni storicamente documentate sul viaggio alla volta del Passaggio.

Il primo racconto, quello di The Terror, si svolge su crudeli contrasti fra esplosioni di luce e tenebre senza via d’uscita, sinistri scricchiolii tra le assi di legno delle navi e vento che corre impietoso sulla schiena desolata della crosta terrestre: ogni elemento di fotografia e scenografia è reso tassello di una cronaca di morte annunciata. E, se lo spettatore ne rimane accecato, i personaggi addirittura vi soccombono: “terrore” non è solo il nome dell’imbarcazione, ma anche l’unica emozione che gli uomini sanno provare davanti a questo misterioso nulla indifferenziato, popolato da incarnazioni di spiriti maligni e individui arrivati al punto di rottura, che non hanno più nulla da perdere.
Insomma vorrebbe proprio inquietare, questa serie, romanzando gli sconosciuti avvenimenti delle stagioni di prigionia artica di Franklin; mettere in guardia contro le efferatezze a cui può spingersi l’essere umano una volta che ogni appiglio è perso, sepolto sotto strati di ghiaccio perenne. La strategia è però più che già vista; e non bastano le indisponenti fattezze del mostro Tunbaaq o qualche – seppur magistralmente approntato – effetto speciale per risollevare le sorti di una narrazione piatta, che procede senza alti né bassi e che, anzi, avanza per ingiustificati inframmezzamenti di percorso, al termine dei quali l’unica considerazione che rimane in bocca è un amaro: «Embè?»
Se dunque la prima componente del binomio – la serie – ci ha lasciati interdetti e forse addirittura delusi, nel tentativo di avvicinarci vergini al romanzo di Vollmann e al suo protagonista finiamo al contrario per essere violentati, vittime del waterboarding linguistico e figurativo a cui lo scrittore sottopone i propri lettori.
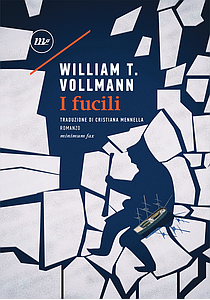
Alle imperiture pianure che abbiamo calcato in The Terror l’autore del libro oppone “fiori gialli” che “ogni tanto ti osservavano dal posto più brullo che ci sia”, oppure un “secondo rilievo a ovest, oltre il quale era stato spremuto un tubetto di meravigliosa luce arancione sulla lama di un terzo rilievo, sormontato da una luminosa distesa di nubi gialle”; o ancora “umide baie azzurre a sud e a est, valli nevose e meandri di fiumi, gli scogli azzurri di un promontorio zuccherato di neve, e nuvole viola che nevicavano in lontananza”. È un paesaggio in flusso di coscienza, quello in cui ci immerge Vollmann, e con così pochi preamboli che ci si ritrova un po’ spaurati, dovendosi improvvisamente destreggiare tra isole d’aria e curve femminili disperse nel gelo perenne.
Ed è proprio in flusso di coscienza che viene condotta la narrazione, strategia che viene solo sporadicamente alternata a discorso indiretto libero, sporadici dialoghi, e repentini cambi di voce narrante. Si è perciò costretti a pensare con i pensieri di altri, a districarsi con la migliore approssimazione attraverso il reticolo delle associazioni mentali, le quali vengono impostate su continui giochi e commistioni di piani percettivi e dimensioni spazio-temporali, per cui dal tempo di Sottozero siamo sbalzati a quello dello sventurato Franklin, del quale il protagonista del romanzo rivive i passi e i conflitti interiori. Si finisce così a spiare inavvertitamente dietro le quinte non solo della Storia, ma, in primis, dell’azione umana: quali sono, di volta in volta, le nostre motivazioni? Che cosa si va cercando negli strani silenzi artici che non si possa trovare a Londra? Ma soprattutto, perché l’uomo occidentale ha portato con sé i fucili?
Eppure, come Vollmann stesso dichiara, tutto ciò, insieme a ulteriori sei volumi sulla colonizzazione del Nord America da parte degli europei, è solamente un Sogno, il quale, come ogni psicanalista freudiano saprebbe spiegarci, non è altro che l’inscindibile unione di fantasia, rimosso, e realtà, manifestata in un linguaggio superiore per quanto in qualche modo obliquo, significante secondo specialissime regole semantico-grammaticali. È al fondo del Sogno che sta la verità: è solo all’ultima pagina del romanzo che il cerchio si chiude e che, pur riconoscendo di essersi persi una dozzina di volte nelle circonvoluzioni dell’intreccio, si sa, nelle viscere, di aver capito tutto.

Scrittura posatamente selvaggia, cristallina conoscenza delle profondità umane, sostanziale inimitabilità: questi i punti vincenti di un trionfo letterario, che possiede la delicatezza del carillon e l’incisività fulminante del colpo di pistola. Corredato, per di più, di mappe, schizzi di esemplari naturali delle regioni artiche, e una lista di ciò di cui dovreste riempire il vostro zaino per pellegrinare in cerca di redenzione verso questo mondo parallelo, dove il tempo non procede linearmente ma sembra collassare sugli esseri viventi. Vollmann l’ha fatto, e a documentare ulteriormente il suo lavoro ha inserito appendici e bibliografia in coda al volume.
L’unica cosa che l’autore si è dimenticato di dirci è se infine giunge una lieta conclusione, se Sottozero riesce a fondersi con Reepah, una giovane eschimese, chiamata da alcuni Sedna, che mangia grasso di foca a mani nude e che era stata amata in precedenza anche da Franklin (sebbene egli avesse già una sua Lady ad aspettarlo nei salotti vittoriani). O se davvero, anche dopo aver combattuto il Tunbaaq ed essersi mangiati gli stivali per allentare i crampi allo stomaco, si rimane ancora convinti che “appena tirato il grilletto il fucile [ci] avrebbe salvato la vita”.