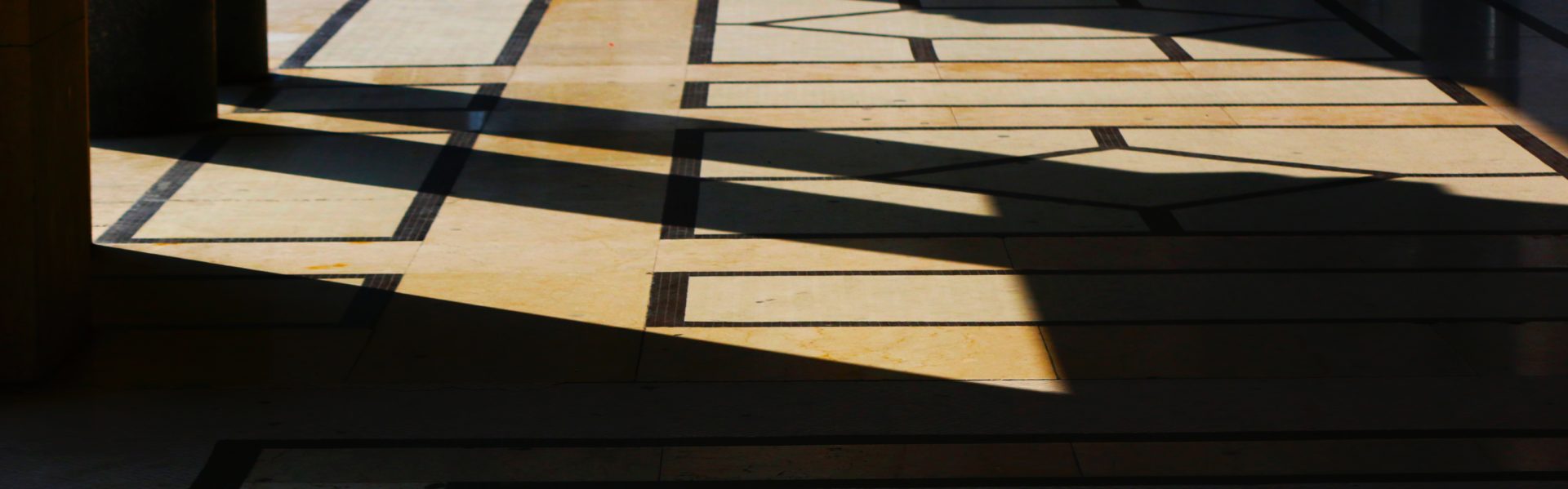Prologo
–Dopo la scola alura vai a scriver le letere?
– No, nonno, non scrivo le lettere, faccio Lettere.
–Ah, ho capì, fai la postina.
–Nonno, vado all’università. Non scrivo lettere e nemmeno le recapito.
–Lo so che vai all’università, bela. Proprio per questo te disi che dopo farai la postina.
Se non son già amò sciopà, ti guardo girare in bicicletta con le lettere sotto il bras e la tua bella “laura” in lettere. Ustì chissà che laurà che te ghe da far.
Omero ha scritto di un uomo che si finge pazzo, perché odia la guerra ed ama la famiglia. Non sto dicendo che mio nonno fosse Ulisse, no, e nemmeno che fosse stato reclutato dai messaggeri di Agamennone; non voglio parlare di Odissea, in queste pagine, e nemmeno di letteratura manualistica.
Ci sarà solo la storia di un uomo che odiava la guerra ed amava la famiglia -ecco cosa ci sarà.
Qualcuno diceva che mio nonno fosse un po’ come Ulisse quando semina il sale sulla sabbia. Dalle mie parti si dice fare lo scemo per non andare in guerra. Era un tipo così mio nonno -che, dietro uno scherzo, ti esaminava come il più preciso degli psicoanalisti.
Mio nonno conosceva benissimo la differenza tra un laureando in lettere ed un postino; mio nonno voleva solo dirmi di giocare fino in fondo, di raschiare l’osso senza scheggiarmi i denti. Era un tipo così, mio nonno, con i suoi silenzi seri, con quelle conversazioni che poi ti logorano dentro per anni. Anche adesso. Un tipo così, mio nonno, che faceva lo scemo per non andare in guerra, che odiava la guerra e amava la famiglia.
Caro nonno, qualunque mare io solcherò, sarai sempre l’Itaca a cui vorrò far ritorno.
Capitolo uno: Mio nonno
Mio nonno diceva che chi scrive va oltre. Oltremare, oltreterra, verso un trascendente oltre, dove io e lui avremmo fatto girare un carillon sulla litania che la gente chioccola quando esiste e si dimentica.
Mio nonno diceva che, prima di imbottigliare il vino, lui guardava la luna. Mio nonno diceva che la luna ha mugugnato, quando l’uomo ha posato i piedi sul suo petto. “Era bianca bianca, anche quando c’era la guerra, adesso la vedi solo a pezzi, in alto, tra le cimase.” Mio nonno diceva così perché conosceva Montale.
Mio nonno diceva che un giorno, un uomo, è tornato dal fronte e non era più un uomo. Era il 1945. Mio nonno l’ha vissuto.
Mio nonno diceva che sarebbe diventato un poeta, se non fosse scoppiata la guerra.
Mio nonno da bambino aveva le orecchie d’asino e da vecchio le ferite aperte, mio nonno. Mio nonno ci è andato al funerale di Montale.
Era il 1981. Mio nonno l’ha vissuto.
Mio nonno diceva che se qualcuno, dall’alto del suo balcone, quel dieci giugno, avesse guardato giù, ora lui non avrebbe bisogno di bendare gli ematomi.
Era il 1940. Mio nonno l’ha vissuto.
Mio nonno diceva che l’uomo sul balcone era in cerca di un posto al sole e, lui, a sette anni, in cerca di un vicolo stretto, non toccato dai rivolgimenti della storia.
Voleva correre in bici, là.
Mio nonno diceva che, per quel posto al sole, ora dal sole cadevano bombe e sua mamma sgambettava per la casa e diceva di correre in cantina, -”che oggi il sole lacrima più forte.” Mio nonno diceva che in cantina c’era la Berta, che stringeva il rosario e pregava. Sentiva quei fischi e pregava più forte. Mio nonno diceva che aveva paura della Berta, perché si tirava dietro uno strascico di solitudine. Aveva paura della solitudine, mio nonno. Aveva paura di morire dimenticato, lui.
Mio nonno diceva che un morto pianto è meglio di un vivo spaiato. Come la Berta.
Mio nonno da bambino reggeva in una mano un brano di legno e uno scalpello, nell’altra. Quel giorno, mentre il sole lacrimava e le nuvole, dall’alto, lanciavano quegli stridi laceranti, la Berta pregava.
Mio nonno diceva che, quando un uomo non ha più nulla, si rivolge a Dio.
Quel giorno mio nonno ha detto che si è stretto le mani intorno alla bocca e ha bestemmiato. Intanto premeva l’indice sulla punta dello scalpello. Si diceva che, se l’avesse premuto più in fondo, le sirene si sarebbero placate.
Mio nonno non sapeva mettere le doppie, ma diceva che la vera poesia fosse quella di occhi che hanno visto e non dimenticano.
Mio nonno, la sera, sedeva allo scrittoio e iniziava ogni lettera con “Iole, colei che porta in sole.”
Lo scriveva in corsivo, nell’angolo in alto a sinistra, per non dimenticarla.
Diceva che la sua materia poetante fosse ricordare il sole che filtrava dalle imposte mentre lei le serrava per ripararlo dalla luce.
Mio nonno mi ha preso le mani e mi ha detto di non dimenticare. Eravamo sul terrazzo, a Sanremo, davanti a noi solo quel mare inerpicato da scogli, che parevano contendersi lo spazio vitale.
Mio nonno diceva che l’uomo che è tornato dal fronte e non era più uomo, un giorno ha misurato la demarcazione del mare: il punto in cui l’acqua smette di essere liquida e diventa cielo. L’uomo che era tornato in paese dal fronte diceva di aver avvistato gocce di salsedine evaporare e diventare nuvole.
Mio nonno diceva che i frutti più succosi hanno alle spalle contadini caparbi che hanno accudito i propri alberi.
Mio nonno diceva che le querce secolari hanno radici ben piantate nel terreno. Mio nonno diceva che il mio albero non si sarebbe fatto piegare da alcun alito di vento.
Mio nonno aveva seminato i miei frutti, curato le mie radici e visto sbocciare i miei fiori. Mio nonno mi aveva lasciata quando l’infanzia chiudeva il cerchio: il giorno del primo scritto di maturità.
Mio nonno sapeva che poteva andarsene perché i miei frutti erano sani.
Mio nonno voleva solo che io ricordassi, e scrivessi, e fossi oltre.
Questo mi ha detto -che abbiamo una grande storia, che l’uomo che torna dal fronte e non è più uomo, che la Berta, che il sole che lacrima gragnola devono vivere ancora. Che abbiamo una grande storia. E deve essere raccontata.
Soffiava il vento a Sanremo.
Capitolo due: Te lo ricordi
Te lo ricordi, nonno, quante lacrime ho versato quando ho dovuto mettere gli occhiali? Avevo dodici anni, l’apparecchio e le gambe secche; avevo i maglioni che mi stavano enormi e la frangetta tagliata storta. Te lo ricordi quello che mi hai detto? Eh, nonno, te lo ricordi? Non mi hai sollevata in aria e nemmeno presa sulle ginocchia, non hai tentato di placare il mio pianto e nemmeno hai giurato che fossi la ragazzina più bella che tu avessi mai visto; questi qualunquismi alla Little Miss Sunshine non erano da te, nonno, ed è solo grazie al tuo essere se, in tempi avversi, mi salvasti.
Tu ti sei arrabbiato, quel giorno. Mi hai detto che la frangia sarebbe cresciuta dritta, che i denti si sarebbero allineati; mi hai detto che la bellezza estetica è uno stadio della vita, ma che nella ricchezza interiori pochi vi affondano.
Mi hai detto che ero bella, perché leggevo e scrivevo, ed ero avida di storie e di storia; mi hai detto che ero bella perché volevo conoscere e sapere, perché coltivavo relazioni autentiche, perché mi facevo voler bene da tutti, anche se di amici non ne avevo molti.
Io quelle sere, nel mio letto, mi sentivo diversa, nonno, e piangevo. Quando hai dodici anni e ti senti un essere fuori dal mondo e dal tempo, non puoi far altro che pensare che la terra giri con un sistema di coordinate su cui gli altri sono riusciti a posizionarti. Ma tu no.
Solo adesso mi accorgo, nonno, che il moto di rotazione terrestre, in realtà, era accordato sul rumore dei miei passi. Non c’è niente di più bello che sentire te stesso e il mondo strimpellare una canzone sulle stesse note.
Quanti anni sono passati, nonno, da quell’ultimo pranzo? Ancora adesso, a volte, sento il sapore acre del troppo aceto sull’insalata, di quelle gocce incandescenti sul bordo della ciotola. Ancora adesso, a volte, vedo la tua canottiera macchiata di sugo mentre, di spalle, ti volgi ai fornelli e scoli la pasta. La tua voce che urla il mio nome e dice di chiudere i libri, che è pronto in tavola; e io che sbuffo, mi sciolgo la coda e poso gli occhiali, mi strofino gli occhi con entrambi i palmi e penso che non riuscirò mai ad affrontare quella maturità.
Cos’è un essere di diciannove anni, nonno?
E’ un bambino che sta dando il commiato ad un mondo cui non appartiene più o un adulto che non osa crescere? Sono entrata nei vent’anni con la consapevolezza di chi sa che, durante quell’anno, è diventato grande ed adulto, mamma, papà, precettore di se stesso. Io penso che a diciannove anni dovessi essere protetta ancora per un po’, almeno fino all’esito degli esami. Penso che a diciannove anni non vi sia nulla di più importante del mostrare al proprio nonno, al proprio padre, al proprio amico e rifugio, il proprio diploma di maturità.
Invece te ne sei andato prima, nonno. Te ne sei andato il giorno dopo quel pranzo, il giorno dopo domenica, il giorno in cui tua nipote posava la zampa nella sua prima vera prova.
E ancora adesso, che sono cresciuta, mi chiedo il perché. Perché ti sei lasciato portar via come una foglia sulla corrente, perché sei sfociato in un mare in cui non avrei mai potuto raggiungerti. Mi volevi insegnare, forse, che le prove della vita, a volte, possono essere molto più dure di quanto si possa pensare; mi volevi mostrare, però, che io ci ero riuscita, che ero andata avanti, che avevo affrontato la maturità con l’anima pesante, ma poi avevo vinto. E avevo vinto per te.
Cos’è la morte, nonno? Quando versavi troppo aceto nell’insalata, quando salavi la pasta e pelavi le patate, quando stappavi il vino e brindavi all’inizio degli esami di maturità, lo sapevi che quei meccanismi, che pensiamo naturali, non avresti più potuto viverli?
Il giorno dopo sono iniziati i miei esami. E tu sei partito.
Sulla tovaglia sono rimaste le briciola dell’ultima colazione della tua vita.
Io non so dove vada la gente quando muore, nonno.
Non l’ho mai saputo e sono diventata matta; mi sono presa la testa tra le mani fino a quando le tempie non pulsavano, fino a quando non mi addormentavo stremata sul letto con le ginocchia piegate. Mi svegliavo il mattino dopo ricoperta di interrogativi cui nessuno sapeva dare risposta.
Chiudevo gli occhi ed immaginavo l’infinita mutevolezza della vita, chiudevo le tende e pensavo all’infinita corsa, della vita.
Pensavo ad un ruota che macina chilometri, che mentre inizia un giro lo sta già terminando. Pensavo che dopo oggi, viene domani, e un altro domani ed un inesauribile domani e tu intanto sei un po’ spento, perché
hai lasciato correre il tuo ieri e un altro ieri ed un inesauribile ieri.
Pensavo ad un corda di cui non scorgi la fine, accompagnata da una sequela indefinita di numeri. Pensavo al più grande dei numeri primi, al più grande degli infiniti, pensavo all’anno con il più alto numero di cifre che un umano potesse vivere. Pensavo a quante cifre possa avere l’anno vissuto da un uomo che è ancora un uomo. Pensavo a tutto questo, a diciannove anni, mentre i miei amici mi schernivano dicendomi di prenderla come venisse, ‘ché pensare facesse venire i brufoli.
Io pensavo che ognuno di noi fosse un irrilevante segmento di quella corda inesauribile. Loro si facevano sgozzare, da quella corda, senza nemmeno accorgersene, per poi ritrovarsi, dieci anni dopo, senza più ossigeno nelle vene. Sgozzati, a vent’anni, da una vita che si comandavano di vivere.
Oppressi -ed oppressori loro stessi- dal larvato bisogno di coprire l’odore di marcio emanato da quelle domande per cui non volevano cercar risposte.
E intanto loro, elettroni, continuavano a girare su quell’orbita stanca dal raggio infinito. Ognuno dalla sua parte, credendo di rincontrarsi, poi, in un qualche punto di quella circonferenza. Ma, durante il giro, disperdevano energia, ripiegandosi su se stessi. E l’orbita si chiuse sino a collassare. Cercavano allora, il compagno, -l’amico, l’elettrone- che viaggiava con loro, in quella strana circonferenza, salvo accorgersi che l’atmosfera è troppo grande e noi -noi esseri- troppo caducei per vincere contro la meccanica quantistica dell’universo. Sono esplosi come supernove, morti senza saperlo.
Precipitati in un buco nero dove tutto vi scivola, hanno preso consapevolezza dell’accidentalità dell’esistenza, rinchiusa ormai nella prigione delle cose vissute ma dimenticate.
Capitolo quattro: Annullamento
Era dalla morte di Cigno d’oro che non mi capitava di pensare che avrei potuto annullare, in una mattina qualsiasi, me stessa e il tutto.
Una mattina mi sarei voluta svegliare con la consapevolezza di chi sa che quella è l’ultima occasione di vedere il sole sorgere, l’ultima alba della vita, l’ultimo cielo plumbeo. Uscire sul balcone e respirare, in un attimo, tutto il coraggio che non avevo avuto in una vita, respirare il cielo bianco che promette neve, il volo di un uccello che lascia quel cielo, respirare l’inverno che verrà e pensare all’inverno che non mi ha mai lasciata e al gelo che non si è mai squagliato al sole; respirare il cigolare della bicicletta del postino, il rumore della casella che sbatte, delle raccomandate che cadono sull’uscio -pluf- respirare la quotidianità e lasciarsi, in una mattina qualsiasi, morire. Lasciare tutto mentre l’alba cade.
Forse era tutto quel nichilismo ad atterrirmi; l’assoluta noncuranza che la Terra, il mondo, che Dio, serbava nei nostri confronti. Non so chi ci abbia creati, nonno, e non so neanche cosa fossimo in archè, ma so che la nostra fine è assolutamente irrisoria nell’economia del mondo. Non c’era nessuno a proteggere la nostra fine, non c’era alcun Dio che vegliasse sui nostri giorni -un essere solo per sette miliardi di individui tradisce ogni logica distributiva, nonno.
Non c’era alcun Dio -o se c’era era morto anche lui- altrimenti Cigno d’oro e i suoi ventuno anni non si sarebbero, in una mattina qualsiasi, spaccati come onde sulla battigia. Lui, che era risacca.
Era tutto questo a spaventarmi. L’idea che non ci fosse nessuno a manovrare i nostri fili vitali, l’idea che anche quel macchinista di balocchi fosse morto, l’idea che non ci sarebbe stato alcun luogo dove poterci incontrare. Di nuovo.
Questo me lo dicevi sempre tu, nonno. Dicevi che la gente ha paura ad ammettere che non c’è alcun Dio, per noi, e preferisce cullarsi nell’imperioso bisogno dell’ideale ascetico provvidenziale.
Come in una sorta di poesia bucolica, si modulano un luogo ameno, sospeso nell’immutabilità del tempo e dello spazio, in cui godere della pace eterna suonando zampogna sotto un alto faggio.
Se la gente ha paura di morire, dicevi, è proprio perché teme di non trovare nulla di tutto questo.
Ma, nonno, da morto non potrà mai sapere se quell’ideale sia stato disatteso.
Avevo quattordici anni e mi figuravo una sorta di cielo Mironiano. In quel tempo la morte era una distesa di Blu e noi nient’altro che i punti neri di quel blu, punti neri nell’universo. Cosa fosse il tratto rosso dipinto, non riuscivo ad immaginarmelo, ma non volevo neanche perderci dietro troppe energie: ai tempi non provavo grande simpatia per i Surrealisti in genere. Ora credo siano stati in grado di penetrare nel mio intimo e tradurre in concreto tutto ciò che di più incomprensibile vi sia nell’astrattezza del vivere. E, adesso, in quei punti neri, tra quell’ammasso astratto di colori vivi, non vedo più noi esseri e la nostra accidentalità, quanto, piuttosto, un vortice scuro che risucchia ogni materia.
E’ questo l’assurdo. Noi uomini temiamo più quello che non potremo fare quando non saremo più uomini, piuttosto che quello che ci siamo dimenticati di fare da vivi.
Era questo, mio nonno.
Capitolo cinque: La fine della storia
Mi manchi.
Avrei voluto che vedessi almeno il diploma -dieci giorni dopo-, il primo stipendio -pochi mesi dopo-, il primo bonifico, la patente; vedere me che stringevo tra le mani i miei primi volumi universitari -di questo avrei voluto imbevessi i tuoi occhi.
Se ci fossi ancora stato, saremmo andati al ristorante, dopo la patente. Ti ho sognato, col tuo giubbotto marrone, la coppola e le mani in testa, che mi aspettavi sul ciglio della strada. E’ stretta quella curva per entrare in casa tua. Per poco non mi moriva la macchina, ma ho schiacciato la frizione e l’ho salvata.
Scrivo in penna verde, vomitando, su un foglio bianco, caratteri cubitali.
Ora ti sento. L’altra notte ti ho sentito, mi tenevi la mano.
Ti penso quasi sempre,
anche stasera in verde.
Io non so scrivere un romanzo perché una parola mi apre una via e poi un’altra; arrivo in una radura troppo vasta in cui non so come muovermi. La mia professoressa del ginnasio mi diceva che ero peggio di Gadda: credo alludesse al fatto che non ci fosse un finale ben definito, nei miei scritti. Quella del triennio del liceo era innamorata del modernismo europeo degli anni venti e paragonava i miei temi ad un continuo flusso di coscienza. In realtà credo che le stessi simpatica e dovesse trovarmi una motivazione altisonante per affibbiarmi voti altisonanti.
Qui non c’è un inizio e nemmeno un fine. C’è una raccolta di ricordi che mio nonno mi ha lasciato tra le mani mentre mi salutava. Un giorno, forse, me ne verranno in mente altri e riuscirò ad impastarli insieme in una forma.
Un giorno, forse -quando avrò metabolizzato la fine di un uomo che cade dalla bicicletta e picchia la tempia sul marciapiede.
La coppola era finita sulle strisce pedonali, riversa, a forma in giù.
Il pedale altalenava.
Dicevo che chi vive all’impasse ha bisogno di illudersi di spaziare in un cronotopo cosmico e sterminato, senza dare per forza un finale ai propri scritti.
Forse sto diventando come la mia professoressa del triennio, che li definisce uno stream of consciousness per convincersi io scrivessi bene.
Sto dilungandomi oltre un’altra volta. Chiudo con una poesia, che, per chi sta nell’impasse, è la via di fuga.
“Mi hanno chiesto dove si vada
e io ho risposto dove si rimane:
nell’inchiostro delle parole
che cadono di notte
e fanno troppo rumore
e poi nella fiamma
che danza di una candelina non accesa
quando fa male ricordare i compleanni
di chi si è mosso verso il dove si vada.
E cosa mi manca non lo possono sapere:
gli insegnamenti forse
e il nerbo
e la storia di chi non vuole che la storia si riveda.
Le rughe tue da sbattere in faccia all’ignoranza di chi la storia la distrugge e la distorce
e la tua voce che spacca il silenzio quando decanta la dolcezza delle ciliegie
nel quarantatré.
Mani grinzose nere
e il sole le cucina a suo piacere
mani come antichi segni di un’esperienza antica
di una battaglia combattuta
di una memoria condivisa.
Per le ciliege che crescevano dolci
mentre la vita si faceva dura
per l’ignoranza che hai combattuto
e gli ideali in cui hai creduto.
Per la storia che hai vissuto
per il valore della memoria
che hai insegnato
per la forza della poesia
che mi hai seminato
mentre la stagione tua si chiudeva in un unico cerchio.
Dovunque sei ascoltami se puoi
leggi queste righe se ancora ce la fai
e cerca di tirarmi fuori della conoscenza quella sete che
viveva insieme a te.”