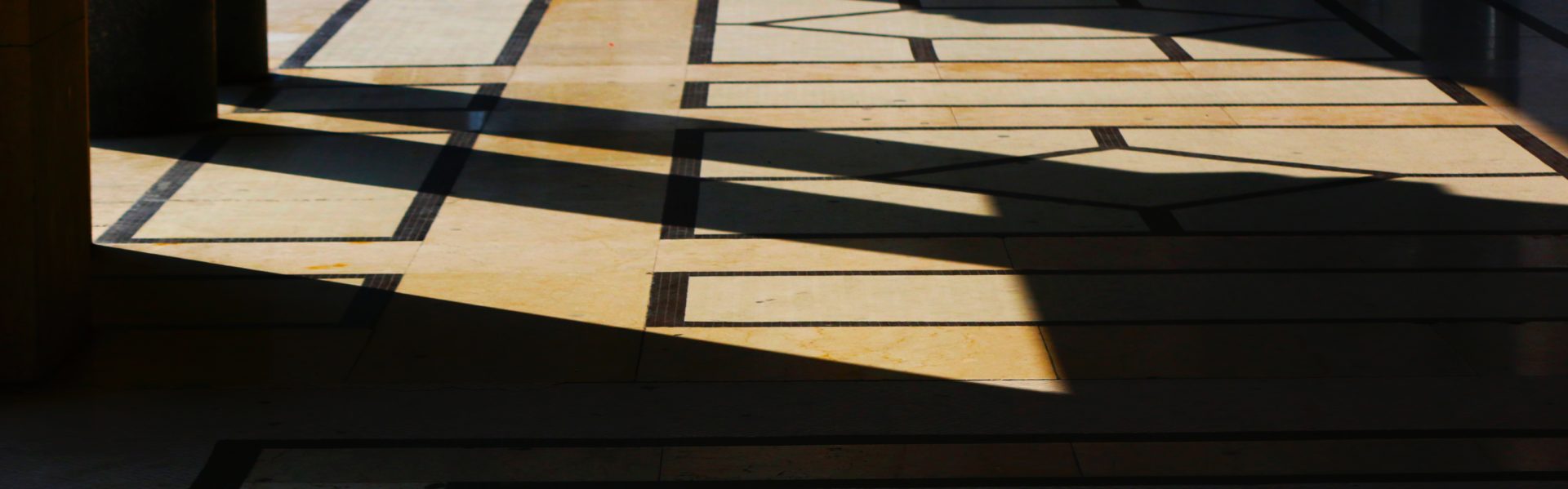Ho sempre pensato che le storie dovessero avere un inizio e un punto in cui trovano la propria fine: qualcosa che accade e, poi, smette di succedere. Tutto lì, un groviglio di fili che qualcuno tesse e disgrega, come se niente mai -mai più- possa andare ad intaccare quelle trecce lasciate ora al vento. Perché qualcuno ha deciso che così dovessero concludersi, perché un altro ha disgregato la matassa con un’azione risolutiva, perché una penna vi ha posto la parola fine. Sarebbe semplice, forse, se fosse così, se la vita fosse un rassicurante susseguirsi di fabula, sequenza ed intreccio.
Credevo che la storia che mio nonno mi aveva chiesto di raccontare sarebbe andata così, che avrei allineate, ad una ad una, le tessere del domino che lui aveva iniziato a spolverare. Mio nonno voleva solo che io rimettessi le tessere al proprio posto, che dessi un senso al suo aver vissuto, che il suo non fosse stato solo un occupare un posto, su due piedi, quattro arti, per 81 anni. Voleva rimanere -e rimanere nelle sottolineature di un libro in cui trovare chi si è allontanato, nella polvere di un vinile di Elton John che inumidisce gli occhi, nella melodia ancestrale di Bob Dylan, nelle parole che cadono e provano ad assumere la fisionomia di un intreccio che non riesce a prendere forma.
Pensavo che la vita -e la storia di una vita- potesse ridursi al semplice allinearsi di tessere di domino che qualcuno aveva provveduto a spolverare e passare di mano in mano.
Più volte ho provato a scriverla, questa storia, e più volte mi sono scoperta a cancellarla, a perderla, a lasciarmela dietro, salvo poi comprendere che, proprio nel cancellarla, la stavo riscrivendo -dentro di me, tra i fili del tram, davanti ad un’onda che si spezza, in un aereo che sale, nell’alba che cade.
Mentre stavo cancellando quel rassicurante susseguirsi di fabule, intreccio e consequenziali segmenti, lasciavo posare le parole nelle giunture più segrete, tra i ricordi che nemmeno sapevo di avere, in quegli odori confinati negli spazi cerebrali più longevi. Parole lasciate lì, a crescere, nella luce di un uomo che bramava di esistere ancora.
E così l’ho capito: che quando chiedeva di raccontare una storia, non voleva parlassi dei tedeschi che fanno irruzione in casa quando la notte è più buia, di suo padre portato via con le mani dietro la schiena, di sua madre che piange e, nei gesti convulsi di cui solo una donna è capace, prende ad agitare il frustino della polenta. Di sua madre scaraventata in un angolo e degli occhi decenni di un bambino che, dal buio della sua stanza, impara cosa sia l’odio e si chiede come mai potrà cedere all’amore quando spunterà il giorno e se mai la notte lo lascerà. Non voleva parlassi, poi, di Mauthausen, dei campi di lavoro, della soppressione del Partito Comunista, dei vestiti arraffati, la mattina dopo quel buio, per mettersi al riparo, per scappare, per andar via.
Mio nonno non sapeva come fosse riuscita a finire quella notte, -ripercorreva il corso degli eventi, da vecchio, alle volte- ma non riusciva a ricordare il momento in cui i cannoni avessero smesso di tuonare, in cui lui è riuscito a cedere, senza paura, alla rassicurante quotidianità di una vita macinata giornata dopo giornata.
Era questo che voleva raccontassi: lo sfavillante ritorno dell’ordine dopo il vuoto della vita, le ginocchia che tornano ad ergere in piedi il corpo ammaccato, il sole che fa capolino tra i pensieri surclassati dal terrore.
Questo, solo, era il senso del suo chiedere: che imparassi, da lui, a vivere, a non cedere a malinconie inessenziali, che permettessi alle parole di leccarmi le ferite, che non le lasciassi sanguinare, che trovassi il mio cerotto. Che assegnassi, alfine, ad una storia il senso di questo trovare. Voleva mi ergessi, mentre sapeva che quello che mi tratteneva supina era l’eco di interrogativi da cui solo questa storia avrebbe potuto salvarmi.
Lui si era salvato, ora toccava a me, ad una storia da comporre, ad un coraggio nuovo di cui vestirsi. C’era la commuovente disfatta di cui solo i vinti sono capaci in questa storia che non è più stata una storia, un’ammessa incapacità di raccontare che si affida allo stridere dei ricordi che hanno visto.
Era il 1955, aveva poco più di vent’anni, appena uscito da un’adolescenza bastarda che gli aveva lasciato i segni impressi: della guerra, della fatica, del buio, della disfatta.
Era il 1955, aveva ventidue anni lui, venti, la mia nonna: era orfano di entrambi i genitori, consumava le giornate tra l’amianto che gli succhiava via i polmoni. Il papà di mia nonna era stato fascista, il suo i fascisti gliel’avevano portato via quella notte in cui, mentre si reggeva disperatamente con i polpastrelli alle barriere della paura che atterrisce, si era scoperto, suo malgrado, ad imparare l’amore, la malinconia, la struggente mancanza di una figura portante, la commozione, le lacrime, il terrore, la vita, l’essere uomo: il cedere ai sentimenti più elementari.
Aveva interrotto la scuola a quattordici anni per prendere il posto di quel suo padre alle raffinerie, mia nonna a quattordici anni iniziava il ginnasio e non voleva portarsi addosso il peso del dizionario di greco. Lei il greco lo conosceva, conosceva il latino e anche il francese, ma le lettere le scriveva mio nonno e le fiabe, poi, era sempre lui a raccontarle.
Eppure c’era qualcosa che azzerava quel livello diastratico, esisteva una strada in cui si incontravano insieme: la guerra di mio nonno, il senso del suo fieramente esistere, non è finita con la liberazione di Italia, la sua guerra si è conclusa dieci anni dopo quando la vita incominciava anche per lui.
Era il 1955 quando si è placato ogni tuono di cannone in quella perfezione danzante dell’armonia di cifre tonde. La seconda metà di un secolo atroce.
Elvis Presley, in quell’anno, cantava “I’ve got a woman”. Lui appoggiava le sue armi: poteva smettere di combattere.