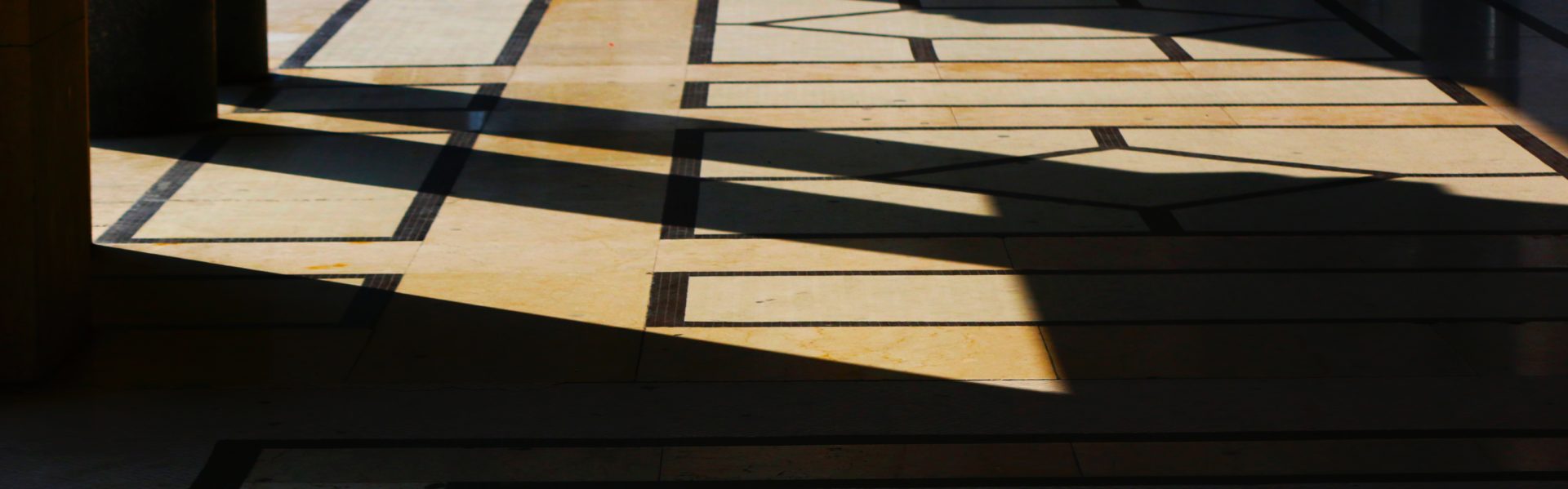Io sono il massimo esperto in questo campo. Ho la capacità di infilarmi in situazioni talmente impossibili da non riuscire più a uscirne. Se qualcuno fa domande sospettose ho solo una possibilità: sostenere a qualsiasi costo la verità della mia storia. Neanche mi accorgo di arrivare al punto di non ritorno, aggiungendo pezzi di semi realtà un po’ alla volta.
Ecco come sono arrivato qui: un cassone pieno di capre, tutto quello che merito. Le capre da vicino puzzano molto e su questo, ve lo giuro, non dico balle. Sono saltato sul furgone a pochi metri dalla cabina telefonica e le capre non si sono stupite, probabilmente lo fanno tutti.
Alcune bugie sono esageratamente grandi, come quelle che ti porti sempre dentro: non dico così grandi da pensarci tutti i giorni; ma fino a quando restano qualcosa non va. Del resto indietro non torno e non c’è mai una cosa uguale oggi e domani.
La capra di Felù mica puzzava così tanto. Cosa ti fa mangiare il tuo padrone? Non guardarmi così, ti prego, sono già abbastanza triste. L’avrei messa solo nei guai Felù.
Tiro fuori la mappa dalla tasca, ma sui cartelli in strada non ho ancora visto uno dei nomi riportati qui sopra. Le capre iniziano a belare. Puzzano e urlano. Una di loro sta male, non respira bene. Il furgone si ferma e così il mio cuore. Infilo la faccia nel maglione.
Siete capaci di sentire gli occhi di qualcuno guardarvi? Io, purtroppo, sì. E questa volta non posso neanche fare finta di niente. Il suo respiro esce dal naso e tanto profondo da spostarmi i capelli. Puzza di tabacco, come mio nonno Julien. Eppure sta lì immobile, aspetta una mia mossa. Sbuco dalla maglia a occhi chiusi, li apro e la capra è sdraiata davanti a me, morta. Penserà sia colpa mia?
L’uomo fischia come per chiamare un cane, poi con la testa mi fa segno di scendere. Tremo al solo pensiero di avvicinarlo, ma è lui a farsi incontro, quando siedo sul bordo per saltare mi prende in braccio e mi carica sul sedile accanto al suo. Partiamo.
A dónde vas? Chiede lui. Gli faccio vedere il nome sulla mappa. Non dice né domanda più niente. Deve essere il loro modo di mettersi nei guai il meno possibile aiutando chi ne ha bisogno. Anche in questo il signore mi ricorda nonno Julien, incapace di dire no a chi stava peggio di lui.
Dopo due ore di guida, rallenta e indica un cartello.
El Bolson!
Dico gracias tipo dieci volte, scendo dal furgone e vado per la mia strada.
La mia strada, sarebbe meglio dire per la strada, non ho idea di quale sia la mia. Riesco a procurarmi un rifugio, caldo e riparato dal vento, e studio la mappa: proprio non so come raggiungerò la grotta. Sarebbe già tanto arrivare al museo dall’altra parte della strada senza dare nell’occhio: solo, zaino in spalle, zero possibilità di formulare una frase intera. Chi voglio prendere in giro? Ma, come da qualche giorno a questa parte, il mio corpo prende le decisioni e si muove, fuori, dove tutto fa paura. Cammino e imploro qualcosa al cielo, per la prima volta in vita mia sto pregando, o almeno credo si faccia così. Un pullmino sbuca dalla curva fondo strada e si ferma a qualche metro. Una scolaresca scende a fiume. Infilo un cappellino e mi mescolo tra di loro, guardo tutti e nessuno, tutto e niente. Mi sposto da un fianco all’altro, non lascio il tempo alle domande. Il piano sembra funzionare, ma all’altezza del museo la fila prosegue, io mi fermo, una bambina si gira indietro una volta, un’altra ancora e poi di nuovo, si è accorta di me, ma non fa niente, continua a camminare. Sbuffo tutto il fiato sospeso e mi giro verso l’ingresso, qualcosa inventerò. O forse no. Un’asse di legno vecchia e brutta sbarra la porta, il museo è chiuso. Tengo lo sguardo fisso sulla strada, e mi bagno le scarpe. Voglio del latte caldo e un dulche de leche. Attraverso la strada, entro in una caffetteria, non mi importa più di niente. La cameriera ha uno sguardo gentile, mi fa sedere al bancone e mi tratta come un uomo. Il locale è pieno. Dall’altra parte della stanza è seduta una signora, l’unica altra persona sola. Non riesco a smettere di guardarla, e anche se lei sembra avere il mio potere e se ne accorge, io continuo a fissarla. La signora risponde con occhiate dolci e veloci tra un morso al suo panino e un sorso dalla tazza. Ma quando una lacrima attraversa silenziosa la mia faccia, lei ferma il suo sguardo intenerito nel mio. Sorride, è come ricevere una carezza. Lascio del tempo alle coccole di fare il loro mestiere e qualcosa comincia a frullarmi in testa.
Qualche anno fa, in una delle estati da zia Rinaldin, ho scoperto un alpeggio diroccato. Nessuno sembrava averne fatto più uso, eppure le stanze erano piene di cose. Ho passato il resto dell’estate a farmi compagnia tra quelle cose.
Museo chiuso, montagne di materiale, nessun controllo. Devo solo aspettare il buio.
La parte difficile sono le spalle, passate quelle, il resto è già dall’altra parte. Il museo sembra chiuso da molto tempo e non ci sono segni di lavori in corso. Accendo la torcia, mi avvicino alle teche appese. Passa qualche ora, nessuna traccia della grotta, sembra davvero che nessuno l’abbia mai trovata.
Mi siedo a terra, c’è una scatola nello scaffale difronte. Togo il coperchio e un disegno copre tutte le altre cose, sembra fatto da un bambino, comunque qualcuno più piccolo di me, oppure qualcuno davvero scarso. Ci sono delle curve, sembrano onde stilizzate, e una grossa X tra la terra e il cielo, non sospesa ma incastonata in qualcosa di molto simile a una grotta. Il disegno mi trema nelle mani mentre indago quello che nasconde: fotografie, scritti, carte di cioccolatini, qualche biglietto del bus, altri disegni. Guardo meglio la scatola, sotto il coperchio c’è una striscia di scotch con scritto Familia Alquenta. Scavo ancora, c’è un articolo di giornale, parla di loro, mi sembra, ci sono gli stessi visi raccolti in un’unica fotografia dove sorridono tutti. Ricerca e grotta sono le uniche parole che capisco, ma né nell’articolo né nella scatola campare la grotta. Di nuovo. Il loro diario di bordo, comunque, sembra la cosa più simile a una guida, e passo la notte a incollare tutto sulle pagine di un vecchio quaderno.
Cammino da due giorni e ormai sento ogni passo cadere nel vuoto. La terra qui è umida e fredda, non ci sono molti riferimenti, giusto le piante variano da ciuffi di erbacce a cespugli di vai a sapere che bacca. Non ci sono alberi, né fiumi. Comincio a capire perché nessuno abbia mai saputo ricostruire la strada. Ho dormito sotto le stelle e questa è l’unica consolazione. Ho sentito le balene e questo mi fa sentire in un posto sicuro. Ieri mi sono fermato per qualche ora vicino a un grosso sasso, solo dopo un’ora ho capito che erano due: uno piatto, uno alto poggiato a diamante sopra il suo compagno. Tra i due c’era una fessura, non so come facessero a stare insieme, eppure sembrava potessero esserlo per sempre. Sono rimasto al loro riparo mentre consultavo il quaderno, confrontandolo con le mappe prese a casa di Felù. Speravo in un dettaglio comune, cose parte del paesaggio immortalate dietro a soggetti più importanti, ma niente. Avevo due possibilità: rimanere parte delle pietre o continuare a camminare. Ho scelto la seconda, ho paura delle cose ferme, anche quel masso cominciava inquietarmi.
Magari, a furia di camminare, inciamperò nella caverna, scoprirò un sentiero mai percorso, troverò quel dettaglio.
Oppure camminerò solo nel vuoto.