C’è un motivetto che mette insieme tutti i pezzi della mia infanzia ed era quello che canticchiava mia nonna, caricandomi sulle ginocchia, quando faceva caldo e non riuscivo ad addormentarmi: “Presto la pioggia suol venire a noia, ma in Luglio è un ricco dono e apporta gioia.”
Sono nata in luglio, nel giorno che è il primissimo numero palindromo della serie, oltre ad essere il quinto dei numeri primi.
Le mie estati le trascorrevo tra le pareti ancestrali di un’abitazione che, qualche anno prima, si era tappata le orecchie di fronte allo strillio nascituro di mia cugina, aveva assistito al trascorrere degli anni di mia mamma e di mia zia e, indietro, aveva registrato, nei propri bulbi oculari, le immagini nunziali dei miei nonni ventenni; aveva aperto le porte a mio nonno decenne sfollato dalla guerra, aveva assistito all’infanzia lieta, all’adolescenza burrascosa, all’età adulta, al macinio degli anni, fino all’inevitabile ineluttabilità -di ognuno di noi.
Era una casa sul limitar di un bosco della Valsassina: dietro, la cuccuzza di dolomia del Monte Serrata, davanti solo un burrone che cadeva a gradoni fino ad annegarsi nel torrente sottostante, insieme alle leggende folcloristiche di quel bosco che atterrivano dall’interno tutte le generazioni di bambini della nostra famiglia. Una casa, lì, nel nulla, che sembrava piovuta dal cielo per stringere le vite di tutti noi e mescerle insieme.
Avevo otto anni -l’11 luglio del 2003-, era uno dei miei ultimi compleanni che avrei trascorso lì prima della demolizione di quella casa bicentenaria e, quella mattina, mi svegliai convinta di sentire un odore, un effluvio, un olezzo che avrei voluto saper descrivere, ma non sapevo come. A ripensarci, non avrei nemmeno saputo dire se fosse un profumo o un odore sgradevole; a ripensarci, non avrei nemmeno saputo dire se non fosse che un convincemento mentale di quanto sentissi internamente. Era una delle prime volte in cui avrei sperimentato la tristezza, un’insolita mestizia che volevo sciogliere in pianto a dispetto degli occhi che rimanevano asciutti, un vuoto nel petto che, poi, mi avrebbe accompagnata in ogni momento.
Sentivo, intorno a me, come un nidore -ecco cos’era-, un’esalazione acre di qualcosa che stava andando in fumo, l’odore della carne quando si brucia sulla griglia. Era la mia infanzia che sentivo allontanarsi, la mia famiglia che faceva un balzo avanti lasciando la loro storia incastrata tra quelle pareti che sarebbero state, presto, cenere al suolo; era un olezzo di morte, di qualcosa che stava eclissandosi lasciandomi la mano pian piano. E, così, lo chiesi: -“Mamma, ma tu non senti l’odore della nonna che non c’è, dei grilli che rimarranno sul tetto, del muschio che non marcirà più, delle lacrime delle pareti?”
“Non si può sentire l’odore di qualcosa che non c’è, l’olfatto è un organo di senso che si avviluppa intorno a qualcosa della nostra realtà empirica.”
Ma io ero sicura di riuscire a sentirlo.
Quella sera stessa brindammo per i miei otto anni, versando spumante nei calici del servizio matrimoniale della mia bisnonna prima che finissero tutti in scatoloni marroni dalla scritta Fragile. Avevo otto anni, appunto, le pareti piangevano, c’era odore di cose che stavano per non esserci più ed io, avvicinandomi il bicchiere all’orecchio, sentì le bollicine cantare: era una sorta di tip tap, con quelle minuscole cavità sferoidali gassose che scoppiavano e si ricomponevano vicine, si attaccavano disperate allo smeriglio del vetro come naufraghi in cerca di salvezza, per poi implodere e diventare acqua. Era una sorta di melodia nuova, una musica mai ascoltata, era la mia canzone preferita, perché avevo la sensazione che solo per me fosse stata composta e, solo io, potessi origliarla.
Avevo otto anni, ero nata il giorno undici -il quinto numero primo e primo numero palindromo- di un mese “ricco dono che apporta gioia”; avevo un nome inusuale e bizzarro che i bambini sbagliavano a scrivere e mi chiedevano di ripetere -Miriam-. Mi portavo addosso un nome che nessuno aveva nella mia scuola elementare, avevo trascorso i miei primi otto anni all’ombra del monte Serrata che Manzoni aveva registrato nella memoria collettiva come Resegone, sentivo le bollicine cantare, le pareti piangere di malinconia, sentivo gli odori delle cose che stavano per non esserci più. Mi convinsi che ci fosse una magia in tutto questo, che mi portassi sulle spalle, come uno scialle, un destino speciale, qualcosa che avrei voluto comunicare alle mie amiche per far loro capire che, no, non mi stavo inventando bugie, erano cose che esistevano realmente, che meritavano di essere scoperte.
E, così, lo chiesi anche alla maestra, con tutto il candore di cui sanno vestirsi i bambini di otto anni: “Come faccio a dire alle mie amiche delle bollicine che cantano e poi muoiono sul vetro, del pianto delle pareti, che ho sentito un odore di cose che bruciano lentamente?”
Mi rispose che era necessaria una certa sensibilità, che avrei potuto provare ad assorbirla dalle pagine dei libri, che adesso mi sarebbe sembrata una cosa difficilissima ma sarebbe venuto un giorno in cui scrivere della danza delle bollicine sarebbe stato, per me, naturale come respirare, come tapparsi gli occhi sott’acqua ma avere, poi, il coraggio di aprirli nonostante il sale.
Io volevo riuscire a scrivere di quel nidore e, forse, presto, avrei potuto trovare gli strumenti: mi tesserai alla biblioteca del quartiere e mi misi a cercare, a sfogliare, a far miei, tutti quei libri dai quali potevo risucchiare la sensibilità di cui diceva la maestra.
Nel frattempo le scuole elementari finirono, finirono anche le medie e arrivarono i quattordici anni e il tempo della scelta. Forse sarei riuscita a parlare meglio del lamento straziante di quelle pareti se mi fossi misurata con la classicità romana e con quella d’oltremare, se avessi imparato cosa stava dietro a quelle parole che cercavo invano di maneggiare, se avessi affondato le mie radici in radici più solide che, a loro volta, affondavano negli abissi scuri di un terriccio che si ergeva sulla storia di altri.
I Greci, i Latini, Dante, la filosofia: il racconto di Plinio sul Vesuvio imploso mi ricordava le pareti di quella mia casa, l’incendio di Roma di cui scrive Tacito aveva emanato un odore ancora più acre del nidore di quella mia casa, il coro là fisso sull’orchestra cantava il dolore straziante di Medea, di Elettra, di Antigone, la morte di Alcesti, l’amore sbagliato di Fedra. Erano tutte donne, come me, dal nome ancora più insolito ma più bello. Oρχέομαι significava proprio “mi muovo danzando”, come le bollicine che poi scoppiavano.
Erano trascorsi più di duemila anni, ma ritrovavo me stessa, c’era tutta una fitta rete di corrispondenza tra il mio sentire e il loro: forse era questa la sensibilità, la simpatia, l’empatia, il sentire insieme di cui mi aveva detto la maestra dieci anni prima. Trascorsi con quelle donne cinque anni pienissimi, sicuramente i più formativi, salvo poi scoprire che, no, non ero ancora pronta a lasciarle: fu così che mi iscrissi alla facoltà di Lettere e cercai, ogni sera, ogni volta che mi sentissi prudere le mani, di mettere giù per iscritto, con la penna, l’odore delle cose che non ci sono più.
Adesso, di anni, ne ho ventuno, studio Lettere, ho smesso di struggermi sul modo in cui scrivere di quel canto, di quel lamento, di quel nidore, di quelle mancanze. La maestra, nel 2003, aveva ragione: presto usare quello strumento sarebbe stato naturale come respirare. Lo stringo tra le dita, adesso, lo strumento.
Guardo l’anulare diventare violaceo, il callo sul pollice ingrossarsi, mentre spero, un giorno, di essere quella voce del coro che,tra i banchi, possa intonare del dolore inspiegabile di Orfeo mentre risale solo dagli Inferi, della voce nonnesca di Montale mentre instilla il coraggio di vivere su questa muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
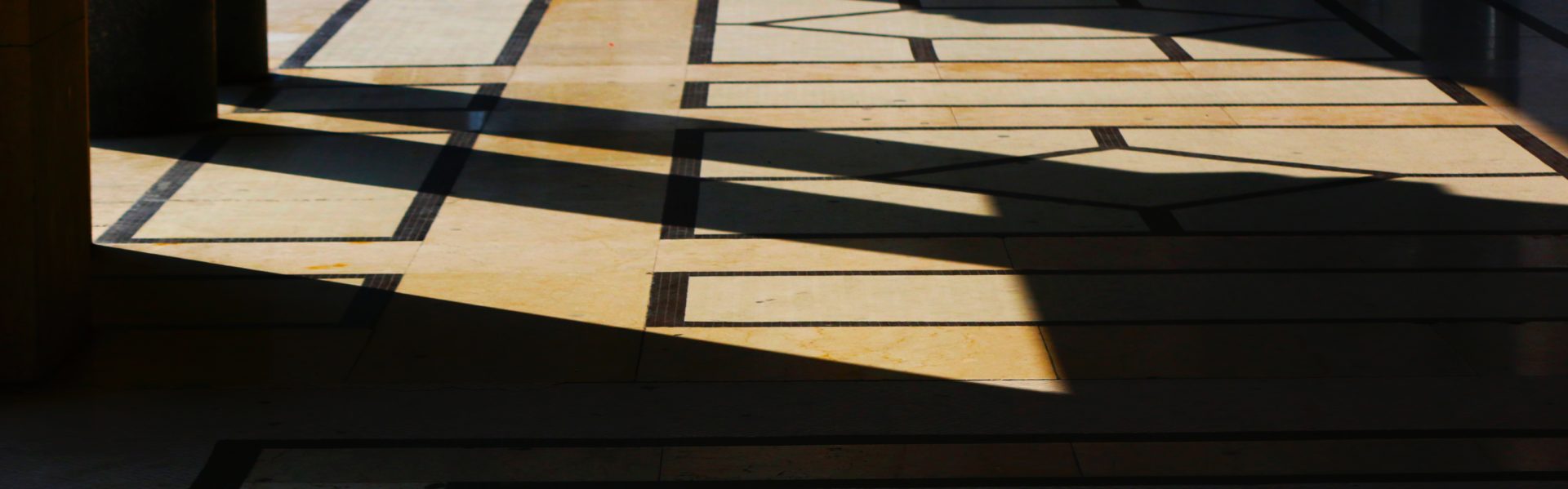

Un pensiero su “Il motivo per cui siamo”
Complimenti!