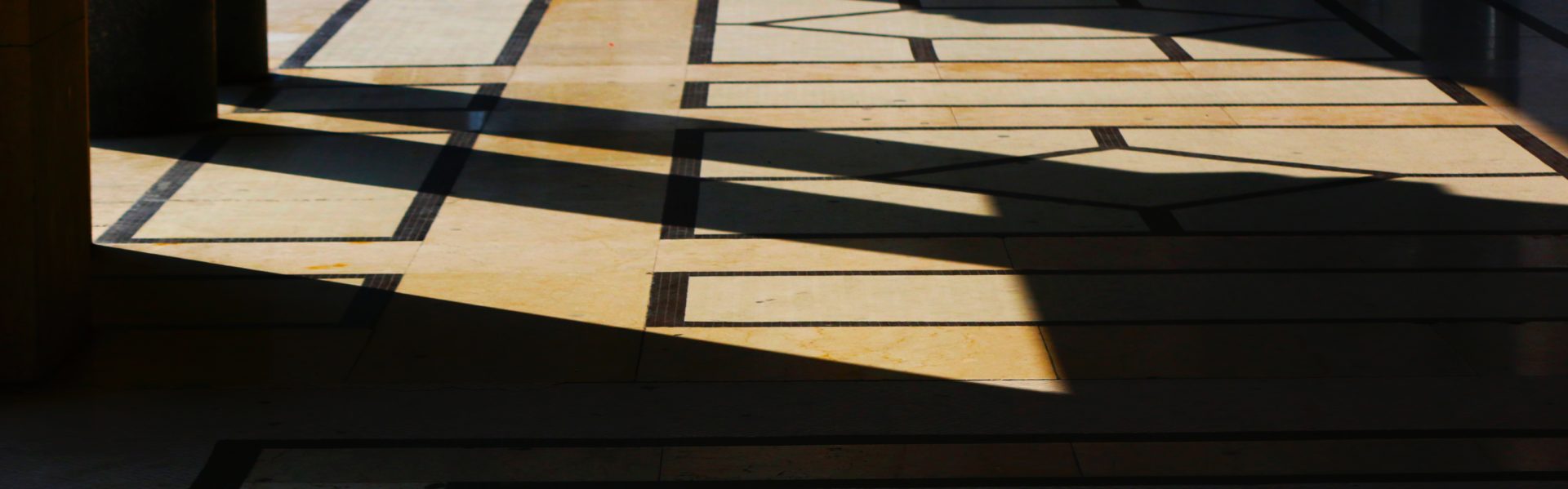La sinergia tra Il vizio dell’esistenza e Academia Peregrini ha dato i suoi frutti: sono stati individuati i vincitori della quindicesima edizione del premio letterario “Il Viandante“, dedicato alla scrittura di viaggio. Si tratta di Enrico Sala per la sezione poesia, con “Le mie scarpe”, un componimento di grande densità meditativa, e Roberto Bosio per la sezione narrativa, con “Sulle sponde del fiume Don”, un gelido salto indietro nel tempo alla campagna di Russia della Seconda Guerra Mondiale. Di seguito, i testi.
Le mie scarpe
di Enrico Sala
Inzuppate
di tempo sprecato
nel fango dei giorni
pesano
le mie scarpe
ed è lento
il passo
sul sentiero del presente
dove corre veloce
la nostalgia del futuro.
–
Sulle sponde del fiume Don
di Roberto Bosio
“Anima mia, sii brava
e va’ in cerca di lei.
Tu sola sai cosa darei
se la incontrassi per strada”
(Giorgio Caproni)
Sono ormai settimane che Boris non si fa vedere.
Le storie sul suo conto sono le più disparate, ma in qualche modo sono diventate il collante capace di unirci in questi lunghi giorni di attesa.
Nel campo non si parla d’altro: c’è chi dice che è stato catturato dai Russi, chi dice che è scappato oltre confine, per altri invece è semplicemente passato a miglior vita e ora ci guarda da lassù, con un ghigno di soddisfazione, mentre noi arranchiamo sulle rive del Don.
Ma io credo che il piccolo venditore ambulante sia troppo furbo per farsi catturare, troppo scaltro per morire su questa terra che conosce come il palmo della sua mano. No, la mia visione è differente, e così me lo immagino da tutt’altra parte, nascosto in qualche isba abbandonata, mentre trascorre le sue giornate davanti a un fuoco acceso, magari sorseggiando un brodo caldo e leggendo qualche pagina di Tolstoj o Pasternak.
Questa possibilità è diventata in breve tempo più o meno la versione ufficiale del destino del piccolo Boris, forse perché nasconde la speranza di rivederlo, forse perché diversa dalla solita alzata di spalle.
Chissà… come continua a ripetermi Luigi, ogni cosa ha il suo tempo. Non possiamo fare altro che aspettare e guardare la linea dell’orizzonte e sperare di vederlo spuntare come un’ombra scura sulla neve fresca, trascinare il suo carretto, carico di merce, notizie e speranza.
Ma è proprio la pazienza che ci manca. Questa attesa, le lunghe marce, sono un logorio mentale ancor prima che fisico. Siamo lontani da casa migliaia di chilometri, siamo armati fino ai denti: fucile, pugnale e granata. Ma quello che ci manca è proprio la pazienza e anche la certezza di ritrovarsi a mercanteggiare con un venditore ambulante, per molti, è un vuoto da colmare.
E poi c’è la neve. Così bella e così fatale.
L’inverno da queste parti pare sia arrivato con largo anticipo. Ha cominciato a fare freddo a fine settembre e ogni giorno il termometro batte il record di quello precedente: quello che i miei occhi vedono è un panorama monotono e piatto, ricoperto da uno spesso strato di coltre bianca.
Ricordo di tanto in tanto la neve di casa, quella che tra dicembre e gennaio ricopre i nostri campi trasformando la campagna in un paesaggio fiabesco, ma quaggiù, dove le più minuscole gobbe del terreno sono chiamate già colline, di dolce non c’è nulla. Tutto sembra addormentato, in letargo, come se quello che stiamo guardando fosse solo un inganno, l’inganno della Natura. È lei che comanda in questo mondo e Boris lo sa benissimo. Ecco perché me lo immagino furbescamente rintanato da qualche parte. Anche il nemico la teme e, seguendo l’esempio del piccolo venditore ambulante, si nasconde chissà dove, silenzioso e vigile, come un predatore pronto a colpire. Siamo arrivati a temere più l’inverno che il nemico russo. L’invasione del primo è già cominciata e avanza inesorabile: lo intuisco dai cespugli cristallizzati dal gelo, dal fumo ghiacciato che esce dalle bocche, dalle mani spellate dalle basse temperature.
E di notte è ancora peggio. La scorsa siamo arrivati a meno venti e durante la ronda notturna lungo il fiume ormai ghiacciato mi sono pisciato addosso. Non ce l’ho fatta a calarmi le braghe, avevo le mani talmente gelide da non riuscire ad armeggiare coi pantaloni e così, come un bambino, ho liberato l’urina calda lungo le gambe.
Le prime gelate sono comparse ad ottobre, il fiume a novembre era già parzialmente congelato e noi, equipaggiati per una scampagnata autunnale fra i boschi, sfioriamo il ridicolo. Dicono che gli alpini, accampati più a nord, siano più attrezzati, ma lo sono anche i crucchi: in fondo per loro è il secondo inverno trascorso in Russia e quaggiù l’esperienza vale quanto un buon fucile.
L’altro giorno abbiamo incrociato una camionetta tedesca: i soldati avevano uniformi bianche perfettamente mimetizzate in questo paesaggio innevato, copricapi e guanti imbottiti e sicuramente scarponi chiodati. Ci hanno deriso come sono soliti fare: “mamma… spaghetti…”. Sanno dove colpire. Mamma e spaghetti. Dio solo sa quanto mi mancano.
La notizia che Boris sta arrivando ha fatto rapidamente il giro del campo.
Chissà, forse è stato via così tanto tempo per recuperare quanto più cibo e fumo potesse trasportare. Ma quando da lontano lo vedo arrancare sulla neve fresca, trascinando con enorme fatica il suo carretto pressoché vuoto, capisco che i giorni davvero difficili devono ancora arrivare.
Luigi riesce a recuperare un poco di fumo, Oliviero riesce a barattare un paio di grossi guanti di lana bucati con uno dei suoi disegni. Gliel’ho visto fare qualche giorno fa. Lo schizzo del mulino di Filorovo come lo vediamo in questi giorni, con le pale quasi piegate dal peso della neve. Boris ha la faccia di uno che ha fiutato l’affare. Forse con quel disegno andrà in una grande città, magari a Mosca o a Kiev, e lo venderà a qualche nobile di passeggio lungo una vie elegante. Eppure, nonostante il suo abile modo di mercanteggiare, Boris nasconde un animo sensibile. In particolare ha una predilezione per le immaginette dei nostri santi, che tanto, dice, gli ricordano le icone religiose della sua Russia… e quando dice Russia ne parla come di qualcosa che non c’è più.
“Due patate e un cavolo per quell’immaginetta che tieni nascosta in tasca, tutti i soldati italiani ne hanno una…”, mi ha detto una volta col suo italiano sorprendentemente corretto, ma io ho scosso il capo e ho messo una mano a protezione della Madonna, rifiutando quel baratto che a detta sua sarei stato un pazzo a non accettare. In realtà aveva già fatto incetta di immaginette e carte votive: la maggior parte dei soldati barattava volentieri un po’ di fede con qualche bottiglia di vodka e con della machorska.
Aspetto paziente che le compravendite si esauriscano e, mentre gli ultimi compagni si allontanano fumando qualcosa, mi avvicino a Boris, chino su se stesso, intento a sistemare i suoi guadagni.
Prima di rivolgergli la parola osservo il suo carretto: quel poco che aveva è stato rimpiazzato da collane e anelli, qualche moneta, cartoline religiose e un crocifisso, che vedo spuntare in mezzo alle cianfrusaglie come un trofeo.
“Hai fatto buoni affari quest’oggi?”, gli dico sorprendendolo alle spalle.
Lui si volta e mi sorride. Gli mancano un paio di denti e quelli che gli restano sono marci. I segni del freddo pungente sono evidenti sulla pelle del viso arrossata dal gelo e sulle labbra screpolate e sanguinolente. È vestito di stracci, un’accozzaglia di colori e tessuti diversi, indossati senza criterio, con il solo scopo di proteggersi dal freddo, ma sono talmente tanti da regalargli una stazza ben più grande di quella che il suo volto scarno ed emaciato suggerisce.
“Sono tempi duri”, risponde, come se gli avessi chiesto che tempo fa, “Se vuoi ti do questo cappello che indosso per il tuo santo… farà molto freddo quest’inverno, ti può essere utile”.
Gli ricordo ancora una volta che da certe cose non bisognerebbe mai separarsi e poi quell’immaginetta mi aveva già salvato una volta la vita. Forse mi avrebbe protetto più di quanto il cappello avrebbe fatto col freddo.
Mi appoggio al carretto e aspetto pazientemente che sistemi le sue cose. Ormai avevo smesso di credere alla buona sorte, ma quel piccolo venditore era la mia unica speranza. Forse la sua vecchia Russia era un paese diverso e i miracoli accadevano ancora.
Siamo soli, i miei compagni sono tornati al campo, altri si avviano in trincea, attorno a noi c’è la distesa sterminata della steppa innevata, alle mie spalle la città delle talpe e poi il fiume ghiacciato.
Boris ha legato con alcune cinghie il suo bottino e ora mi sta fissando. C’è curiosità nel suo sguardo. Chissà cosa pensa. Una luce brilla nei suoi occhi grigi, forse è convinto di strappare un ultimo affare. Restiamo sospesi per qualche istante fra la mia esitazione e la sua curiosità. Il silenzio alimenta il mio coraggio, e così mi convinco che è arrivato il momento di rivelare le mie intenzioni, senza temere scherno o rifiuto.
Faccio un gran respiro: “Mi rendo conto che la steppa è così vasta, ma c’è una giovane ragazza, probabilmente russa come te, che ha prestato soccorso in questo stesso campo dopo l’attacco di settembre e…” gli domando tutto d’un fiato, rendendomi subito conto dell’assurdità delle parole che ho appena pronunciato. Ma Boris mi interrompe: “Non è così vasta come tu puoi pensare… vai avanti”, risponde seriamente, accompagnando le sue parole con un invito della mano a proseguire. Ho un sussulto, il cuore accelera di colpo e io mi aggrappo alle sue parole come il più disperato dei naufraghi.
“Non conosco nulla di lei”, mi affretto a precisare, “nemmeno il nome. Per quanto ne so può vivere di là del fiume, nel folto del bosco di Starovo, oppure in qualche isba abbandonata… ogni tanto dubito persino che esista, di lei non ho altro che un breve ricordo impresso nella mente: i suoi occhi verdi, le lentiggini che le attraversano il volto e la sua mano tesa sulla mia, che m’invita ad alzarmi. Questo ricordo di lei… forse non era nemmeno una donna, forse era una visione, forse un angelo”.
Una smorfia sale ad increspargli il volto. Guarda il cielo, alcuni fiocchi cadono sul suo volto prima di scomparire, poi il suo sguardo si ferma sul mio e la sua mano si posa sulla mia spalla, in un atto che trasuda amicizia e complicità.
“Anna”, mi rivela, “Si chiama Anna, Anna di Staraya, un tempo viveva là, prima della guerra”.
Siamo in trincea. Le voci di un attacco russo si rincorrono ormai da giorni, movimenti di truppe e carri sovietici sono percepibili anche a distanza. Non li vediamo, ma l’idea che si stia radunando un grosso assembramento di uomini e materiali tra il fiume e la collinetta 220 è condivisa da molti. Il rumore dei cingolati nemici sul fiume ghiacciato ne è la conferma. È un verso, quello del Don, che pare il lamento di un mostro acquatico imprigionato nelle sue stesse acque, insofferente all’acciaio dell’uomo.
Un pallido sole ci regala una piccola tregua dal gelo infinito. Alla mia destra il profilo di Franco, intento come me a scrutare l’orizzonte, rilascia calore come una stufa accesa, il fumo che si leva dal suo corpo è impalpabile, ma visibile, e leggero si disperde nell’aria.
Ogni tanto sbuffa, più spesso tossisce. Dalla bocca, come dal naso, esce altra condensa, ma a differenza di altri, il gigante di Corbetta sembra aver fatto scorta di grasso per l’inverno. Sembra sempre più ingombrante o forse siamo noi, divorati dal gelo e dalla fame, a farci più piccoli.
Anche Luigi è accanto a me e cerca di farsi più vicino: siamo tutti stretti in una sorta di abbraccio collettivo, nel vano tentativo di scambiarci un poco di calore corporeo.
“Fa un freddo cane!”, sbotta Luigi, e in effetti il gelo di questi giorni è una delle sensazioni più terribili che io abbia mai provato in vita mia. Non esiste un termine che possa descrivere con precisione quello che stiamo patendo, tanto più che l’inverno, quello ufficiale, ancora non è iniziato.
Se il calore non possiamo trovarlo su questa terra ghiacciata, allora lo cerchiamo altrove. Le parole e le verità del Duce, che davano conforto e coraggio, ora sembrano vacillare davanti ai morti, ai giovani mutilati, ai feriti gravi, a uomini che piangono disperati. E quando quelle parole non mi sono più bastaste, ho finito per ripiegare sui ricordi, la mia famiglia, sopratutto mia madre, e sulla speranza, di tornare a casa vivo e di ricominciare tutto da capo. Ma anche questo non è sufficiente, come se la prolungata distanza da casa ne avesse corroso l’immagine, che si disperde insieme al suo valore.
C’è quella ragazza, però, che finalmente ha un nome. È lei che occupa i miei pensieri, è il suo volto che riempie i miei sogni e il desiderio di ritrovarla è quel calore che ancora mi tiene in vita. Guardo Franco e penso a quante volte ha invocato nel sonno e nella veglia il nome della sua Luisa. Ora posso capirlo. Dannato cuore, capace di oscurare tutto il resto. Mi chiedo come tu ci sia riuscito, così velocemente e senza che niente ci sia stato tra me e lei, salvo quel breve istante, sul campo insanguinato, quando i nostri sguardi si sono incrociati.
Il volto di Anna non mi ha più abbandonato. Sono sufficienti alcuni rametti sulla neve fresca o i profili delle nuvole in cielo perché io possa riconoscervi i suoi lineamenti. Durante il giorno la sua impronta lieve è un sottofondo continuo e costante, ma è paradossalmente di notte che assume i contorni della realtà. Chiudo gli occhi e tutto diventa vero. La mente annulla le distanze e io rischio di sprofondare in un limbo dal quale non vorrei mai uscire. La rincorro di giorno e la ritrovo di notte. Ho cominciato a vivere due vite, quella di soldato e quella di uomo che chiude gli occhi e corre libero e scalzo, sotto un sole caldo, lungo le rive del Don. Nell’aria che profuma di primavera volano farfalle e libellule e la gente è tornata a casa. Le facciate delle isbe rosse e verdi sono state rimesse a nuovo e il suono della balalaika è tornato ad allietare le steppe. Io corro e corro e poi finalmente la vedo, dall’altra parte del fiume, sciogliere e ravvivare al sole i suoi capelli biondi. La chiamo a gran voce, il suo nome echeggia nella valle del Don e lei sorride, ma le sue labbra restano serrate. Non conosce il mio nome, ma io non so fare altro che gridare il suo. Il fiume è gonfio e carico d’acqua come non mai, ma non ci sono ponti o guadi che mi permettano di attraversarlo. Ci sono solo le note zingare della balalaika che giungono da lontano e ricordano una vecchia canzone russa che qualcuno, una sera, ha cantato attorno al fuoco del vecchio mulino di Filorovo.
Quando riceviamo l’ordine di ritirarci sto ancora armeggiando col mio fucile inceppato, ma una deflagrazione a non più di dieci metri mi scaraventa a terra. Il boato precede di poco lo spostamento d’aria, come uno schiaffo, poi una colonna di fumo, di terra e di neve mi ricopre quasi per intero. Striscio come un serpente, cieco e senza una meta.
“Franco, Oliviero, Luigi!” Chiamo i miei compagni, ma l’inferno di fuoco che ci sta vomitando addosso il nemico non ha pause e sopra le nostre teste cominciano a volare gli stukas russi bombardando l’intero campo. Non c’è più ordine, solo panico e urla strazianti. Vorrei scavarmi una buca, sprofondare sotto terra, scomparire come fanno le talpe quando sono minacciate e riemergere da un’altra parte, ma il mio destino sembra molto più tragico: diventerò humus, concime per questa terra arida e fredda, rinascerò forse un giorno, come un cespuglio spinoso e abiterò per sempre le sponde di questo fiume.
Qualcosa mi colpisce, un dolore che è come una scossa mi fa urlare. Guardo il mio braccio sanguinare: una scheggia spunta dalla spalla, come una spada conficcata. È l’ultima cosa che vedrò di questo mondo? Qualcuno mi afferra il braccio sano e mi aiuta ad alzarmi.
“Forza Mario!”, riconosco la voce di Franco, ma sono esausto. Vedo l’orizzonte sfuocato e le mani di Oliviero e Luigi che ci invitano a fare alla svelta. Sembra che tutto si muova a una velocità ridotta, solo le bombe cadono senza sosta come se andassero a velocità doppia. Scivolo via dalla presa di Franco e gli dico “Vai, amico, vai…”.
“Forza Mario!”, urla ancora Franco, “Ricordi il nostro patto? Non ti lasceremo qui!”.
Mi rialzo a fatica e mi appoggio al suo fianco. Piegati, come se questo fosse sufficiente a proteggerci, seguiamo Oliviero e Luigi, sfidando la sorte. Riesco a voltarmi indietro. Non è vero che la neve non brucia. Fuoco e fiamme si levano dal suo manto candido mentre i corazzati sovietici e le truppe nemiche calano dalla collinetta 220 come un’armata invincibile. È allora che vedo in mezzo al campo Marco e Lorenzo, i due ragazzi di Torino, avvinghiati al loro mortaio. Attorno a loro piovono bombe e razzi e i proiettili fendono l’aria come schegge impazzite. Sono loro l’ultimo baluardo, due semplici soldati con un mortaio. Sono certo che si faranno esplodere piuttosto che consegnarlo al nemico e non ho bisogno di una conferma quando l’ennesima bomba li colpisce in pieno.
Cerchiamo di correre più velocemente, dobbiamo attraversare il piccolo villaggio di Filorovo e da lì ritrovare il resto del battaglione. Ma la katiuscia ha sparato la sua sequenza infinita di colpi, ci sorvolano come cani lanciati in una battuta di caccia e colpiscono il terreno di poco davanti a noi.
Si apre una voragine, il fumo e la neve vaporizzata ci fanno quasi soffocare. Cerchiamo di spostarci lateralmente alla ricerca di altri varchi, ma la visibilità è così ridotta che non sappiamo dove stiamo andando. Calpestiamo cadaveri, poi sentiamo le voci dei russi e capiamo che stiamo tornando indietro, verso una morte certa. Guardo il cielo grigio: lentamente cominciano a cadere i primi fiocchi, ben presto saremo morti e ricoperti di neve, come ferite aperte nella terra.
“Di qua…”, Oliviero sembra aver trovato un varco, attraverso un gruppo di alberi rimasto miracolosamente in piedi. Ci rifugiamo per qualche istante fra betulle e larici e ci guardiamo in faccia l’uno con l’altro. Siamo intrappolati, è solo questione di tempo, i soldati russi ci troveranno e poi tutto sarà finito.
Siamo esausti e terrorizzati, ma non c’è tempo per fermarsi a riposare: gli alberi verranno abbattuti rapidamente e noi moriremo nel modo più stupido, schiacciati dalla neve e dal legno.
Oliviero si avvicina e mi tranquillizza, Franco e Luigi mi reggono con forza e Oliviero si piega sopra di me afferrando la scheggia conficcata nella spalla: “Farà male amico mio…”. Io lo prego di aspettare ancora un istante.
Giro il capo altrove. Sento l’acqua scorrere. Il Don non deve essere lontano. Il fiume, rotto in più punti, sembra ribellarsi alla furia omicida dell’uomo. Chiudo gli occhi e il silenzio per un attimo mi coglie impreparato, mentre la mente lentamente riporta a galla immagini confuse di luoghi e persone. Ci sono tutti ora, sotto il grande pergolato: mia madre, mio padre, i miei fratelli, ci sono Franco e Luigi vestiti da contadini e poi, in fondo al cortile, tra le trame spinose di roseto bianco, intravedo lei, col suo vestito rosso e verde, che in silenzio, con un semplice gesto della mano, mi invita a raggiungerla. Il profumo del mosto selvatico e l’operosità delle api attorno agli acini maturi sembrano appartenere ad un altro mondo. Lentamente mi avvicino ad Anna, ma non la raggiungo mai. Il suo profilo sfuma come vapore e il volto dei miei amici chini si sostituisce al suo, insieme al fragore delle bombe e dell’avanzata nemica. Li guardo. Sporchi e stanchi, feriti e spaventati: sono lo specchio della mia anima.
Con un cenno del capo dico ad Oliviero che sono pronto. Stringe la scheggia sul mio braccio e una fitta come un lampo mi fa trasalire, poi tutto comincia a ruotare vorticosamente. Sto per vomitare, poi cala l’oscurità e un buio assoluto mi trascina in un sonno senza sogni.
Quando riapro gli occhi, la luce intermittente di un neon appeso al soffitto quasi mi acceca. Cerco di guardami attorno, ma ogni piccolo movimento, anche quello oculare, mi costa un’enorme fatica. Mi affido allora agli altri sensi. Percepisco un forte odore di etere, lo sferragliare di strumenti e carrelli, ma sono i lamenti che mi fanno rabbrividire. Faccio un’ulteriore sforzo. Riesco appena a muovere le punte dei piedi e delle mani, ma il resto del mio corpo è come intorpidito e la mente è annebbiata. Ricordi confusi degli ultimi giorni si confondono con altri più lontani, si intrecciano con sogni e incubi. Mi ritrovo sospeso in un limbo senza nome e senza tempo e la possibilità che io possa essere già morto mi lacera come un coltello affilato. Ricordo confusamente un viaggio in treno, un vecchio ospedale russo, alcune donne con in mano un secchio d’acqua bollente, il mio corpo nudo e umiliato dal freddo, un rasoio affilato sul mio volto e due piedi gonfi come se stessero per scoppiare, ma per quanto mi sforzi sono pensieri che non riesco a riordinare.
Chiudo gli occhi, forse il sonno è la salvezza o più semplicemente il mio destino. Poi sento il suo nome. Chiamato a gran voce, urlato. Il rumore di passi affrettati sul pavimento, la concitazione frenetica di uno scambio di opinioni e infine un’ombra gentile china su di me, come un angelo. Resto in silenzio, mentre la mia anima comincia a vedere. Cerco di pronunciare il suo nome e la risposta è una carezza leggera sul mio volto. Ci siamo ritrovati, Anna. Mi piace pensare che sia così. Le nostre anime hanno finito di rincorrersi per ritrovarsi nel loro nascondiglio segreto. Ognuno ha un percorso, il mio portava dritto a te. Mio padre si sbagliava, tutti sbagliavano. Quante volte mi è stato detto che il mio compito era quello di combattere per la patria, di servire il paese sino alla morte. Ora che sono disteso su questa branda percepisco la sensazione meravigliosa di aver percorso la strada giusta e mi affido al destino.
Un alito caldo soffia sulla mia pelle. È il vento del sud, che nelle lunghe giornate di luglio trasforma la piana attorno al Don in una fornace. Sono seduto sulla veranda di quella che è finalmente casa mia, un vecchio mulino, uno dei pochi rimasti in piedi dopo la guerra, che abbiamo rimesso a nuovo e trasformato in abitazione. Dondolo sulla sedia, che cigola come le ossa malandate di un vecchio, davanti ai miei occhi infiniti campi di grano si confondono con l’orizzonte. Sembra un mare giallo, che il vento increspa. Qua e là spuntano alcune figure: riesco a riconoscere Franco intento a mietere il grano, poco più in là Oliviero, col suo cavalletto, rapito dal paesaggio, mentre alcune ragazze, sedute ai piedi di un pioppo, parlano del più e del meno, sotto un’illusoria nevicata di pollini.
Ripenso alla guerra come qualcosa di lontano, come se il sangue versato su questa terra fosse solo un brutto sogno. In fondo la terra ne ha cancellato ogni prova. Dove sono le ferite? Dove sono le voragini aperte, le case diroccate, gli alberi divelti? Tutto è stato ricoperto dal grano e dove la spiga non è arrivata, l’uomo, come un sarto accorto, ha pensato a ricucire gli strappi.
Amo questi momenti di quiete: non c’è nulla che stoni, tutto è esattamente dove deve essere. Il rintocco di un campanile lontano non è un disturbo, ma mi ricorda che c’è ancora molto lavoro da fare. Dobbiamo sistemare il fienile e dare da mangiare alle bestie.
Anna mi raggiunge in veranda. Ha le mani sporche di rosso, nel grembiule raccolto scorgo more e ciliegie. Dietro di lei il piccolo Nikolaj non sta fermo un attimo, mi corre incontro e quasi mi fa cadere dalla sedia: “Papà!”.
“Vai a lavarti le mani, subito!”. Scappa come un lampo chissà dove, lasciando un’impronta rossa sul muro di casa.
Anna è sulla porta e sembra intuire i miei pensieri: “Daremo da mangiare alle oche più tardi”. Una sorriso lieve, che è come un richiamo, illumina il suo volto: scende i gradini della veranda con una grazia tutta femminile, io mi alzo e la seguo.
Dietro casa, l’ombra del mulino si allunga su un piccolo sentiero che si insinua fra le spighe mature. Poco dopo, una piccola salita segna l’inizio di una modesta collina. Veniamo spesso quassù, è il nostro rifugio.
Le voci degli amici sono lontane, il profilo della fattoria sfuma alle nostre spalle e al soffio del vento va sostituendosi la corrente placida del fiume, che scorre al di là della collina.
Il Tanai non ha mai smesso di scorrere. Il nome antico ha un fascino che l’attuale Don non possiede. Nelle sue acque si sono specchiati gli Sciti e gli antichi popoli delle steppe. I greci vi hanno pescato e hanno utilizzato il suo corso come linea di confine.
Il sentiero è così stretto che non ci è possibile camminare affiancati. Anna mi precede di qualche passo, allungo la mano sfiorando la sua. Poco prima di arrivare in cima l’erba si fa più alta e il cammino più arduo. Anna si ferma e cerca il mio sguardo. Lo fa ogni volta. Sento la sua mano stringere la mia e gli occhi inumidirsi. Oltre le sue spalle scorgo già le prime croci. I loro nomi incisi sul legno li conosco a memoria: Franco, Luigi, Oliviero… ci sono tutti.
Giunti in vetta, la collina si apre. Anna è di fianco a me e insieme osserviamo stregati il panorama. Le ultime due croci, svettano solitarie sulla cima. Non abbiamo bisogno di rileggere i nomi, lo abbiamo già fatto un milione di volte.
Sulla collina il vento ha smesso di soffiare. C’è solo il fiume che scorre sotto di noi, lento ma inesorabile, come ha sempre fatto.