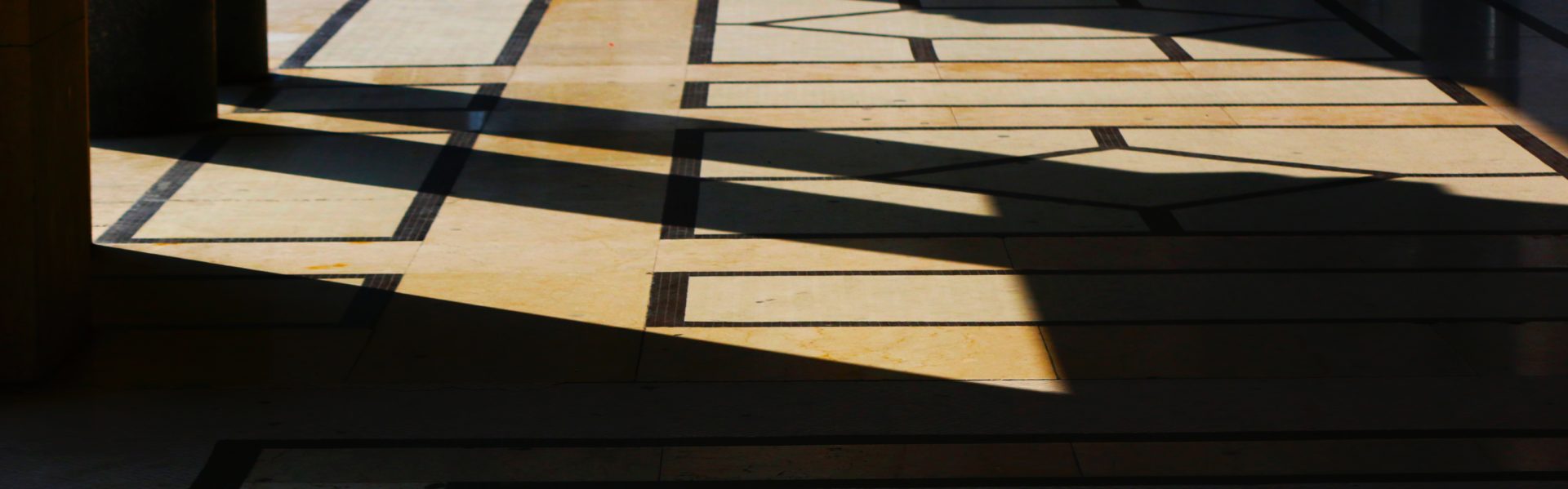Ragazzi di zinco di Svetlana Aleksievič – giornalista e scrittrice bielorussa di lingua russa e vincitrice del Nobel per la letteratura nel 2015 – esce a Minsk nel 2002 ed è pubblicato in Italia nella traduzione di Sergio Rapetti da E/O Edizioni, la prima volta nel 2015 e la seconda nell’ottobre dell’anno scorso.
Dopo aver raccontato la Seconda guerra mondiale dalla prospettiva delle donne sovietiche e dei bambini bielorussi, rispettivamente in La guerra non ha un volto di donna e Gli ultimi testimoni, Aleksievič si dedica questa volta alla guerra russo-afghana che, tra il 1979 e il 1989, vide contrapposti la Repubblica Democratica dell’Afghanistan sostenuta dai sovietici e i guerriglieri afghani – noti come mujaheddin – appoggiati da varie nazioni estere, tra cui gli Stati Uniti. Ma non bisogna necessariamente interessarsi a questo triste capitolo di storia contemporanea per apprezzare Ragazzi di zinco. L’opera merita la lettura, ancor prima che per il suo valore documentario, perché permette al lettore di immergersi nella psiche e nei sentimenti più reconditi dell’animo umano, collocando così a pieno titolo Aleksievič nella scia dei più grandi interpreti della letteratura russa.

Tanti sono i modi in cui si potrebbe definire questo libro (inchiesta, reportage, romanzo documentario…), ma forse l’espressione più giusta sarebbe “raccolta di voci”, perché proprio le voci sono da sempre al centro del lavoro di Aleksievič. Il suo discorso del Nobel, ad esempio, si apre con alcuni dei racconti più toccanti delle già citate protagoniste femminili del secondo conflitto mondiale. Voci non di personaggi noti, quindi, ma di persone comuni, di esseri umani travolti dalla storia, le cui vite sarebbero passate inosservate se l’autrice non avesse messo la propria penna al loro servizio.
Si intravede qui l’ombra di un altro scrittore di lingua russa: il premio Nobel per la letteratura Aleksandr Solženicyn, che nel suo Arcipelago Gulag aveva delineato, attraverso le numerose testimonianze di chi, come lui, lo aveva vissuto sulla propria pelle, l’atrocità del sistema concentrazionario sovietico.
A parlare, in Ragazzi di zinco, sono figure molto diverse fra loro, ma accomunate da un’unica tragedia: un conflitto che in dieci anni ha visto la mobilitazione di un milione di ragazzi e ragazze sovietici, tra cui almeno quindicimila i caduti e cinquantamila i feriti, e la morte di mezzo milione di afghani.
Incontriamo, innanzitutto, i soldati, quasi tutti giovanissimi. Alcuni sono ragazzi di leva costretti a partire per l’Afghanistan, a volte senza neanche conoscere fino all’ultimo la propria vera destinazione. Destinazione sulla quale mentono poi ai familiari per tranquillizzarli: chi dice di essere in Mongolia, chi racconta che l’Afghanistan è un paese bellissimo perché ci sono le montagne, chi descrive il fronte come una sorta di villeggiatura… Tanti sono i volontari, arruolatisi perché ingannati dalla menzogna della “grande causa internazionalista e patriottica”, con cui lo stato faceva loro credere che avrebbero portato pace a un popolo alleato e sarebbero poi stati celebrati come eroi in patria.
Era ancora fresco, infatti, il ricordo della Seconda guerra mondiale – che in URSS prende il nome di “Grande guerra patriottica” – durante la quale ogni famiglia aveva subito perdite e in cui tutti avevano fatto la propria parte nell’eroica resistenza contro il nemico nazista. Il desiderio è quello di emulare i propri padri, ma questa volta, come non mancano di sottolineare alcune delle voci di Aleksievič, il popolo sovietico non è più invaso ma invasore. Per evitare polemiche, le notizie sul conflitto afghano nei media sovietici sono esigue ed edulcorate, i numeri falsati e i caduti vengono seppelliti di nascosto. Mentre le autorità li descrivono come l’esercito più potente e all’avanguardia al mondo, i cosiddetti afgancy – i soldati sovietici che si battono sul fronte afghano – scoprono di avere un equipaggiamento inadeguato, scorte alimentari insufficienti e condizioni igienico-sanitarie pessime. Tra di loro c’è chi si droga per sopportare la fatica e l’orrore; chi, dopo aver visto un compagno fatto letteralmente a pezzi dai mujaheddin, inizia a sparare a qualsiasi cosa si muova; chi scopre un gusto perverso nell’uccidere altri esseri umani.
Tanti rimarranno orrendamente mutilati, senza più né braccia né gambe, e saranno costretti, una volta tornati in URSS, a una non-esistenza peggiore della morte, abbandonati a se stessi in strutture create appositamente per loro, nascosti agli occhi dell’opinione pubblica. Ma anche chi tornerà integro fisicamente non lo sarà più in senso psicologico e morale, scoprendo così di non poter più, in ogni caso, condurre una vita normale.
In questa terribile sorte degli afgancy riecheggiano le parole di Varlam Šalamov, altro scrittore russo deportato in Gulag, che ne I Racconti di Kolyma scriveva che nessuno sopravvive al lager. Si nota quindi ancora come la guerra russo-afgana e il sistema concentrazionario sovietico siano entrambi espressione di una macchina-stato che tritura carne umana per garantire il funzionamento dei propri ingranaggi.
Ecco quindi che gli afgancy considerano la loro vecchia vita troppo banale, non riescono a trovare un posto in una società che, lungi dal celebrarli per il sacrificio compiuto, li ostracizza. L’Afghanistan è infatti ormai ritenuto un errore politico, un Vietnam sovietico da nascondere, i cui veterani tornati in patria faticano a instaurare rapporti umani perché si sentono incompresi.
Viene qui in mente il medesimo destino in cui erano incappati, qualche decennio prima, migliaia di giovani europei reduci della Prima guerra mondiale. Le loro condizioni sono ben rappresentate dal celeberrimo esempio letterario del Septimus di Virginia Woolf, che in Mrs Dalloway, pur nella civilissima e vittoriosa Inghilterra dei primi anni Venti, si suicida perché incapace di continuare a vivere dopo i traumi psicologici subiti nelle trincee e l’indifferenza incontrata al ritorno in patria.
Lo stesso prezzo è pagato da tante ragazze che, volontariamente o costrette dai propri superiori, sono andate al fronte per lavorare come infermiere o impiegate, per poi essere costrette a subire ricatti a sfondo sessuale ed essere considerate in patria alla stregua di prostitute, pur avendo salvato tante vite e corso gli stessi pericoli degli uomini.
Una voce femminile molto forte in Ragazzi di zinco è poi anche quella delle madri e delle mogli dei caduti, che si vedono recapitare i propri figli, figlie e mariti dentro a bare di zinco sigillate (da cui il titolo del romanzo) e sono costrette a seppellirli senza poterli vedere un’ultima volta – anche perché spesso di loro resta ben poco –, ma soprattutto senza trovare una ragione per la loro morte. Straziante comune denominatore dei loro racconti è il ricordo di tutti i sacrifici fatti per i propri figli – in un paese che dalla Seconda guerra mondiale era uscito vincitore ma che aveva pagato un prezzo altissimo sia in termini economici che di vite umane –, soltanto per vederseli poi strappati via e trattati alla stregua di carne da macello dallo stato. Stato in cui loro avevano riposto una fede cieca, che avevano creduto il migliore del mondo, inculcando nelle teste dei propri figli come non ci fosse gioia più grande che mettere la propria vita al suo servizio. Stato che, invece, le ha tradite, ingannate e poi lasciate sole col loro dolore. A volte il sacrificio dei figli viene “ripagato” con una casa statale in centro, a volte nemmeno, perché non ce ne sono abbastanza. Ma del resto a loro non importa, ormai trascorrono le giornate al cimitero, sulle tombe dei figli, a parlare con mute lapidi che invariabilmente recitano: «Caduto adempiendo al proprio dovere internazionalista». Paradossalmente, ma forse neanche tanto, l’unica persona cui una di queste madri si sente vicina è una donna afghana che, alla televisione, piange la morte del proprio figlio.

E la voce di Aleksievič, direte voi? Si fa sentire nelle prime pagine del libro, quando l’autrice ripercorre il suo arrivo in Afghanistan nel settembre del 1988: dinanzi all’esaltazione di un altro scrittore all’idea di vedere il fronte e «magari sparare anche qualche colpo» lei non può fare a meno di pensare che «la guerra sia frutto della natura maschile, la quale resta, per me donna, in gran parte incomprensibile». E si fa sentire di nuovo alla fine del libro, quando scrive quella che sembra un’epigrafe non soltanto per il conflitto russo-afghano, ma anche per la fine di un’era, quella sovietica, che coi suoi miti illusori ha lasciato dietro di sé una scia di cadaveri fin troppo reali:
«La nostra terra, ormai per sempre, è disseminata di queste rosse pietre tombali che perpetuano insieme al ricordo delle anime che non ci sono più anche quello della nostra fede ingenua a fiduciosa».