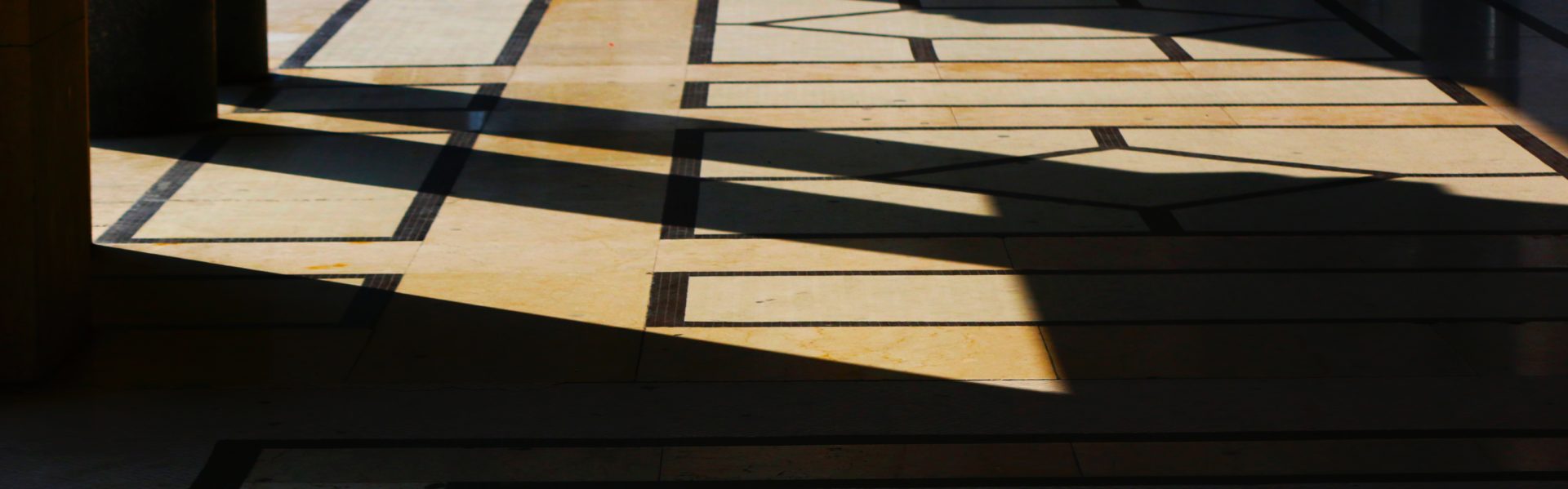Che si sia trattato di un’operazione editoriale di successo quasi assicurato non c’è dubbio, che il linguaggio e i contenuti non siano facilmente digeribili da chiunque si può capire, ma basta questo a rendere un libro indegno di essere scritto e letto? È lecito chiederselo soprattutto se compie un gesto di cui nell’editoria contemporanea si sente sempre più spesso la mancanza, in un’era in cui capita ancora che vengano tolte tele dalle pareti dei musei in nome della pubblica decenza: affronta gli scheletri nell’armadio, scoperchia i tabù. Fuor di metafora, costringe a ragionare su argomenti a proposito dei quali si è taciuto fin troppo a lungo.
Il libro in questione è Bruciare tutto del docente universitario, saggista, critico letterario e infine scrittore (Premio strega 2013 con Resistere non serve a niente) Walter Siti, caso letterario controverso come in Italia non se ne vedevano forse dai tempi di Altri libertini di Tondelli. La trama è molto semplice: Don Leo, prete in una parrocchia milanese, cerca, tra un’opera buona e una canzone di Amy Winehouse, di convivere con la propria attrazione sessuale per i bambini. A non essere semplice è il rapporto di Don Leo con se stesso, con la Chiesa, con la fede, con il mondo. E infatti non solo di pedofilia si tratta, anzi, è un peccato che – l’autore ne era consapevole tanto da anticiparlo nel romanzo stesso – la critica abbia bruciato «un lavoro molteplice al fuoco di un unico tema». Quasi letteralmente, c’è da dire.
È vero che il linguaggio e la sintassi artificiali, fatti di metafore ardite e voli pindarici, inserti dall’andamento saggistico e passaggi oscuri, non sono facili da assimilare alla prima lettura. È vero che l’ironia, disincantata e a tratti sarcastica, che pervade le pagine può risultare scostante. È vero che qualche scena pare forzata e che qualche stereotipo, anche anacronistico, ogni tanto fa capolino. È vero che non si tratta di un romanzo perfetto (esiste il romanzo perfetto?), ma non sono di certo stile e struttura ad aver scandalizzato certa critica. Sono tre gli aspetti dirompenti che, fusi insieme, sono parsi intollerabili: l’abuso commesso da un prete su un ragazzino; il fatto che alla cieca condanna del gesto si sia preferita l’analisi delle sue motivazioni e conseguenze e, soprattutto, il fatto che tale analisi fosse condotta attraverso il punto di vista di chi l’abuso l’ha commesso. Se l’abuso non fosse stato problematizzato nessuno si sarebbe indignato; se ad essere problematizzata fossero stati l’omicidio, il suicidio, il genocidio e così via, nessuno si sarebbe sorpreso; se l’autore non avesse scelto il peccatore stesso come suo portavoce o, meglio, come suo strumento di approfondimento della realtà, il libro sarebbe stato tutt’al più massacrato, ma non rifiutato. La cosa più difficile da accettare è proprio questa: che il “mostro” appartenga alla razza umana, che sia dotato non solo di raziocinio, ma anche di un sincero spirito di carità. È infatti Leo -trentatreenne, curiosamente- ad assumere il ruolo di guida attraverso l’inferno dell’inconscio personale e collettivo contemporaneo, sino alle radici del male, che, attraverso la storia di Andrea, si scopre essere paurosamente prossimo al bene supremo: la grazia, la carità, la salvezza. E Siti, che per la prima volta nella sua produzione non si fa personaggio, si fa a sua volta seguace, riservandosi di intervenire direttamente solo in qualche nota al testo o paragrafo in corsivo. Interviene per rassicurarlo, ma anche per prenderne le distanze: l’ha inventato, ma gli è sfuggito di mano, proprio come dio con gli uomini.
Leo non è solo un prete tormentato, è un lucido analista della malattia della società contemporanea, perché la riconosce ogni giorno nella sua comunità di piccoli peccatori, «uomini e donne sopravvissuti senza troppa difficoltà alla morte di Dio»: Fermo e Adua, Matilde e l’ombra di Sebastiano, Duilio e Federica, Bianca e Adolfo, Roberto ed Emilio, con le loro sofferenze, bugie, meschinità, difficoltà, desideri. Questi ultimi troppo spesso confusi con i bisogni, di affetto soprattutto. È la malattia di chi vuole sradicare tutti i paletti etici (non solo quelli religiosi), ma non sa come sopravvivere al di fuori di essi, che vuole oltrepassare ogni limite ma non è pronta ad assumersi le responsabilità che ciò comporta. Una sofferenza che il milanese medio non vuole ammettere o non ha i mezzi per comprendere, ma che, già insita nell’uomo, nella società senza padri di oggi trova un terreno particolarmente fertile.
«Quando Dio, non riuscendo ad autolimitarsi nel proprio nulla, ha dato luogo al mistero insondabile dell’essere, non ha potuto evitare che si formasse la prima terribile onda del “quasi”: un essere quasi perfetto quanto lui, quasi altrettanto luminoso e potente, è rimbalzato nel vuoto come un’eco del frastuono primigenio. In questa seconda (e quasi immediata) energia-mente si è impiantato il fuoco del “se solo…”: mancava poco, se appena i momenti si fossero invertiti, l’Onnipotente sarei stato io». Dei mancati, tormentati dall’impotenza e dal rimpianto, è così che ci siamo ridotti: a necessitare la guida di un prete pedofilo che non riesce a smettere di credere in dio, proprio come la necessitavano Massimo e Andrea.
Davanti a questa paradossale desolazione, c’è chi reagisce invocando il rogo del libro e la riprovazione del suo autore e chi, invece, sostiene che proprio questo è il compito della letteratura: destabilizzare, obbligare a prendere consapevolezza, soprattuto di ciò che altrimenti passerebbe inosservato. Quel che è certo è che non si può giustificare la propria indignazione puntando il dito contro qualche immagine e parola particolarmente spinte (dopotutto questo non è il momento né il luogo di «cincischiare in malafede con gli eufemismi»), perché equivale a sviare il problema, a chiudere per l’ennesima volta gli occhi davanti alla realtà dei fatti. Era necessario parlare di «shampoo alla fragola, al lampone e al cioccolato»? Forse no, ma di certo era necessario che qualcuno tirasse fuori dalla stanza della vergogna l’argomento, l’unico che viene ancora liquidato tout court come mostruosità disumana e, come tale, semplicemente accantonato. E guai a confondere il tentativo di comprendere la pedofilia con un’apologia della stessa: dare un nome e un’immagine alle cose significa farle proprie non eticamente, ma cognitivamente. Confondere i due piani vuol dire non aver chiari alcuni meccanismi attivi nella letteratura (l’“implied author” e il “second self” di Wayne Booth, per esempio), non aver capito quale sia il ruolo della letteratura nel mondo e nella vita delle persone, ma anche non aver capito come funziona la conoscenza. Il male si rafforza nell’indifferenza e far finta di non vederlo per non doverlo affrontare psicologicamente e moralmente è la forma più meschina di indifferenza. La letteratura, come tutta l’arte, permette di affrontarlo senza scottarsi, di scandagliarlo senza subire traumi.
Le vere domande da porsi infatti sono molto più radicali e investono il significato e il compito dell’arte lato sensu: l’arte può essere giudicata in base alla categoria della moralità? Cosa significa per un’opera essere morale? Esiste un limite oltre il quale è illecito spingersi con la penna o con il pennello? Da cosa dipende questo limite? Contenuto o stile? Se il dibattito non si è ancora esaurito dopo secoli un motivo ci sarà. E questo motivo non è solo che il senso del pudore e la morale cambiano a seconda delle epoche e delle persone – il che renderebbe già impossibile una regolamentazione definitiva -, ma anche che all’arte e all’artista non si può chiedere di dare il buon esempio. O, meglio, non si può chieder loro di dare il buon esempio attraverso l’auto-censura. L’arte non deve essere edificante se per esserlo è costretta a snaturarsi, a tacere sulla realtà: perché non è quello il suo obiettivo. Anzi, il compito dell’arte è di indagare la realtà, personale e collettiva, utilizzando tutti i mezzi di cui può disporre. E uno di questi mezzi è l’impiego del “repellente” (così è stato definito il romanzo di Siti), se è vero che l’insegnamento “morale” dell’arte non passa solo attraverso il bello e buono, ma anche dal suo contrario.
Non regolamentare (gli articoli 527, 528 e 529 del Codice Penale sono tutt’altro che esaustivi) significa tutelare la sacrosanta libertà di (creare, indagare, scandalizzare…) dell’arte e con essa quella di chi la fruisce di interfacciarsi con tutto lo spettro del reale. Il che non significa che tutto è lecito, ma che autore e fruitore sono chiamati ad assumersi le responsabilità che il loro ruolo conferisce. E se nessuno che sia sano di mente crede veramente che quella di Siti sia un’apologia della pedofilia e tanto meno che il lettore prenda Don Leo a modello di vita perché prova un barlume di empatia nei suoi confronti, allora che cosa davvero spaventa di questo libro? Forse il fatto che dimostri chiaramente come sia arrivato il momento, dopo aver bruciato tutto in nome della “libertà da”, di assumerci le responsabilità della ricostruzione.